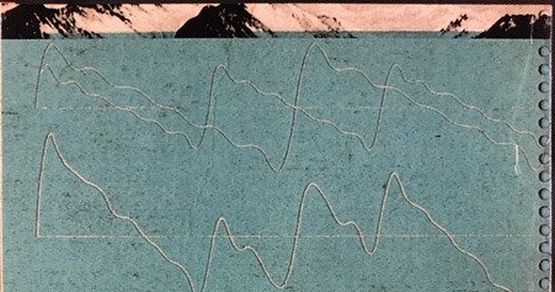I Lemonheads prima di “It’s A Shame About Ray” erano stati poca cosa.
Quattro dischi trascurabili, fama e grande pubblico lontani, un sound troppo legato a quell’hardcore punk portato al successo dai concittadini Husker Du e Replacements.
La storia cambia radicalmente nell’esatto momento in cui Evan Dando, ragazzo insoddisfatto dell’alta borghesia di Boston, decide di trasformare i Lemonheads da anonima band college-rock a fortunato progetto solista.
Quello che accadrà in seguito ad “It’s A Shame About Ray” avrà fatalmente l’effetto di far passare alla storia il biondo front-man come l’icona mancata di una generazione di giovani americani al tempo stesso punk e hippy, ma se accantoniamo anche solo per un attimo le storie di tossicodipendenza, i fidanzamenti illustri e i continui confronti con chi per diversi motivi icona di quei tempi riuscirà ad esserlo veramente (leggasi River Phoenix, Kurt Cobain, Eddie Vedder), ci accorgiamo che Dando prima di tutto questo è stato un ottimo songwriter.
Nel 1992 i Lemonheads da tempo non sono più una band.
Evan ha preso il totale controllo della situazione puntando tutto sul suo inespresso talento.
Le intenzioni sono chiare, questa volta o si combina qualcosa di memorabile, emergendo una volta per tutte dalla scena underground oppure si abbandonano definitivamente i sogni di gloria.
A raccolta vengono chiamati solo persone fidate senza manie di protagonismo, braccia e dita disposte ad assecondarlo in modo incondizionato, l’amica/ex girlfriend Julian Hatfield si accomoda al basso, il fido David Ryan prende in mano le bacchette.
Sarà stata la mancanza di tensioni interne, o più semplicemente la totale libertà concessa al suo principale ed unico protagonista, da quelle sessions uscirà un disco tutt’ora considerato fondamentale nel processo di svezzamento delle successive generazioni indie-rock (mettiamoci dentro anche parte del brit-pop).
La lezione di Ramones e Husker Du rimane imprescindibile nel sound del trio, ma per la prima volta non è più morboso oggetto di adolescenziali giochi di stile, diventa viceversa il punto di partenza di un suono più personale.
“Rockin’ Stroll”, “Confetti”, “Rudderless”, la stessa title-track, in tal senso sono esempi emblematici, hanno una profonda anima punk, ma tengono a freno, quasi soffocano, furia e rabbia giovanile, liberandosi in armonie solari e melodie colorate.
Accanto ad istintivi bozzetti chitarristici trovano poi spazio parentesi come “My Drug Buddy”, “Hannah & Gabi”, “Frank Mills” scarne ballate dal sapore southern-rock (Gram Parsons è un altro idolo dichiarato di Dando) che arricchiscono ulteriormente il lavoro con un tocco malinconico e riflessivo insospettabile se si analizza il cammino dei Lemonheads fino a quel momento.
La perfezione di queste tredici tracce compresse in 30 minuti (altro retaggio punk) trova totale conferma in una maturità di testi che per stesso rammarico delle “teste di limone” da quel momento in poi non concederà repliche.
Se Cobain è stato per quegli anni interprete assoluto del disagio giovanile vissuto nell’estrema provincia americana , con questo disco Dando assume il ruolo di portavoce dei figli della middle-class borghese, suggerendo come soprattutto in quei tempi destini divisi da diversi contesti sociali condividevano identiche esperienze di vita.
La noia era la stessa tanto ad Aberdeen, periferia balorda di Seattle, quanto tra i quartieri residenziali di Boston, la droga, l’isolamento, gli insuccessi sentimentali provocavano la stessa micidiale frustrazione indipendentemente dalle disponibilità economiche o dalle possibili prospettive di vita.
Da qui nascono amare confessioni, parole e testi che in più di un occasione sembrano contrastare con una musica protesa comunque alla ricerca di melodie orecchiabili e accattivanti.
Dopo questo disco, Evan Dando finirà travolto dal suo stesso successo negando di fatto la possibilità ai Lemonheads di essere ricordati come gruppo seminale degli anni ’90 al pari di mostri sacri quali , Pixies, Dinosaur Jr o Pavement .
Le alterne vicende private del suo autore non intaccano però il valore di “It’s A Shame About Ray”, disco fondamentale di quel decennio al pari di capolavori realizzati da band unanimemente riconosciute come padri dell’attuale scena indie-rock stelle e strisce.