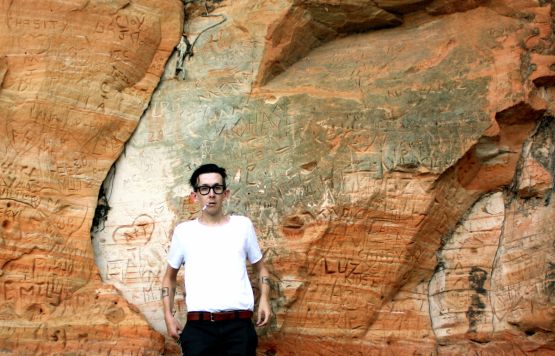Vorrei vivere sulla superficie. Passare sulle cose a volo radente. Vorrei non posarmi su nulla, scivolare come un cormorano tra le spume oceaniche. Non voglio più profondità . Vorrei cogliere il profumo primigenio della terra, goderne per pochi attimi prima di scappare via. Sarebbe grazioso ascoltare musica e rimanere folgorati al primo ascolto, al di là della mode e delle tendenze asfissianti. Oppure girare tra le vie innevate di un carillon, dove tutto è perfetto, colorato ed inesorabilmente nostalgico.
Mi convinco e lo faccio, plano curioso dentro le spire avvolgenti di uno dei più interessanti gruppi americani di questi anni, ben certo che la loro ultima fatica sia una scatoletta smaltata piena di bon-bon succulenti. Dare fiducia è l’unico atto rivoluzionario che ci è rimasto: venirne ripagati è il giusto compenso. I Grizzly Bear non tradiscono le attese e vanno oltre le architetture complesse dei lavori precedenti, approdando sulle rive assolate di un pop nobile ““la travolgente “Two Weeks” si candida ad essere singolo dell’anno -, sporcato da schizzi folk degni della miglior polvere di provincia.
è tutto un gioco di rimandi, di grossi sogni colorati, un amalgama di visi di porcellana che intonano storielle prese in prestito dal candore vocale dei Beach Boys sorpresi in una jam session coi Dodos ed i Beatles. La maniacale cura per i particolari messa da Daniel Rossen e da Ed Drost è stupefacente, un gioco di contrappesi ed arguzie stilistiche pronte a sciogliersi in micidiali ritornelli, che come saliscendi emotivi trasportano in un altrove magico ed incotaminato. La ricercata eleganza che si frammischia con la levità malinconica di un’umbratile mattinata di sole è la medaglia che il quartetto newyorkese si appunta fieramente sul petto.
Un suono nuovo fatto di linee dritte che si spezzano e si ricompongono in continuazione, un folk drogato, iperglicemico, stratiforme, libero da lamenti autoreferenziali, imbevuto di perfezioni sixties corrette col miglior bourbon, sezioni ritmiche rinvigorite da una batteria corposa ed onnipresente ““ e qui un plauso va alla zazzera bionda di Chris Taylor e alle bacchette di Christopher Bear ““, linee vocali sentimentalmente cristalline, misurate, accorate, curate fino allo spasimo, universi capovolti e carezze: tutto questo galleggia nelle 12 tracce di “Veckatimest”, florilegio di gemme sonore inscatolate da questi ragazzi di Brooklyn perdutamente innamorati di atmosfere cariche di sogni à la Tim Burton e di ultimi giri di valzer.
In definitiva i Grizzly Bear potranno piacere oppure no, potranno essere la luce in fondo al tunnel o risultare ahimè una band noiosa, ma in entrambi i casi non si potrà rimanere indifferenti ad un gruppo capace di costruire una musica completamente originale, non derivativa e fuoco acceso nella notte per le generazioni future. Scusate se è poco.