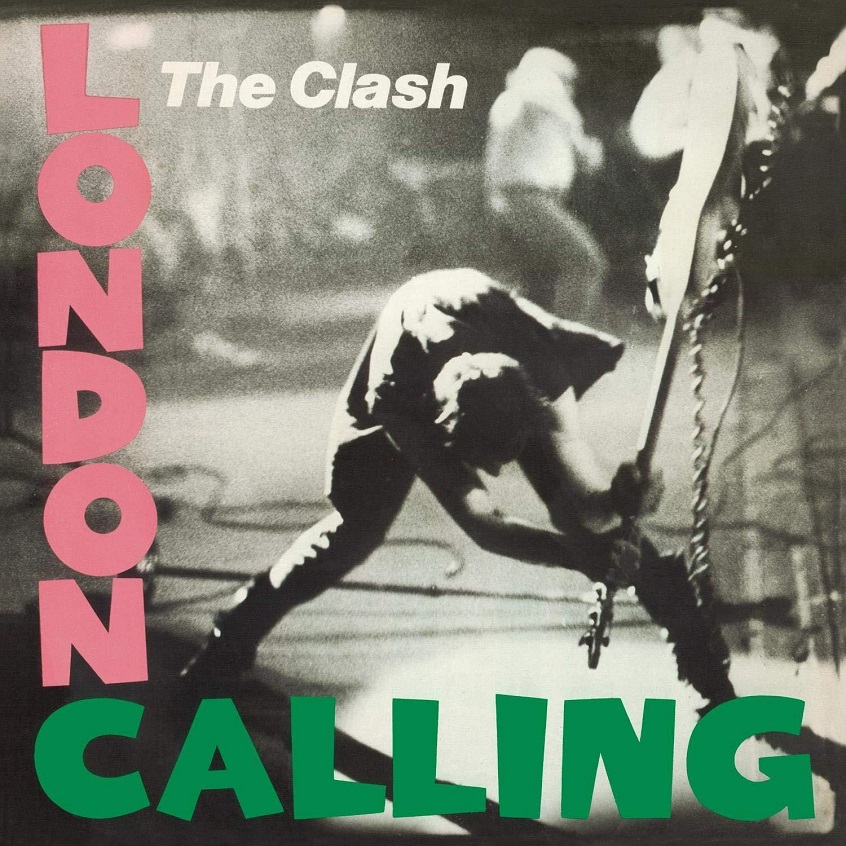Miles Davis è stato e rimane uno dei più grandi ed autentici geni della musica moderna. In perenne ed incessante ricerca tra innovazione e tradizione, si è mosso con slancio ed ha attraversato epoche e stili, fagocitandoli e rendendoli propri, fungendo da catalizzatore, da antenna parabolica verso gli eventi e le suggestioni musicali che lo circondavano, molte volte, anzi quasi sempre, precorrendo i tempi o inventando dal nulla generi e stili musicali ed umani: la scinitilla del Be-Bop con Charlie Parker e Dizzie Gillespie negli anni Quaranta, la breve parentesi del Cool Jazz agli albori dei Cinquanta, Il Jazz Modale e l’Orchestra negli anni Cinquanta, infine l’evoluzione e la trasfigurazione del modale col suo secondo quintetto negli anni Sessanta, poi il periodo elettrico, dalla fine dei Sessanta fino alla sua morte.
Miles è uno sciamano, un Re Mida che trasfigurava in oro tutto quello che toccava, ma è stato anche un tempista, un ladro di idee e composizioni, un vampiro che succhiava le suggestioni e le proposte musicali dei suoi collaboratori, pretendendo spesso di apporre la propria firma su composizioni altrui (cosa che fortunatamente non sempre gli riuscì).
Doppio come il suo segno zodiacale, il Gemelli, Miles era un Giano bifronte che esprimeva allo stesso tempo e con la stessa intensità crudeltà e tenerezza, genio e sregolatezza, carne e spirito, avanguardia e retroguardia. Un uomo impossibile e decisamente trivalente: bambino, adulto e vecchio, tradizionalista, in continua ricerca ed attratto verso il nuovo, sinfonico, acustico ed elettrico, ha vissuto contemporaneamente tra presente, passato e futuro.
La dicitura Directions in music by Miles Davis marchiata a fuoco a mo’ di sottotitolo nei suoi tre dischi più arditi, “Filles de Kilimanjiaro”, “In a Silent Way” e “Bitches Brew”, concepiti e realizzati rispettivamente nel 1968, 1969 e 1970, esprime a chiare lettere la concezione e l’idea che risiede nella sua musica: Processo, nonchè continua ed incessante ricerca unita ad un afflato verso il nuovo, l’ignoto. Ogni volta che Miles Davis sperimentava un’idea o una suggestione musicale era già al passo successivo, alle possibilità di svolta e di sviluppo futuri.
La stagione elettrica qui presa in esame getta i suoi semi e germogli dal 1964 in poi, quando Davis inaugura il suo secondo, formidabile quintetto: Herbie Hancock, Wayne Shorter, Ron Carter e Tony Williams e producendo un denso ed incredibile alveolo di dischi assolutamente fantastici, (“E.S.P.”, “Miles Smiles”, “The Sorcerer”, giusto per citarne tre), dove aveva luogo un fitto gioco di rimandi, call and response tra i musicisti coinvolti, dando vita ad un interplay che si è visto raramente nella storia del jazz. Da qui in avanti, Miles Davis supererà se stesso, abbatterà per sempre gli steccati tra jazz e non jazz, musica còlta e di intrattenimento, dividendo e disorientando ma allo stesso tempo affascinando, critica e pubblico.
Attratto dalla stagione psichedelica e dai musicisti black più mistici e coraggiosi, da James Brown a George Clinton, passando per Sly Stone sino ad arrivare ad Hendrix, Miles seppe ancora una volta rendere proprie tali idee e stimoli, inaugurando una via nuova alla musica, grazie soprattutto a sua moglie Betty Mabry, cantante e musicista black ed amica di Jimi Hendrix e di Sly Stone che presentò al marito, ma anche grazie all’apporto di un musicista straordinario come Joe Zawinul, che portava avanti un’idea di musica pastorale e magnetica, sopesa, prossima al silenzio, che influenzò profondamente tutto il Miles Davis elettrico.
Lo sciamano inseguì, attrasse a sè Jimi Hendrix, fantasticando e progettando un disco con lui, purtroppo mai realizzato per la morte precoce del chitarrista, cercò poi disperatamente di inserire la chitarra nei suoi progetti, cercando di rendere vivo il ricordo Hendrixiano e ci riuscì, seppur con esiti a volte differenti, con il geniale e talentuoso John McLaughlin, che introdusse elementi esoterici ed indiani nella musica di Miles.
Tutto ciò che scaturisce dal 1969 al 1972, che caratterizza il primo periodo elettrico e si estende fino al 1975, prima del ritiro dalle scene di Miles, è assolutamente immagnifico e produce una pletora di dischi magmatici e possenti e non vi si potrebbe rinunciare ad alcuno di essi per nessun motivo al mondo.
Una scelta bisogna però operarla e quindi mi limiterò a suggerirne quattro in studio più un live, tanto per drizzarvi orecchie e pelo, o coniglietti:
“In A Silent Way” del 1969, disco pastorale e magnetico, sospeso, costituito da due sole composizioni: una del leader, “Shhh/Peaceful”, un mantra ipnotico, scandito da due note del basso di Dave Holland e dagli accenti di charleston di Tony Williams ed alcune note sparse della chitarra e delle tastiere (ben tre: un organo e due pianoforti elettrici) mentre la tromba del leader disegna trame sonore affascinanti sul registro medio.
La seconda composizione, di Zawinul, “In a Silent Way” è qui completamente trasfigurata e privata degli accordi principali da Miles Davis, risultando così una meditazione sul tempo e sullo spazio: qui la chitarra di McLaughlin e l’organo di Zawinul ci trasportano in una dimensione parallela, di quiete, una sorta di limbo, ove regna il silenzio e l’armonia. Ma subito la pace si trasforma in frenesia, groove: “It’s About that Time” di Miles, incastonata tra l’inizio e la fine della sinfonia Zawinuliana è un treno in corsa, il cui suono è scandito dalla possente batteria funky di DeJohnette, in un’estasi quasi orgiastica. Ma poi di nuovo il silenzio, la meditazione del tema principale. Un capolavoro senza precedenti.
Il disco successivo è quel Monolite di “Bitches Brew” sul quale il sottoscritto si è speso ampiamente (vi invito a tal scopo a leggere la precedente puntata di Jazzical Moods dedicata al disco in questione che ha appena compiuto quarant’anni) e di certo non abbisogna di ulteriori spiegazioni: Esso E’.
Se vi siete ripresi dallo stordimento, proseguite pure verso il pugilato funky di “Tribute to Jack Johnson”, di un anno dopo “In A Silent Way”, la cosa più rock mai ideata da Miles Davis: due lunghissime composizioni, “Right Off” e “Yesternow”, festose, ringhianti e vitali come non mai.
Poi si arriva al punto di non ritorno, miei cari amici pelosi: “On The Corner”, del 1972, uno stream of consciousness funky e stradaiolo, nonchè festante e drogato come non mai che suona come se Sly Stone, James Brown e Santana suonassero tutti insieme strafatti di coca. Vi ho avvisato.
Infine, la fatality: Il “Live Evil”, testimonianza Live al Cellar Door di Washington di ben quattro serate: 6 Febbraio, 3 Giugno, 4 Giugno e 19 Dicembre del 1970, nonchè messa in scena di una vera e propria arma di distruzione di massa sonora: Keith Jarrett, Herbie Hancock, Chick Corea alle tastiere, Wayne Shorter, Steve Grossman e Garry Bartz al sax, Dave Holland, Ron Carter e Michael Henderson al basso, Jack DeJohnette ed Hermeto Pascoal alle batterie, infine Airto Moreira e Billy Cobham alle percussioni. Di recente, precisamente nel 2005, questa meraviglia è stata arricchita da altre registrazioni ed inserite in un cofanetto sestuplo (!) denominato The Cellar Door Sessions, che è la prova dell’esistenza di Dio. Se volete esagerare ed accaparrarvelo, non ve ne pentirete affatto.
Sposate la via elettrica dello sciamano Miles ed innamoratevi. Se così non dovesse accadere, non amate la vita.
Discografia Consigliata: