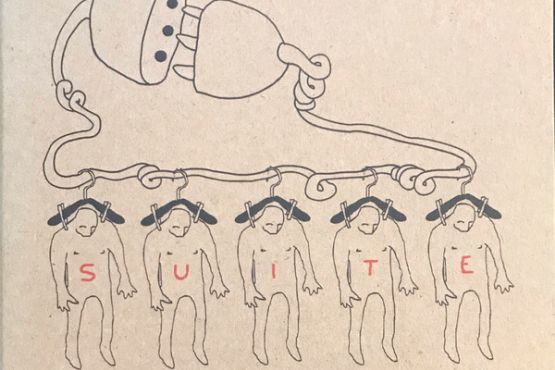Ok, confesso! Se devo dirla tutta allora la verità è questa: mi sono accaparrato il promo in questione nella piena convinzione che si trattasse di un disco dei Tokyo Sex Destruction (misconosciuta band garage ispanica), per cui sono rimasto alquanto spiazzato quando dalle casse hanno preso a fuoriuscire note che poco avevano a che vedere col rock sixties che mi aspettavo… Se in tutto ciò forse devo cogliere un segno inviato dal mio cervello che inizia a liquefarsi e a fare cilecca sotto la cappa dei 45 gradi estivi, d’altro canto è anche vero che in questi tempi di ipertrofia musicale è sempre più missione impossibile tenere a mente nomi di gruppi, membri di band, progetti paralleli, titoli di album, canzoni e compagnia bella. Tanto per dire, “Tokyo” sarà nella ragione sociale di qualche decina di gruppi transitati nel mio lettore cd di recente, per non parlare di “Club”, perchè qui si entra nel novero delle centinaia…
(Ndr: alla fine scopro che in realtà qualche annetto fa qualcosa del combo canadese era anche finita nella mia collezione di dischi, vale a dire l’EP d’esordio “A Lesson In Crime”, che all’epoca generò non poco hype).
Ok, dopo questo sfogo da arteriosclerosi precoce, forse è il caso di tornare a parlare di musica suonata, e magari del disco di David Monks e soci. Che dire, allora, di questo lavoro? Sicuramente quello che balza subito all’udito è quanto i brani qui contenuti non si allontanino più di tanto dai percorsi battuti in precedenza dalla band, e dalle decine di seguaci/emuli/cloni di certo indie rock alla Strokes; dire che i paragoni sono lampanti sarebbe poco, a partire dai suoni di chitarra che ricordano tantissimo, oltre ai succitati modaioli newyorkesi (“Not Sick” o “Favourite Color” su tutte), i primi Cribs o i Bloc Party pre-deriva-musica-da-autoscontri (“Big Difference”, tanto per citare un titolo, potrebbe benissimo far parte della tracklist di “A Weekend In The City”); troviamo poi certi crescendo molto Arcade Fire-iani (l’opening act “Favourite Food”), divagazioni synth-freak alla Unicorns (“Gone”), ed un timbro vocale che alterna momenti di strascicamento fintoscazzato alla Casablancas a inflessioni più ruvide, che tirano in ballo Brian Aubert dei Silversun Pickups. Insomma, i riferimenti sono di tutto rispetto e il lavoro su arrangiamenti, produzione, cura dei suoni e smussatura degli spigoli è notevole, tanto che è palese l’intenzione della band di offrire un prodotto immediato e decisamente radiofonico; ed è questa la croce e delizia dell’album, perchè tutto il lavoro di limatura e rifinitura rende il disco eccessivamente piatto e privo di sussulti.
Insomma, siamo in presenza di un disco onesto, molto politically correct, senza infamia e senza lode, che naviga tranquillo nelle acque basse della sufficienza tenendo sott’occhio la costa ed evitando accuratamente ogni rischio di perdere i riferimenti a terra. Magari qualche canzone (“Bambi”, per esempio?), complice la pista da ballo, avrà la fortuna di durare una stagione, per poi finire inevitabilmente nel dimenticatoio insieme a decine di altri brani di decine di altri dischi di decine di altri gruppi, di cui resterà solo un ricordo confuso e sfocato come dell’estate 2010.