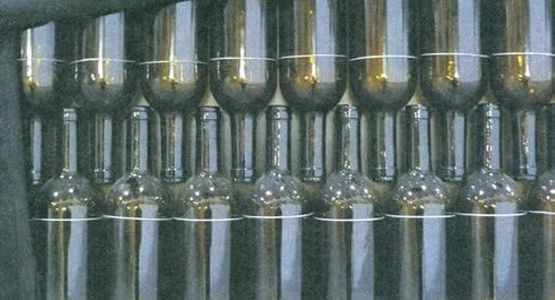Esordio alquanto controverso quello dei londinesi Chapel Club. Dalla piccola Italia ci sembrava che si fosse creato un certo hype attorno all’album. Invece poi scopriamo che il plasticoso e modaiolo NME lo ha liquidato con una risicatissima sufficienza, e non sembra che se ne stia parlando molto nè in Patria nè nel resto del mondo. Il pubblico e la critica sono assolutamente divisi: c’è chi grida al nuovo capolavoro dell’indie-pop, c’è chi ha marchiato la band come il solito combo di hipsters tutto stile e niente sostanza. La verità ovviamente non possiamo offrirvela noi. Piuttosto si può parlare di un punto di vista, certamente più magnanimo rispetto a quello di alcuni dei compatrioti dei CC. Più che convincervi della bontà di questo lavoro, vorremmo fare luce su certi aspetti che forse sono sfuggiti a molti.
Palace ci è piaciuto subito, al primissimo ascolto, ‘a pelle’, come si dice. Andando più a fondo nelle canzoni, si scopre un gran lavoro di cesello nella ricerca dei suoni ma anche nelle dinamiche e nelle scelte d’interplay (più originali di quello che potrebbe sembrare). Ci troviamo in una romantica terra di confine tra shoegaze e post-punk molto melodico virato jangle pop, tra fantasmi di Echo & The Bunnymen, Smiths e Kitchens Of Distinction. Più che emuli di queste band però direi che i Chapel Club sono tra i continuatori più nobili di una tradizione musicale che come si sa ha visto, vede e vedrà tanti e tanti sciagurati falsi eredi incapaci di apportare la minima innovazione. La voce di Lewis Bowman non viene soffocata dalle distorsioni ma anzi solca profonda ed elegantissima texture, armonie e melodie, stagliandosi imperiosa su di esse. Al di sotto i dolceagri droni che lacerano l’algida superficie dei brani guizzano scintillanti schegge chitarristiche e melodie di una commovente limpidezza. A tutto ciò si aggiungono testi profondi, piccoli particolari e trovate di mirabile finitezza (produce il ben noto Paul Epworth, già al fianco di Adele, Bloc Party, Florence and the Machine, tra gli altri), una sezione ritmica interessante e non sempre solo di supporto. Inoltre il disco riesce a trovare un equilibrio quasi perfetto tra momenti più robusti e episodi più dolcemente dreamy, senza che manchi mai una certa raffinata solennità . Insomma quello che sembra il solito album ‘indie’ (sarà pure colpa dell’immagine molto trendy di almeno 4/5 della band?) appare invece molto più complesso nella forma e nella sostanza.
Stupisce l’inaspettata, vigorosissima coda di “Five Trees” che sbuca fuori da un ritornello disorientante e già di per sè bello potente (ma sempre melodicamente assai elegante), travolgono, grazie a un basso e batteria da urlo, le forsennata “After The Flood” e “White Knight Position”, con quest’ultima che fa pensare a una possibile e mai avvenuta evoluzione dei Bloc Party (e non veniteci a parlare di mero revivalismo), emoziona con vibrazioni che forse non sentivamo da tempo la progressione epicamente gioiosa di “Fine Light”. Più sbilanciati verso un certo immalinconente romanticismo brit ci sono brani come “O Maybe I” (il ritornello è probabilmente il momento più mesto del disco) e soprattutto i due lenti “The Shore” (maestosa eppure fragilissima) e la retromodernista “Paper Thin” (i Vampire Weekend senz’allegria bagnati dalle lacrime di un Morrissey definitivamente sconfitto), vero e proprio capolavoro e degna chiusura di uno tra i migliori debutti degli ultimi anni.