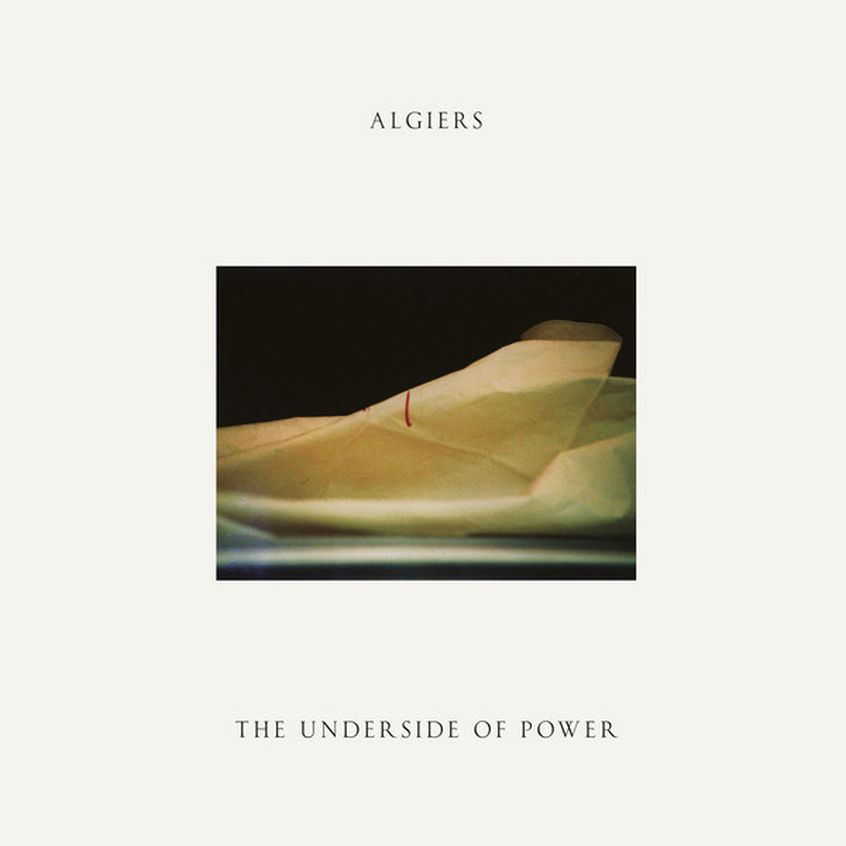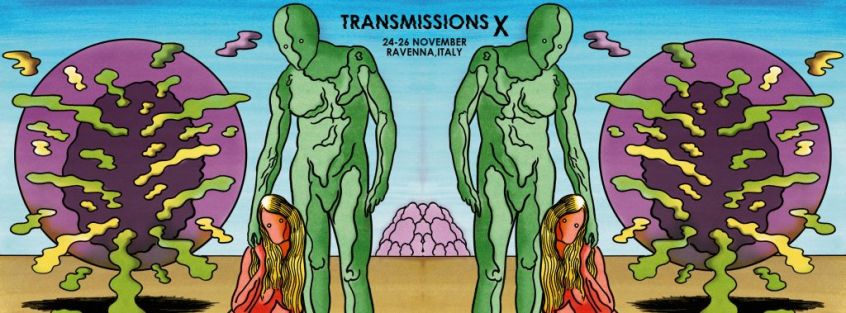In tempi di crisi economica, la mancanza di risorse finanziarie è l’ultimo dei problemi. Che ci si creda o no, la paura di perdere è di gran lunga peggiore della sconfitta. Parole di circostanza? Forse. Ma la violenza con la quale il timore di fare l’investimento sbagliato si abbatte sulla creatività è un problema atavico ma mai così attuale. Uno sguardo al passato, a quella che gli etnologi chiamano “golden age”, diviene dunque una reazione automatica che fa sì che si guardi a un’età dell’innocenza che, invero, non è mai veramente esistita.
“Childhood’s End” è tutto questo: un lavoro che va sul sicuro, un rifugio nel passato e una fotografia sbiadita di un ottimismo morto e sepolto che continuiamo a cercare tra le copertine sbiadite di vecchi vinili.
E se di immagini vogliamo parlare, la copertina ““ forse un po’ banale nella sua tragicità ““ è complementare al titolo della raccolta: alla perdita della leggendaria (nel senso di “‘falsa’) innocenza degli anni 60, alla nozione di un’età dell’amore a cui ogni decade deve oramai rapportarsi finendo per perdere irrimediabilmente il confronto.
Gli Ulver, indubbiamente rinfrescati dall’innesto del genio di Daniel O’Sullivan, scelgono 16 tracce di rock psichedelico e le reinterpretano alla loro maniera. Ma quale? La risposta non esiste. Andare dal black metal degli esordi all’elettronica e i droni passando per il folk e varie sortite sperimentali non può fornire alcuna risposta.
E allora come si arriva a Trang Bang e ai bambini che fuggono dalle case infiammate dal napalm americano? Attraverso 16 tracce di psichedelia oscura quanto basta per non essere tacciati di scegliere la via più pratica e sicura. Pretty Things (“Bracelets of Fingers”), Electric Prunes (“I Had Too Much To Dream Last Night”), Beau Brummels (“Magic Hollow”) e 13th Floor Elevator (“Street Song”) sono nomi che non implicano una richiesta d’interesse da parte degli organi di stampa mainstream. Al contrario: la scelta di brani oscuri e al di fuori del solito circuito celebrativo della decade in esame fa sì che “Childhood’s End” sia un atto d’amore il più spontaneo possibile. L’intento pecuniario è ovviamente presente ma resta dunque ai margini dell’operazione.
Musicalmente parlando, i suoni caldi e soffusi delle tracce originali sembrano vibrare di nuovo di un’energia del tutto simile a quella che ispirò gente come gli sfortunati Gandalf di Peter Sando (il loro unico LP fu distribuito dalla Capitol con l’album sbagliato inserito nella copertina del vinile) all’epoca di “Can You Travel in the Dark Alone?”. O la splendida “Today” dei ben più noti Jefferson Airplane.
“Childhood’s End” riesce nell’intento di rendere omogenee tracce di band e periodi diversi tra loro e gran parte del merito, in questo senso, va alla voce di Kristoffer Rygg, la quale reinterpreta e rianima delle piccole gemme in maniera semplice ma efficace.
Intendiamoci: il mondo avrebbe continuato a girare comunque anche senza quest’album, ma la sua importanza è da intendersi come testimonianza del fatto che gli Ulver riescono a cambiare pur restando fedeli a se stessi; a rivoluzionare il proprio suono pur facendo in modo che questo resti riconoscibile e quindi inconfondibile.
La strada da Altamont al 2012 è stata lunga ma dell’innocenza, chimera di ogni tempo, ancora nessuna traccia. Non ci restano che foto sbiadite e una manciata di canzoni che ne testimoniano comunque, e in ogni caso, il momento della morte e mai quello di una vita che, in verità , non è mai stata.
Credit Foto: Ingrid Aas