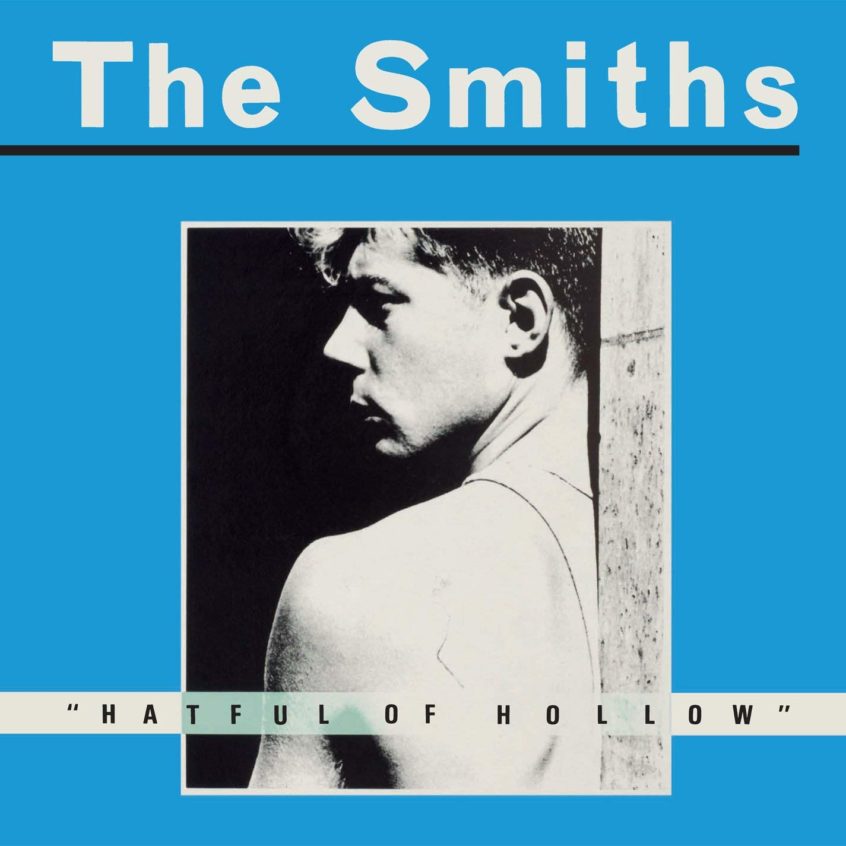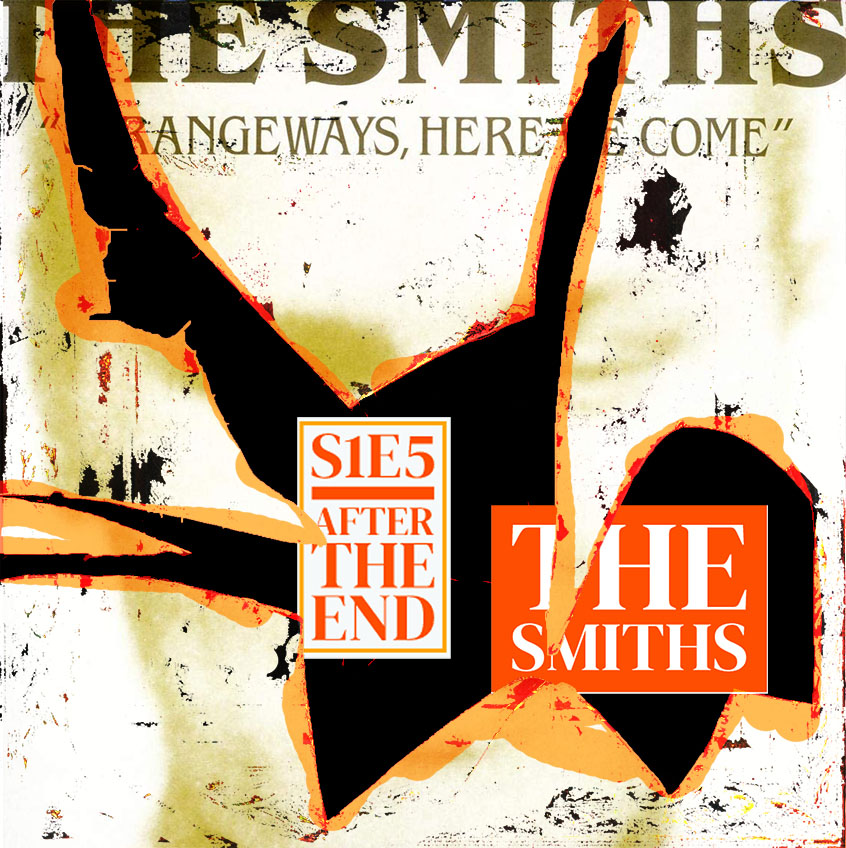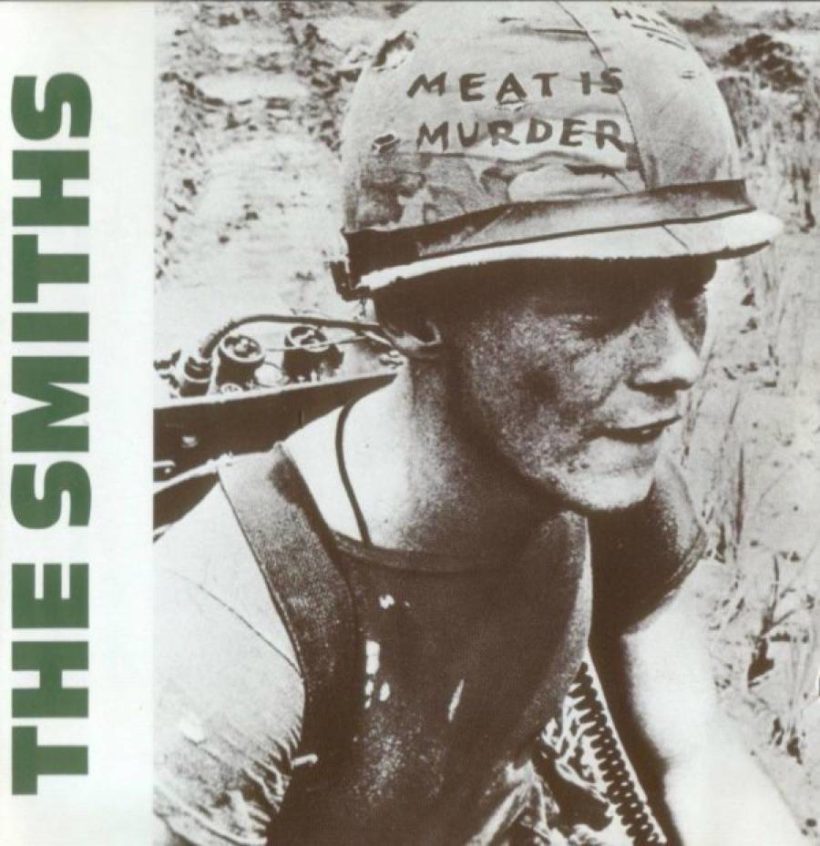A Johnny Marr la storia ha dato ragione, togliendogli di dosso quel peso ingombrante che era stato Morrissey e dandogli il giusto merito. La rivincita ha significato un ridimensionamento, dovuto, a chi ha contribuito in maniera significativa al successo smithsiano. Eppure da quella rottura, ormai lontana, Morrissey, con la sua personalità dominante, ha saputo cavalcare i decenni successivi brillando di luce propria, mentre a Marr è servita una spinta. E così, dopo anni di partecipazioni in progetti che non lo hanno visto protagonista, decide di sfornare un album tutto suo, rimettendosi in discussione.
Il risultato è “The Messenger”. Un disco che fa luce sul talento chitarristico di Marr (ma questo lo sapevamo già ) e scaccia via alcune ombre sulle sue doti compositive. Un tuffo al passato in cui quel modo di intendere il rock non era più punk e non era ancora brit pop. Un po’ sembra che Johnny Marr sia diventato l’adolescente che ascolta gli Smiths e ne rimane folgorato, che si regala una Rickenbacker e mette su un gruppo tutto suo: insomma, la storia presa in prestito da un Noel Gallagher a caso.
“The Messenger” scorre veloce, senza grossi intoppi, con ritmo e senza picchi clamorosi (sia nel bene che nel male). In bilico tra la frenesia dei Franz Ferdinand (“The Messenger”, “The right thing right”), le melodie degli Oasis (“European me”, “Lockdown”) e la wave più cupa e teatrale (“Say demesne”), ma soprattutto, perennemente attraversato da una vena Smiths. Un disco che mostra un Johnny Marr ancora giovane (nonostante i cinquant’anni), con quell’energia della prima volta, che prima volta non è, che si diverte a suonare e a sovraincidere chitarra su chitarra, che è poi la cosa che gli viene meglio.
Niente di nuovo sotto il sole, com’era immaginabile, ma di classe ce n’è, e pure tanta.