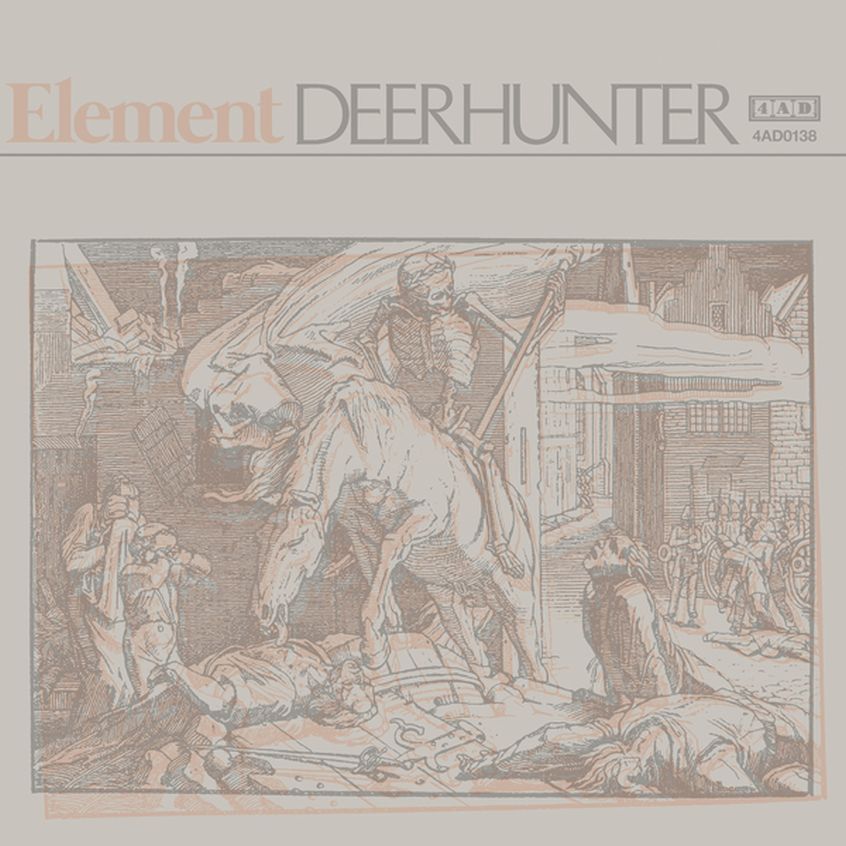…o della monomania di Bradford Cox
Quando ieri sera ho rimesso piede a casa, trovandomi nel casino più totale tipico dell’appartamento di un universitario, per un attimo ho pensato che dalla cucina sarebbe spuntato fuori Bradford Cox con i suoi occhi allampanati, fumando distrattamente una sigaretta fatta a mano un po’ di fretta. Nella recensione dell’ultimo album dei suoi Deerhunter avevamo riportato come lui, Bradford, non faccia in realtà tutta sta gran distinzione tra la roba che registra e che rimane lì non licenziata (“the blog stuff”, come la chiama lui stesso) e quella che una volta registrata finisce effettivamente su disco. Ecco, Bradford Cox è una costante e perpetua fucina di idee, la sua monomania è la musica, e ogni momento è buono per inventare, provare, cestinare, perfezionare, riprovare. Anche il palco.
Durante il concerto al Magnolia, Cox si avventura in cavalcate shoedeliche dai 2 ai 7 minuti (a seconda di come gli giri) abbozzando riff e perdendosi nel groove francamente irresistibile di pezzi che nella dimensione live diventano più elettrici, aggressivi e dolcemente rintronanti.
Ammetto che l’espressione “muro del suono” mi era empiricamente e direttamente sconosciuta prima di ieri sera, ma posso dire di averla provata per gran parte del concerto che i cinque di Atlanta hanno messo in piedi. Complice sicuramente anche la piega che la performance ha preso o meglio dovuto prendere sin da subito, ossia quella di una nube sonica ai limiti dello shoegaze. Dico “dovuto prendere” perchè problemi di volume hanno purtroppo inciso negativamente su alcuni brani, arrivando addirittura a rendere inudibile la voce in “The Missing” (cantata fra l’altro non da Bradford ma dall’altro chitarrista). Non che in realtà ci si aspettasse qualcosa di granchè diverso: quando i pezzi si prestano a far rumore è bene che lo facciano (“Cryptograms”, “Neon Yunkyard, una “Don’t Cry molto riverberata, una “Revival” forse troppo riverberata, un’accesissima “Monomania”).
Se “Monomania” (l’album) avvicina vagamente i Deerhunter a certe suggestioni Strokes-primi-tempi, mi viene spontaneo associare la loro orgia sonora e sonica (pur con tutte le dovute proporzioni in termini di portata storica) a quella scatenata dai Velvet Underground nei loro primi concerti a New York. Unendo alla forza psichedelica di Reed e co. l’irruenza di una band punk dei pieni anni 70, di quelle vere insomma. Voglio dire: si suona, l’importante è quello, l’importante è colonizzare ogni molecola d’aria con il suono (più che semplicemente con la musica). A Bradford Cox, capo quasi dispotico di un gruppo che al contrario suo è taciturno e mantiene la testa bassa sugli strumenti, bandando bene di seguire il boss in ogni singola deviazione dei suoi percorsi volitivi, non importa null’altro che questo. Non importa null’altro che presentarsi sul palco non si capisce bene in quali condizioni di lucidità mentale, di cognizione di spazio e tempo, con una parrucca che metterà e toglierà a intermittenza, imbracciare la sua chitarra e sbiasciare o urlare i suoi versi di smarrimento e speranza.
Vale pressochè lo stesso discorso fatto su Springsteen (anche qui non voglio passare per il paragonista pallonista): un uomo che non può fare altro che stare su un palco. Con una piccola ma sostanziale differenza: il Boss vive per fare musica, Cox fa musica per vivere. Un personaggio così, dall’indole punk nel senso di rottura dalle convenzioni eppure cristiano alle volte troppo loquace e irruento eppure fragilissimo, va tenuto davvero stretto.