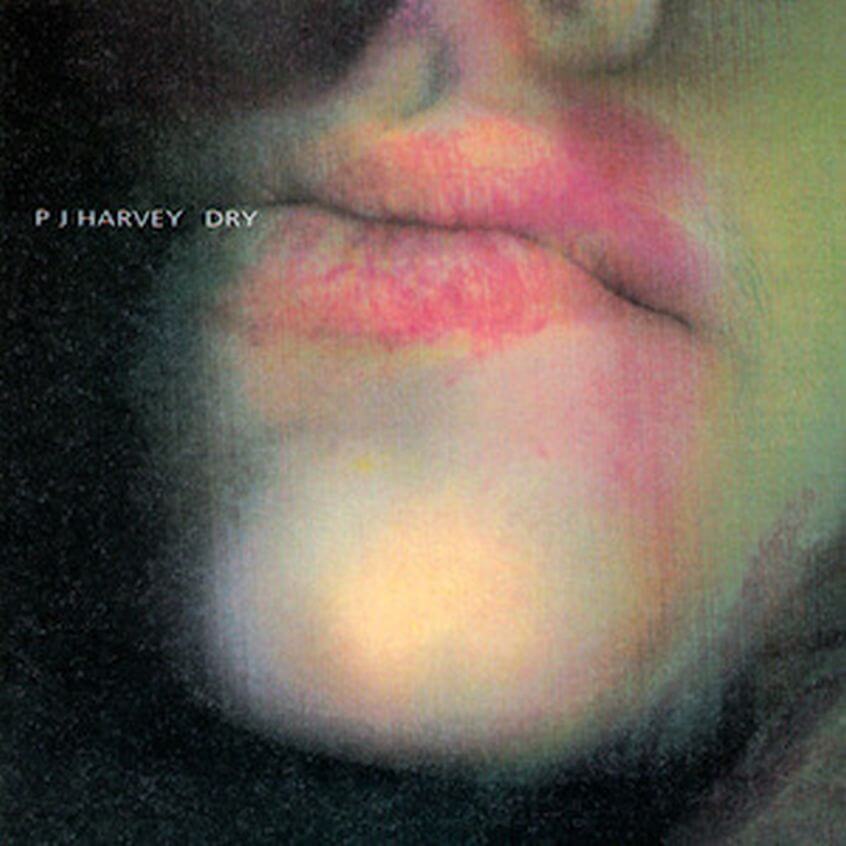Dell’ultimo disco di PJ Harvey, l’unica e inimitabile Polly Jean, si può dire molto, ma non che non sia stato annunciato. Dopo aver registrato parte del lavoro in una serie di sessioni aperte al pubblico ““ gli spettatori erano scortati al di là di un vetro e avevano diritto a quindici minuti di Polly che suonava, parlava, mangiava, a seconda dalla fortuna ““, la musicista inglese ha pubblicato un libro in collaborazione con il fotografo Seamus Murphy, “The Hollow of the Hand”. Poesia e fotografie: Murphy e Harvey hanno trascorso periodi in Kosovo, Afghanistan e Washington DC in cerca di storie e volti ““ il risultato è un volume di 231 pagine, in cui immagini e parole si richiamano a vicenda, senza essere mai indimenticabili, nè trascurabili.
“The Hope Six Demolition Project” segue “The Hollow of the Hand”: le immagini dei video, le parole delle canzoni, si trova ““ quasi ““ tutto qui. Il disco è una sorta di secondo episodio di “Let England Shake”, idealmente e musicalmente, ma se il tentativo di innalzare il discorso in termini mondiali è ambizioso, il processo con cui ci si arriva è debole e incerto.
Polly Jean fa raccontare le storie a chi vive in quei luoghi e ne riporta le voci nel modo più oggettivo che conosce: si allontana dalla fotografia e li lascia parlare, ma sembra dimenticarsi che non c’è modo per essere oggettivi, per cancellare il fatto che stia raccontando una sola storia, stia scattando una sola fotografia. La sua presenza in questo album è elusiva e non dovrebbe esserlo, tanto da esporla alle critiche di chi dice che sembra sia andata in cerca tragedie e detriti: dei pericoli della storia unica si parla anche troppo poco e davvero non hanno torto gli abitanti di Anacostia a lamentarsi di una immagine riduttiva e senza speranza del quartiere; è vero che ci sono drogati e siringhe da quelle parti, ma è vero che questa è solo una parte della realtà , quella che si è deciso di raccontare. C’è qualcosa di poco disinvolto e confuso in un album come questo, ma forse vale la pena ricordare, prima di diventare troppo severi, che queste non sono poesie e non sono etnografie, e “The Community of Hope” resta un ottimo pezzo, così come molte delle altre tracce. Se vogliamo leggerci un reportage dalle zone di conflitto, forse il caso è andare altrove e godere qui della sua presenza nella voce, nella musica; è forse facile dismettere una questione del genere, che è cruciale, solo perchè si ama una musicista più di altre, ma non tutte le persone sono uguali e forse è giusto dare a Polly Jean Harvey il credito che le spetta. “The Hope Six Demolition Project” è un disco che cresce ad ogni ascolto – così ricco musicalmente, così denso che forse è questa la vera eredità che i luoghi le hanno lasciato; come se le istanze di conflitto, la resilienza di certi panorami fossero migrate dallo sguardo alla costruzione musicale. Qua ogni oggetto, ogni lascito musicale – gli spiritual, l’uso ripetuto dei cori, quasi che ogni pezzo avesse a che fare con il cielo e con la polvere che si alza da terra – collaborano a creare una ricchezza di suoni e influenze che non hanno niente a che vedere con la world music come esotismo. Partendo da qua, perchè è di musica che si sta parlando, questo album torna ad avere l’interezza che a tratti è assente.
La vecchia che tiene le chiavi di tutte le case abbandonate, il bambino che chiede un dollaro ai finestrini delle macchine in fila, i graffiti in arabo, le ossa e la musica dai camion: è tutta roba che troveremmo solo stucchevole, come le registrazioni dei rumori di fondo, il sassofono tra i clacson, il Walmart. Eppure “TSHDP” non è un bazaar delle disgrazie, non è una puntata di Homeland con Carrie fuori di sè, perchè quelli non sono simboli, ma storie. Non è il lavoro migliore di Polly Jean, ma questo è il disco di un’artista matura e consapevole. E anche stavolta fa la differenza.
Credit Foto: Maria Mochnacz