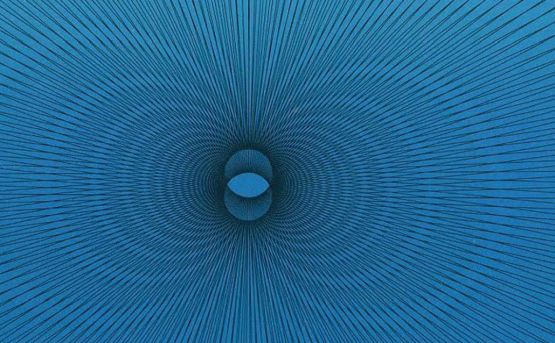Devo proprio ammetterlo: per un figlio degli anni ’90 come me, la cosa che mi ha messo più a disagio, conseguentemente all’elezione di Donald Trump, è stata la condivisione seriale di foto che lo ritraevano come guest in eventi televisivi simbolo della mia infanzia, come Mamma ho riperso l’aereo e, soprattutto, Willy, il principe di Bel-Air. In quel memorandum ho trovato una violenza, terribile e retroattiva, come se il neo-presidente fosse così vorace da riuscire pure a rovinarmi l’infanzia. Del resto, è proprio attraverso alla serie con Will Smith che mi sono approcciato per la prima volta ai nigga con le felpe larghe ed il radiolone sul playground; vedere lì in mezzo l’emblema del razzismo più becero e radicale mi ha fatto male quasi fisicamente.
In questo clima di disfattismo a macchia d’olio, che dal presente si allarga al futuro ed al passato, trovo simbolico il ritorno degli A Tribe Called Quest, appena due giorni dopo l’elezione di Trump.
Andiamo con ordine, però: non mi sembra produttivo spiegarvi chi siano questi ragazzi, lo potete leggere altrove ed in una maniera più esaustiva. Limitiamoci ad accennare come gli ATCQ siano una delle formazioni più influenti degli anni ’90, non solo per il genere ma in senso assoluto, e di come la loro scomparsa negli ultimi diciotto anni si sia sentita, fortissimo.
Poi, all’improvviso, la storia incredibile che, come ogni racconto entusiasmante, contiene al proprio interno epicità , entusiasmo e tragedia.
Neanche un mese fa esce una nota di firmata direttamente da Q-Tip in cui viene raccontato come il calore ricevuto nella prima esibizione televisiva in diciotto anni, il 13 Novembre 2015 al Tonight Show di Jimmy Fallon, e gli attacchi terroristici della stessa sera a Parigi abbiano smosso qualcosa di grosso in loro e abbiano spinto tutti e quattro a mettersi al lavoro su un nuovo LP inedito.
E’ una storia in cui tragedia e festa si incrociano dal primo istante, da quel 13 novembre 2015 ed, ancora più, più strette insieme, a marzo; dopo una lunga battaglia contro il diabete viene a mancare Phife Dawg, architrave con Q-Tip del gruppo, e tutto assume un nuovo significato.
Ora, date queste premesse l’interesse era tanto: assistere all’atto finale di quella storia bellissima che coinvolge Phife Dawg, Q-Tip, Jarobi White e Ali Shaheed Muhammad, tutti insieme, un’ultima volta, nella settimana peggiore da tanto tempo per gli Stati Uniti.
Comincia “The Space Program” e sento per la prima volta Q-Tip e Phife dialogare insieme, dopo diciotto anni.
It’s time to go left and not right, gotta get it together forever, gotta get it together for brothers
gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas, for non-conformers, won’t hear the quitters, for Tyson types and Che figures.
E sotto un piano, un basso e poco altro a formare un architrave jazzy. E basta questo per sentirsi a casa e meno soli e per tornare ad empatizzare con un ambiente che, nonostante il silenzio di diciotto anni, può tornare a suonare prepotentemente come e quando vuole. Ed ha scelto di farlo proprio ora, non a caso.
A seguire, a mio parere, il brano più riuscito dell’intero LP, “We The People…”; già dal titolo si potrebbero notare molte cose, a partire dal riferimento alle parole d’apertura della Costituzione Americana, storicamente segno di libertà ed emancipazione a cui oggi fa da contraltare la radicalizzazione razziale. Un po’ come il contrasto che si provava nel vedere quelle stesse parole, stampate a caratteri cubitali sulla carta da parati, dietro la scrivania di Saul Goodman, in una puntata qualsiasi di Breaking Bad. Il brano è crudele e tagliente: su un beat vorace che va a singhiozzo (e sample, non troppo a caso, dei Black Sabbath) si appoggia la denuncia degli A Tribe Called Quest, i quali, nell’asciuttezza e nella crudezza delle parole, forniscono un quadro realistico e doloroso dello stato di profonda divisione e di diffidenza collettiva che invade oggi gli Stati Uniti ed il mondo intero e trova il proprio compimento nell’odio programmatico di Trump: all the black folks you must go, all the mexicans you should go, che non è solo il ritornello di una canzone ma la fotografia nitida dei pensieri di molti tra noi.
Nella successiva “Whateva Will Be” il registro non muta, bensì trova la propria sintesi: su una base a metà tra il jazz ed il funk ritroviamo la stessa denuncia. Say am I ‘posed to be dead or doin’ life in prison? Just another dummy caught up in the system. Ed il riferimento è ovviamente ai notissimi fatti di cronaca che coinvolgono polizia e popolazione afroamericana ed al tragico stato delle prigioni e del sistema penale statunitense, vera e propria piaga sociale del paese(guardatevi il documentario Netflix XII Emendamento e scoprirete che un afroamericano su tre, statisticamente, si troverà in prigione prima o poi, nell’arco della sua vita). Considerato ciò non trovo che sia una casualità che tutto il brano si appoggi su un sample di una certa “Promised Land” delle Nairobi Sisters.
Sarebbe ingeneroso ridurre alla denuncia politica quella che è, prima di tutto, vera e propria meraviglia musicale: alle super-produzioni e l’auto-tune a grappoli degli ultimi tempi vengono preferite delle composizioni di classe, veramente di altri tempi. Così, in “Solid Wall of Sound” troviamo Elton John alla voce, (ai sample), ed al piano, accompagnato da un certo Jack White all’acustica ed è tutta una grande magia a cui sei grato di prendere parte.
Sarebbe altrettanto ingeneroso ricondurre il tutto al classico ritorno della leggenda che svilisce tutto ciò che è nuovo è sconosciuto; nella produzione, e nei credits, di “We Got It From Here… Thank You 4 Your Service” si nota la grandissima consapevolezza di quello che di buono c’è stato nei diciotto anni di silenzio degli A Tribe Called Quest. In “Dis Generation”, infatti, i quattro trovano tempo per riconoscere i giusti crediti a chi negli ultimi anni ha raccolto la loro eredità : si fanno nomi e cognomi e si parla di J.Cole, Earl Sweathshirt ed, ovviamente, Kendrick Lamar (lo stesso Kendrick che prende parte attiva, ispiratissimo come sempre, in quel bellissimo dialogo chiamato “Conrad Tokyo”).
Contraltare di “Dis Generation” è l’attacco generazionale su beat acido di “Kids…”: qui gli ATCQ, accompagnati da Andrè 300 degli Outkast, si scagliano contro l’immobilismo e l’indifferenza giovanile, riuscendo, ancora una volta, a raffigurare perfettamente la situazione con poche parole (“Kids, don’t you know how all this shit is fantasy?”)
Il tema politico torna potentemente in “The Killing Season”, brano in cui viene denunciata la terribile politica militare made in U.S.A. Nel ritornello di questa canzone, poi, accade il miracolo: compare la persona più egocentrica del business, il nostro caro Kanye West, solo per cantare tre parole (“they sold ya”). Se ci pensate questa cosa ha dell’incredibile e da una giusta dimensione della portata che ha questo album nell’ambiente. Mi ha ricordato una puntata di Friends che ho visto qualche giorno fa in cui Ross è disposto a fare qualsiasi cosa per avere un ruolo al matrimonio di Phoebe ed alla fine, sfumata ogni possibilità di occupare una posizione di rilievo, si accontenta semplicemente di portare il cane dello sposo all’altare; se ci pensate qua succede la stessa cosa, e quello che generalmente è il centro della storia si riduce a portare il cane puzzolente all’altare degli A Tribe Called Quest, piuttosto che rimanere in disparte tra la schiera nutrita dei fedeli.
Poi, ci sono tante altre cose di cui vorrei parlare, tipo gli arpeggi ed il dinamismo di “Melatonin” o le tinte pastello di “Enough!!”, ma rischierei di perdere il punto del discorso, che è sintetizzato perfettamente nella canzone finale, il definitivo commiato, “The Donald”. Tu leggi il titolo e pensi che il tema sia sempre quello, quello della disarmante sconfitta della politica incarnata in Donald Trump, ma scopri che è così solo in parte ed il nome del tycoon è solo una tinta sfumata che si disperde tra gli scratch del bridge; è molto di più: è un dialogo di Q-Tip e Busta Rhymes su, e con, Phife Dawg. Un giusto tributo, un gospel reggae, in cui la morte di Phife, incarnata da tutti i “The Donlads” di questo mondo, viene sopraffatta dalla speranza e dalla gioia che suscitano il ricordo. In questo senso, trovo che sia incredibile che lo stesso Phife partecipi al proprio tributo, come a simboleggiare che non esisterà mai un brano degli A Tribe Called Quest senza di lui.
Ecco, come dicevo, il punto sta tutto in questo ultimo saluto; perchè “We Got It From Here… Thank You 4 Your Service” è certamente un LP che circoscrive e certifica tutte le miserie del nostro mondo ma, ancora di più, è un inno alla speranza, alla vitalità ed a tutto ciò che c’è di buono.
Io non potevo chiedere nulla di meglio per essere accompagnato in questi primi mesi di presidenza di Donald Trump: sapere che da qualche parte in quella grande nazione da cui, volenti e nolenti, dipendiamo, esiste ancora una visione non radicalizzata ma, al contrario, accogliente.
La musica è bella quando riesce ad essere qualcosa che va oltre se stessa, quando riesce a dialogare sui più svariati livelli. Allo stesso modo del bambino che si fa strada nella favelas attraverso i dribbling, il quale trascende completamente il calcio.
In “Enough!!” Q-Tip continua a ripetere incessantemente is this enough? Is this enough? ed, d’impulso mi verrebbe di rispondere no, perchè di cose così enormi non se ne ha mai abbastanza.