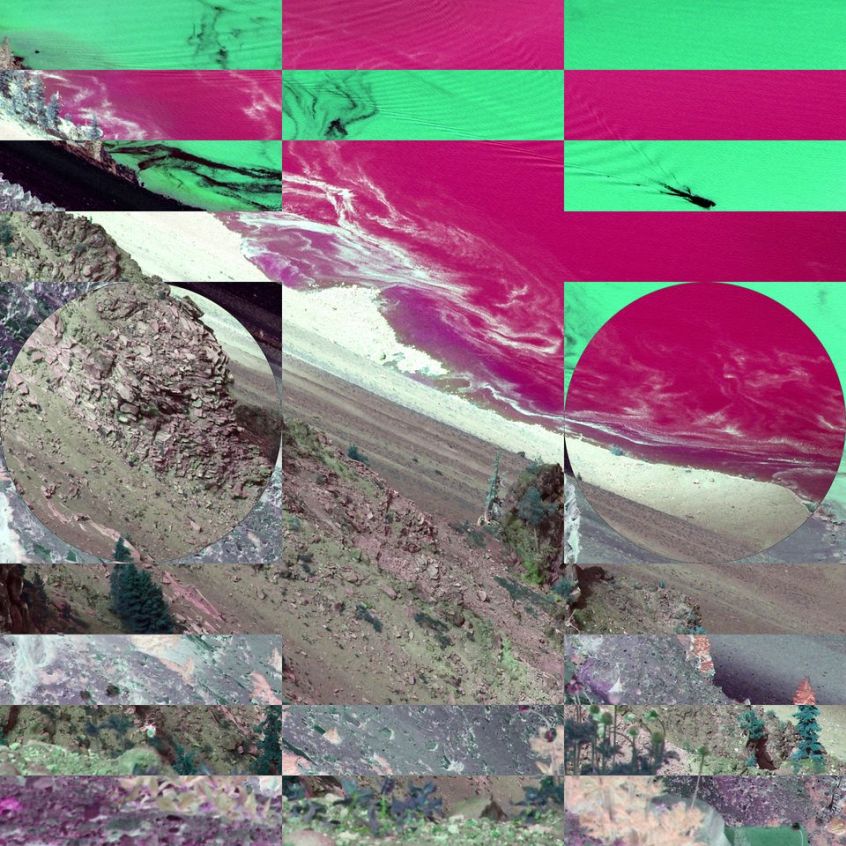Sullo stato dell’indie-rock se n’è discusso anche troppo e probabilmente sarebbe anche l’ora di darci un taglio. Perchè lo stato di crisi del genere è sotto l’occhio di tutti: metteteci da una parte l’incapacità del mezzo di riuscire a stare al passo con i tempi, salvo eccezioni rarissime (vedi Car Seat Headrest) e dall’altra la crisi assoluta, e non solo di genere, delle chitarre ed il quadro sarà facilmente sintetizzabile e comprensibile.
Ora, la ragione per cui si parla qui, in questa recensione, della crisi dell’indie-rock è agilmente dimostrabile: negli ultimi anni, essendo un afecionados del genere, mi sono ascoltato praticamente ogni nuova uscita, ritrovandomi il più delle volte a cavallo tra il disagio e la nostalgia; mai però mi ero trovato ad analizzare un LP che incarnasse in maniera così puntuale le cause ed i risultati di questa crisi dell’indie. Finisce, poi, che “Heartworms” diventa un concept-album sulla ultra-citata crisi, senza un’esplicita volontà dell’autore.
Perchè, bisogna chiarirlo subito, prima di tutto “Heartworms” degli Shins è un album che suona benissimo e la cosa non è per nulla scontata: gli ultimi anni della band non erano stati nulla di trascendentale ed i più probabilmente lì conoscono per “New Slang” nella sala d’attesa ne “La mia vita a Garden State” o per la stessa canzone in sottofondo alla pubblicità del Winner Taco.
Aggiungeteci poi come l’ultimo di James Mercer come Broken Bells trascenda il trascendibile per sfociare direttamente nell’orrore ed il quadro è completo.
Ecco, che un album degli Shins quindi riesca a suonare così gioioso e pieno e colorato nel 2017, per quel che mi riguarda è già una notizia. C’è quell’aria di festa e quell’ariosità e spensieratezza tipica dell’indie-rock: l’eterna adolescenza a cui tutti noi vorremmo aggrapparci nonostante tendenzialmente alle feste ci annoiamo ormai (come saggiamente ci ricorda il profeta nostrano Edroado Calcutta).
Il punto cruciale è chiedersi a cosa può portare oggi tutto questo. Perchè ad ascoltare “Heartworms” succede una cosa molto semplice: tutto è piacevole, addirittura quasi bello, ma niente rimane. Neppure la voglia di ascoltarlo. Tutto è già stato detto meglio e probabilmente così ci basta.
Questo è lampante soprattutto quando si ascoltano le canzoni “classiche”, come la traccia d’apertura “Name for You” o il trittico “Half a Million”- “Dead Alive”- “Heartworms”: la produzione è ispiratissima ed essenziale, la melodia è accattivante ed i ritornelli rimangono in testa. In altre parole, parliamo della perfezione indie-rock. Il problema però è sempre quello e lo trovi scavando un po’ più ne profondo; sono tutte canzoni piacevolmente trascurabili e, per quanto siano oggettivamente produzioni perfette, finisco per assomigliarsi tutte. Come se fossero uramaki di un Sushi All You Can Eat che sembrano tutti buonissimi ma, infondo, sanno tutti riso e poco altro. E poco importa se in una la chitarra sia acustica e nell’altra sia elettrica perchè tutti ci ingozziamo indistintamente di maki con il salmone cotto e crudo. A volte entrambi insieme.
Poi, e questa probabilmente è l’unica vera osservazione degna di nota, vengono riproposte le derive elettroniche sperimentate già con “Port of Morrow” e con i Broken Bells.
“Painting a Hole”, per esempio, oltre ad essere, per quello che è il mio modestissimo parere la canzone migliore dell’album, si appoggia completamente su forti ed, a tratti, incociliabili contrati: synth voraci da una parte e toni scanzonati, tinte vivaci sullo sfondo. Il risultato è convincente e ricorda le prime uscite degli Of Montreal. E, soprattutto, a differenza del resto delle canzoni dell’album, rimane.
O la successiva “Cherry Hearts”, dal piglio più pop e, contestualmente, alieno, straniante ed eccentrico (qualcuno ha parlato di Animal Collective ed ha abbastanza ragione).
Sono entrambe esempi di una strada che sarebbe stata possible ma che non è stata percorsa fino in fondo.
Tirando le somme, dicevo che “Heartworms” è l’esempio perfetto della crisi dell’indie-rock per motivi che ho spiegato: è carino, tanto carino, ma non rimane.
L’impressione è quella di essere di fronte ad un genere che fa sempre più fatica a veicolare un messaggio: la musica è una forma d’arte molto legata al contesto culturale e sociale in cui si inserisce (quale non lo è poi?) e l’indie non è assolutamente il genere che meglio ci descrive oggi (escludendo bellissimi esempi rarissimi come il già citato Car Seat Headrest).
E mi dispiace per gli album perfettini degli Shins, in senso assoluto ed ancora di più per quest’ultimo che suona così bene, ma ci vuole ben altro oggi per restare.