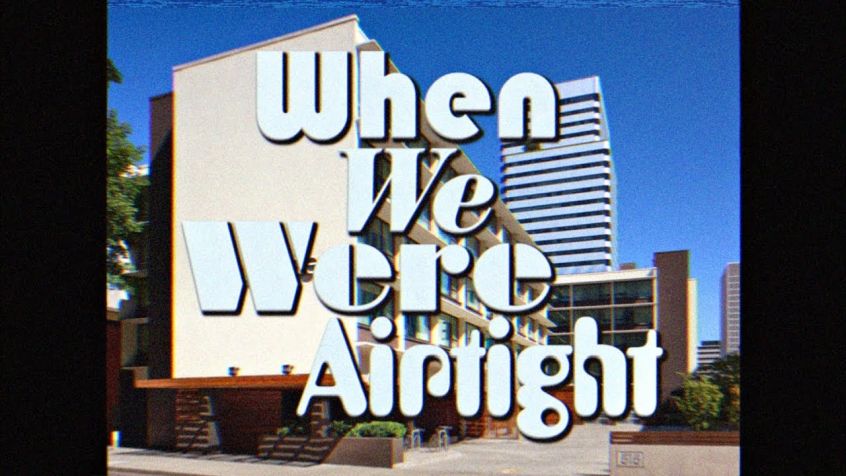Quando ti trovi a recensire il più importante gruppo italiano (a giudizio di chi scrive ovviamente) c’è sempre una certa ansia non indifferente. Non ho voluto basarmi su possibili distrazioni, nè comunicati stampa, nè interviste, nè informazioni di amici che apprezzano la band; no, me ne sono stato in trepidante attesa, senza raccogliere informazioni, ma concentrandomi solo su quello che le orecchie mi avrebbero rimandato al momento del primo ascolto.
Bene, il giudizio è assolutamente positivo. Gli Winter Dies In June non hanno paura nè di rischiare nè di cambiare pelle. Il dialogo tra la strumentazione e la voce di Alain (che narra di una storia d’amore tra due ragazzi, come una diario, tra luoghi, avvenimenti e sensazioni vissute) non avviene più così spesso solo con la chitarra, ma anche con synth che riempiono maggiormente il suono, che si fa più stratificato, e che si sposano a quel gusto sempre in bilico tra l’Inghilterra e l’America. Mutevoli gli Winter quindi, ma sempre loro, con canzoni incalzanti, elaborate (ma sempre fluenti e scorrevoli) e ricche di passione e soprattutto con l’obiettivo melodico sempre impresso nel cervello, perchè alla fine Alain (probabilmente mai così incisivo, suggestivo e versatile nel modulare in modo magnifico la sua voce) e compagni proprio non ce la fanno a stare lontani dai ritornelli vincenti e da soluzioni intriganti. Ma questa volta invece che lavorare sull’immediato, costruiscono una torre indie-pop dalle diverse sfaccettature, che si presta ad essere osservata da più angolazioni e, sguardo dopo sguardo (leggi: ascolto dopo ascolto) il tutto ci appare ancora più maestoso e perfetto.
Sul fatto che le chitarre si trovino a loro agio nel letto del fiume scavato dai synth ecco un brano come “Sands” in cui i due elementi convivono con armonia e sopratutto passione e sentimento: quel calore vivo e importante che anche questa volta non manca alla musica dei ragazzi di Parma. “Boy” è roba sopraffina: parte carica e ariosa, disegnando pregevoli trame pop, spezzate dall’assolo di chitarra che riabbassa i toni, fino a quando ci sembra di sentire gli Air che prendono il controllo del pezzo. Applausi. “Nowhere” ha questo taglio anni ’80 che, emozionalmente, mi viene da accostarla a “Reality” di Richard Sanderson (‘Il tempo delle mele’ docet!), prima del finale riverberato. Riverberi si, perchè spesso le chitarre, quando arrivano, sanno essere rumorose e in odore di shoegaze: la cosa è curatissima e assolutamente studiata al minimo dettaglio, in ogni brano.
Prima del finale struggente e quasi in punta di piedi di “Different”, è impossibile non citare l’equilibrio perfetto tra sogno e concretezza evocato da “Penelope”, forse il brano che potrebbe spiazzare di più chi già conosceva la band ma che in realtà si dimostra scommessa pienamente vinta.
Centro perfetto, ancora una volta: il disco migliore degli Winter Dies In June sarà probabilmente anche una delle uscite italiane più importanti dell’anno. Ne siamo convinti!