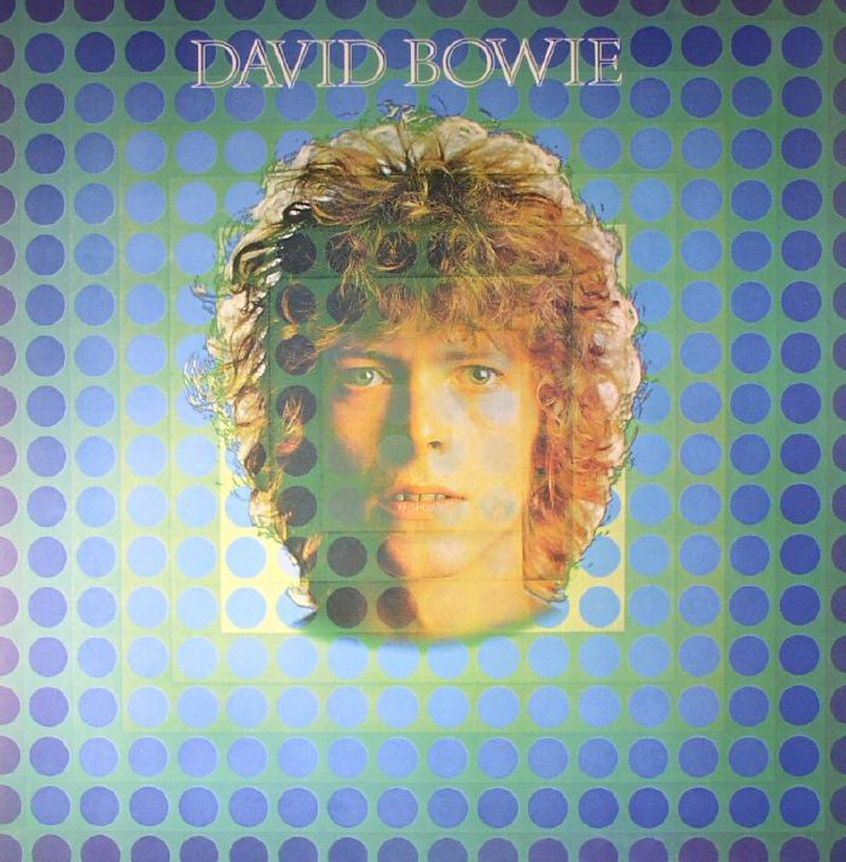Come quando la bandiera della tua squadra del cuore lascia il calcio giocato per dedicarsi ad altro.
Come quando il tuo compagno di bevute ti lascia da solo al bancone del bar, paga il conto e saluta, ricordandoti la sua partenza per un luogo esotico, un nuovo lavoro e quel “ciao” si tramuta in un “arrivederci”.
Come quando dopo ben dieci anni il tuo smartphone e la tua playlist decidono di abbandonarti, levi via le cuffie e rolli una sigaretta, come se il fumo possa sostituire una mancanza.
Qualcuno diceva “Certe luci non puoi spegnerle” ma quando a spegnerle è chi ha dato loro vita, devi solo iniziare ad abituarti alla loro assenza, metabolizzare il dolore e andare avanti, abituandoti al buio.
2008-2018: Vasco Brondi annuncia la fine del suo progetto, LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA.
Quattro album, un cospicuo numero di collaborazioni e tre libri: questo è ciò che lascia a chi c’è sempre stato, a chi ha sempre creduto che quel ragazzo di Ferrara avesse un qualcosa in più, avesse la capacità di arrivare nelle zone più recondite del nostro inconscio, avesse la forza di strattonare i nostri IO e prenderci a ceffoni, quelli belli, quelli che scambieremmo in uno dei più classici incontri sadomaso.
Dieci anni passati forse troppo in fretta, dove è cresciuto lui e sono cresciuto anch’io.
La capacità di evolversi senza perdersi. La capacità di cambiare restando riconoscibile alla prima nota,
al primo verso, al primo respiro. Se dovessi scrivere di lui lo farei esattamente in questo modo.
Era il lontano (ma sembra ieri) 28 dicembre 2008 quando andai per la prima volta ad un suo concerto.
Diciannove anni, tanta confusione e sempre lo zaino sulle spalle.
Conoscevo ben poco del suo primo album, “Canzoni da spiaggia deturpata”.
Andavano ancora i lettori MP3, fumavo ancora Marlboro Red e il live si tenne nell’area fumatori.
Musica, sigarette e aggiungete le birre, il mood era quello giusto,
anche se conoscevo ben poco dell’artista che sta per esibirsi.
Fu amore a prima nota, a prima sbavatura, a prima stonatura.
Sul palco un Vasco ventiquattrenne, accompagnato da Giorgio Canali. Un suono duro, metallico, una voce rauca e profonda. Non credevo di poter star così bene. Futuri inverosimili, sudorazione alta e mani fredde.
Il fumo del locale funge da lacrimogeni, dobbiamo rimboccarci le palpebre e coprire i nostri capelli che sono fili scoperti. Occhi lucidi, mi capita spesso ai concerti, la musica mi emoziona.
Piove dentro e tocca accendere le sigarette con i fulmini, e allora pensi a lei, la tua ex, amori adolescenziali finiti mali e pensi che non l’hai mai rincorsa come nei film melodrammatici di merda, per accorgerti o accorgerci di quanto siamo stati friabili.
Ripensi a quando non avevi tre euro per comprare quei preservativi troppo costosi e a quando,
dopo aver fumato l’erba, passavamo sere a sbranarci e strafarci, cercando di interpretare gli incubi dei pesci rossi e il motivo per cui i nostri addetti alla fabbricazione del buonumore fossero andati in cassa integrazione. Ripensi al fatto che lavoravi da camerieri per pochi euro a serate, che avresti voluto fare l’università mentre alcuni si impiccavano in garage e in tutto ciò invocavi la fine della bella stagione che per te bella non è.
COME BACK SEPTEMBER come il mantra della vita, per chi vive l’autunno come se fosse la più bella delle stagioni. Ripensi alle parole perse, ai silenzi non apprezzati da interlocutori che con le loro parole vuote hanno contribuito allo scioglimento dei ghiacciai, per poi alzarsi e andare via, da soli,
ad abbaiare a cieli sempre più da rottamare.
Se dovessi scrivere della mia prima volta con Le Luci della Centrale Elettrica lo farei esattamente così.
Se dovessi scrivere di “Canzoni da spiaggia deturpata” lo farei esattamente così.
Arriva il 2010, un nuovo album.
Qualche anno in più sul groppone, qualche amico perso alle spalle e la volontà di costruire monumenti in loro memoria. Quei sei mesi in un call center che ripiombano in “Cara catastrofe” e capisci che effettivamente “ci fregano sempre”. Amori interinali, tastiere che sostituiscono le biro per scrivere le nostre lettere d’amore e muri non troppo muti che riportano assenza di pensiero di partner e/o scopamici.
Quando ascolti “Cara catastrofe” piangi, anche se sei uomo, e le guance libere da bulbi piliferi si arrugginiscono comunque. Metterci la faccia quindi, anche se arrugginita e prendersi magari anche qualcosa dell’altro, come quei cazzo di occhi maledetti, che sono stelle attaccate male in cieli dipinti con i pennarelli scarichi e che non puoi fare altro che sequestrare e portarteli sempre dietro, nella tasca interna del giubbotto.
Amori che fanno feriti e che ci rendono consanguinei e allora fanculo quelle stelle, meno stelle e più eclissi per non rivederci. Meglio la notte, dove i capelli decolorati non brillano, dove sull’argine stavamo volentieri scomodi, disegnando i nostri profili sui sedili posteriori delle nostre automobili di seconda mano, magari disegnando strisce pedonali sulla schiena di lei.
Umidità sempre, umidità da occhi lucidi come le Mercedes che vengono trasportate dall’alta marea di quei sguardi. Amore come scambio, come quelli che abbiamo fatto in passato, quando vedevamo l’amore come un qualcosa di folle piuttosto che equilibrato. Amori viscerali, quelli da aprirti in due, da scuoiarti vivi, da portarti a scambiare gli organi e ridurre le nostre camere arredate male a macelli di periferia. Pareti imbrattate, perdite di sangue e vernice rossa per le trasfusioni. Scambi d’organi e gambe chiuse ermeticamente, movimenti sismici e cuori che battono, sismografi attivi, addormentarsi e sogni come armi nucleari, sperando di non morire uccisi da Putin, e cieli che di notte arrivavano ai nostri soffitti.
Se dovessi scrivere di “Per ora la chiameremo felicità ” lo farei esattamente così.
Quattro anni. Pause prolifiche, come se entrambi ci fossimo presi del tempo, per far cose, per far accadere cose. Trent’anni per Vasco, un quarto di secolo per me. Stiamo crescendo, non so come ma stiamo crescendo. Nuove “Costellazioni” e la consapevolezza che, con gli anni, si possa diventare un insieme di violenze e di speranze.
Quando tutto sembra scivolare giù e senti il fondo del baratro a pochi centimetri da te ma, nonostante tutto, nel disastro il futuro era sempre lì a sorriderci. Quando passano gli anni ma l’hard disk interno non cede, trattiene tutto e tutti e l’attività mnemonica e interpretativa dei sogni vacilla inesorabilmente.
Perchè gli anni passano ma in fondo non stai lì ad aver grosse pretese.
Prototipi di cyberdonna che mai avrei voluto accanto. A me sarebbe bastato stare bene con lei,
quella ragazza “normale” al computer che terrebbe lontane quelle crisi di passaggio che porto avanti con il mondo da lustri ormai. Quella ragazza al computer che ascoltava gli Smiths e i Sonic Youth, ascolti capaci di aprire e chiudere strade che ci portano al mare. Quel mare che si muove un po’ allo stesso ritmo dell’amore e viceversa, ti porta giù, smettere di respirare per poi respirare. E poi rimettersi in macchina,
lasciarsi dietro il litorale e finire in quel bar sulla via Lattea, passando sotto i piedi del ponte di Calatrava, di notte, quando cammini sul ciglio della strada con una discoteca nell’anima.
Quando è notte e si alza il vento, che se la tagliassero a pezzetti Eolo li disperderebbe.
Quando è notte, sogni assurdi che si avverano e scontri tranquilli, capacità di essere felici da fare schifo camminando per 40km, cercando le coordinate nel cielo per ritrovarla.
Trovarla, finire a fare l’amore e far credere al mondo che sia danza contemporanea”…
Se dovessi scrivere di “Costellazioni” lo farei esattamente così.
Come un lungo viaggio, in mezzo al mare, dopo anni di acqua salata scorgi all’orizzonte qualcosa.
Urlare “Terra” può diventare quasi eccitante. Toccare con mano il frutto della fatica,
sentirsi Ulisse dopo anni lontani da Itaca e finalmente rivederla. Vedersi addosso i segni degli anni a cercarsi, a cercarla, cicatrici a forme di fulmine, inseguire cuori irraggiungibili e avere tutto da vincere e nulla da difendere.
Stare fermi, stare qui, dopo averla rassicurata e nel frattempo è arrivato il futuro.
Toccare “Terra” e accorgersi di essere ritornati in una bella e malandata Europa multiculturale,
dove i nostri baci sono silenziosi come certi aerei militari, cercando di capire la connessione tra il tuo nome e quell’uragano che ha raso al suolo il Nord America. Poi scappi ancora, poi vuoi tornare. Non ti trovo, lancia dei razzi di segnalazione per cercare di distinguerti tra la folla. Ti vedo e mi allontani, maledico i tuoi vent’anni. Cerco un posto dove il wi-fi non possa ferirmi, dove possa godere del diritto alla segretezza, alla distanza e alla tenerezza.
Sono solo ormai ma ti sogno lo stesso e tu sei in città , stai per allagare e nonostante tutto sei lì,
pronta a baciarmi sul portone e mi sento assolto dal male. Ormai la tua voce la sento soltanto dalle conchiglie, forse perchè vivo dalla parte sbagliata delle acque territoriali. Forse avrei voluto soltanto morire con te o, forse, viverci tutta la vita.
Morirò e lo farò con il cruccio che non mi sarai mai bastata, ti aspetto nel deposito delle anime.
Intanto resto solo, conto i secondi tra i lampi e i tuoni e cerco di capire quanto distino i temporali e i bombardamenti. In fondo eri tu quella a casa, da sola, con il palazzo di fronte a 3 metri ma capace di vedere orizzonti infiniti. Allora via, via, via per un altro viaggio disorganizzato.
Pianificazione a breve periodo, al massimo due anni”…
Quando un tuo amico parte lo accompagni in stazione, prendi quelle valigie cariche di emozioni provate negli ultimi dieci anni e gli auguri di rinascere, tornare ed emozionarti. Perchè quando un amico ti accompagna per una durata del genere non può fare altro, un po’ te lo deve”…
Per toccare “Terra” insieme, ancora una volta, magari in altre vesti ma farlo ancora.