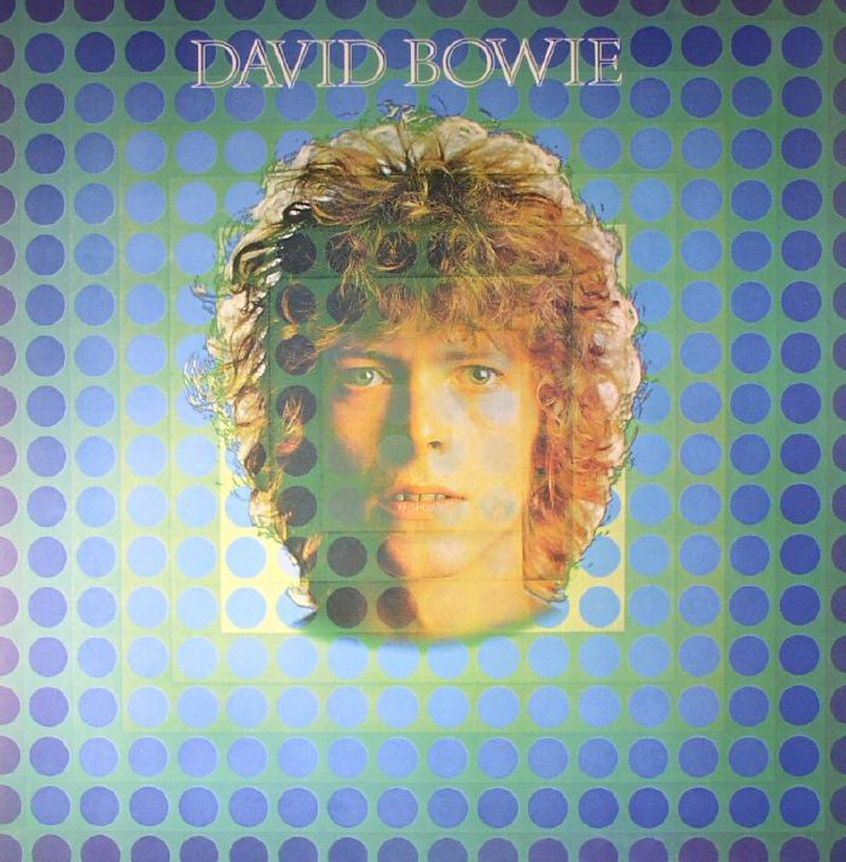Chiariamoci, non che questa cosa sia un sigillo di eternificazione o l’estremo omaggio ad una band ormai leggendaria, poichè i Cure a parer mio non ne hanno bisogno, ma indubbiamente l’ammissione nella Hall of Fame ufficializza, se così possiamo dire, la loro posizione e il loro talento da qui alla fine del mondo. Al Barclays Center di Broooklyn, a New York, Robert Smith e compagni hanno suonato cinque pezzi: “Shake Dog Shake”, “A Forest”, “Love Song”, “Just Like Heaven” e “Boys Don’t Cry” senza risparmiarsi come sempre e mentre ne vedevo le gesta sul web ho pensato che qui non si tratta di semplice musica, non si tratta di aver scritto e suonato una manciata di album tra i più belli e intensi della storia del rock, no, qui parliamo di una summa di fatti: estetica, talento, perizia tecnica, un modo del tutto personale di vivere il music business e sopratutto essere la moda, per quel che voglia dire questa parola, non seguirla.
Robert Smith è icona, ma nel senso più sacrale del termine, egli è colui al quale, noi fanatici musicisti e/o fruitori dobbiamo almeno cinque, sei generi musicali. E poi, finiamola una buona volta di accostarli alla musica dark o almeno rendiamoci conto che i Cure non sono stati solo questo e se lo hanno fatto ne sono stati degni alfieri agli inizi per poi diventare semplicemente se stessi.
Rozzi e post punk in “Three Imaginary Boys” con pezzi come “Another Day” o “Grinding Halt” per dire, così scuri e decadenti in “Seventeen Seconds” con perle come “A Reflection”, “Play for Today” e l’acclamata “A Forest”. Un elenco impossibile da citare, ma allo stesso tempo così pieno di cose, così visceralmente imprescindibile. Il dolore scuro di “Pornography”, dolore anticipato già dal precedente “Faith”, ci consegna dei Cure dal sound oppressivo e lancinante proprio mentre in quegli anni la new wave tocca il suo apice con gruppi leggendari. “One Hundred Years”, “A Short Term Effect”, “The Hanging Garden”, “Cold”, “A Strange Day”, sono marchi a fuoco indelebili di cui non possiamo fare a meno e pare bizzarro che una band di cotale spessore sia passata alla storia, per la massa, per i brani facili ed easy (comunque dei capolavori, diciamolo) quali le solite “Just Like Heaven”, “Boys Don’t Cry” e “Lullaby”.
Chi è Robert Smith? E’ un genio schivo, tecnicamente dotatissimo, ma troppo pigro per ammetterlo o dimostrarlo tanto da circondarsi sempre di virtuosi delle sei corde (il mio mito Porl Thompson su tutti); un paroliere di fine ricercatezza che ti colpisce al cuore con immagini desolanti e parole che ti fanno dire quando le canti e le ascolti: si, è così, così deve essere. Ma è anche immagine inconfondibile con quei capelli sparati a mò di spaventapasseri, gli occhi cerchiati di nero e le labbra rosse, lì sul palco immobile con quella voce romantica, lacrimevole, ma così infinitamente rassicurante. Robert diventa negli anni Edward mani di forbice, ispira Eric Draven nel Corvo di James O’Barr e dà la stura ad un modo di presentarsi sul palco imitato da tanti. “The Head on the Door”, “Kiss me Kiss me Kiss me”, “Disintegration”, album che ci regalano canzoni come “If Only Tonight We Could Sleep”, “Icing Sugar”, “Plainsong”, “Pictures of You”, “Prayers for Rain”, fino all’album, ultimo grande capolavoro assoluto, che anticipa il dream pop e lo shoegaze stesso in alcune soluzioni: “Wish”.
Il mai perdonato (da me), ma coraggioso, “Wild Moon Swings”, “Bloodflowers” che evoca antichi fasti e genera sussulti ammalianti come “The Last day of Summer”. I Cure, o per meglio dire i Cure di Robert Smith, visti gli avvicendamenti continui di formazione, non sono una delle band che… no, i Cure sono LA band che… I Cure evocano tutta la malinconia che ci portiamo dentro, ma sempre illuminata da un pallido raggio di sole. Non mi importa se son diventati quasi una sorta di parodia ormai, se quello spaventapasseri ha i capelli radi e il fisico pesante e imbolsito perchè dal vivo, quando le luci si spengono e c’è penombra, basta ascoltarne la voce, sentire il basso pulsante di Simon Gallup e mi ritrovo catapultato in un mondo magico.