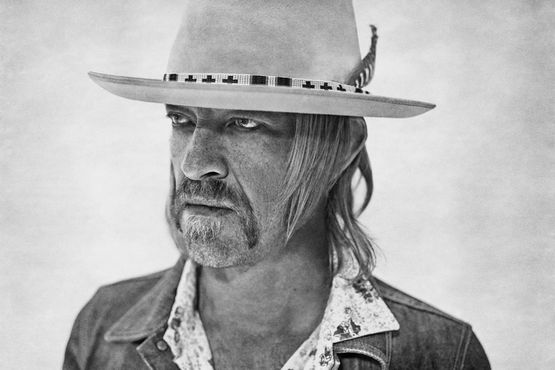I These New Puritans continuano la loro quieta ascesa in un inafferrabile empireo di art-rock lontano da ogni trend musicale. La band ormai si compone dei soli fratelli Barnett, ma questo non ha scalfito lo smalto della proposta sonora e concettuale marchiata TNP.
Non solo: personalmente ho trovato questo album il più “godibile” della saga dei gemelli più austeri del rock arty inglese. L’intento della band, all’indomani del riuscito esordio “Beat Pyramid”, è stato quello di allontanarsi sempre di più da quell’iniziale aura da nu-new wave avanguardistica, per ricercare un sentiero musicale solitario, autarchico, poco inclusivo e dalla bellezza algida.
“Bellezza” è proprio la prima banalissima parola che mi salta in mente percorrendo le sinuose pieghe notturne dei brani che compongono un quadro sfocato, liquido, così carezzevole e duro, monolitico al contempo.
Il precedente “Field of Reeds” picchiava duro sul lato puramente avanguardistico, dilatando gli scenari sonori della band fino a farli arrivare a confini di pura autarchia sonora, imbevuta di pacato sgomento, seriosa quietudine mitteleuropea e boreale estasi. Qui siamo di fronte ad un affresco artistico molto più romantico e penetrabile, nel quale ravvediamo l’incontrarsi flessuoso di vivide trame quasi-urban, intuizioni post- come di un Mark Hollis gotico, eleganti spezie elettroniche, tappeti sinfonici di tersa tetraggine, l’usuale afflato sperimentale avvinto in un clima sempre più esoterico, con lo sguardo rivolto a dimensioni altre innominabili e le membra stregate da immarcescibili tentazioni terrene, tra versi sibillini sullo smarrirsi e ritrovarsi, odi ad un assoluto relativo, da raggiungere attraverso un’intimità amniotica.
Prevale una ricerca tesa a quella che, a conti fatti, sembra proprio la necessità di un dilatamento spaziale, grazie ad architetture che germogliano nell’ambiente psicologico, percettivo e sonoro noncuranti dell’oscurità che le avvolge e le potrebbe relegare ad esiti meramente claustrofobici. Si parte dalle intuizioni e inclinazioni di vecchi brani come “5”, “Organ Eternal” e “Fragment Two” per creare tracce di sontuoso algore generalmente poco ritmiche e liquidissime (l’immagine di copertina è quantomeno azzeccata), fatta eccezione per le belligeranti ““ a loro modo ““ “Infinity Vibrations” e “Into The Fire” (che reca il prestigioso featuring di David Tibet) e la deliquiosa “Anti-Gravity”. Si va dalla carnale plasticità di pezzi come “Beyond Black Suns” e “Inside The Rose” alle avvolgenti volute siderali di “A-R-P” e “Six”, e in mezzo un nero pozzo di emozioni intrappolate in un magma misterico, in realtà sottile e luminescente come cristallo, attraverso il quale scintillano colpi di vibrafoni e ariose folate di archi.
“Inside the Rose” mostra i segnali di un’evoluzione artistica apparentemente inarrestabile: sarà sicuramente tra i dischi dell’anno, se non il disco dell’anno.