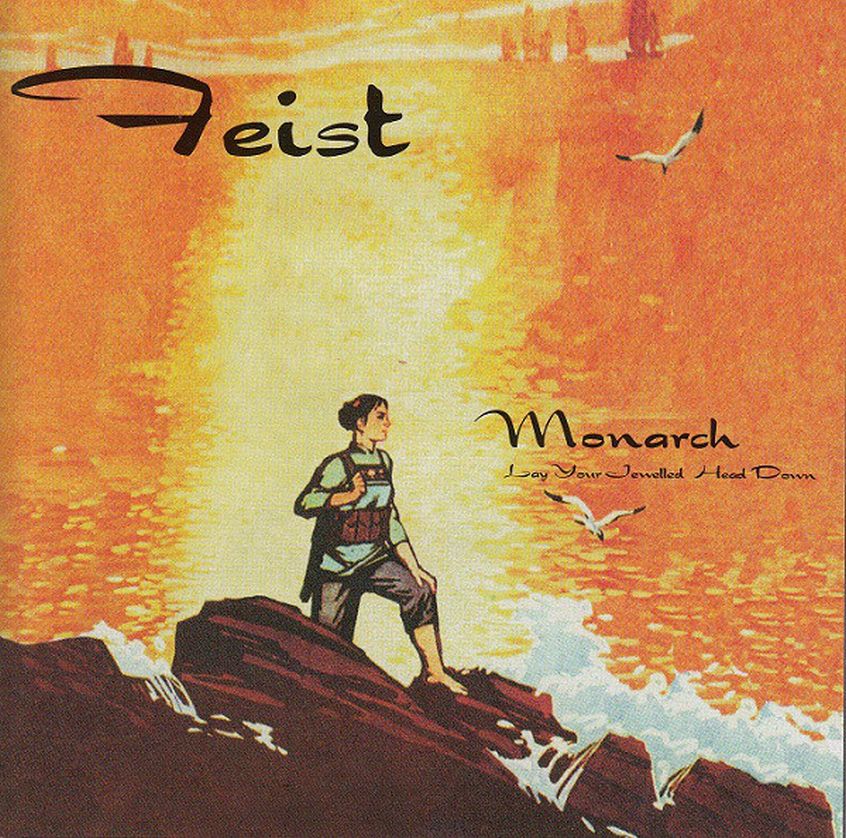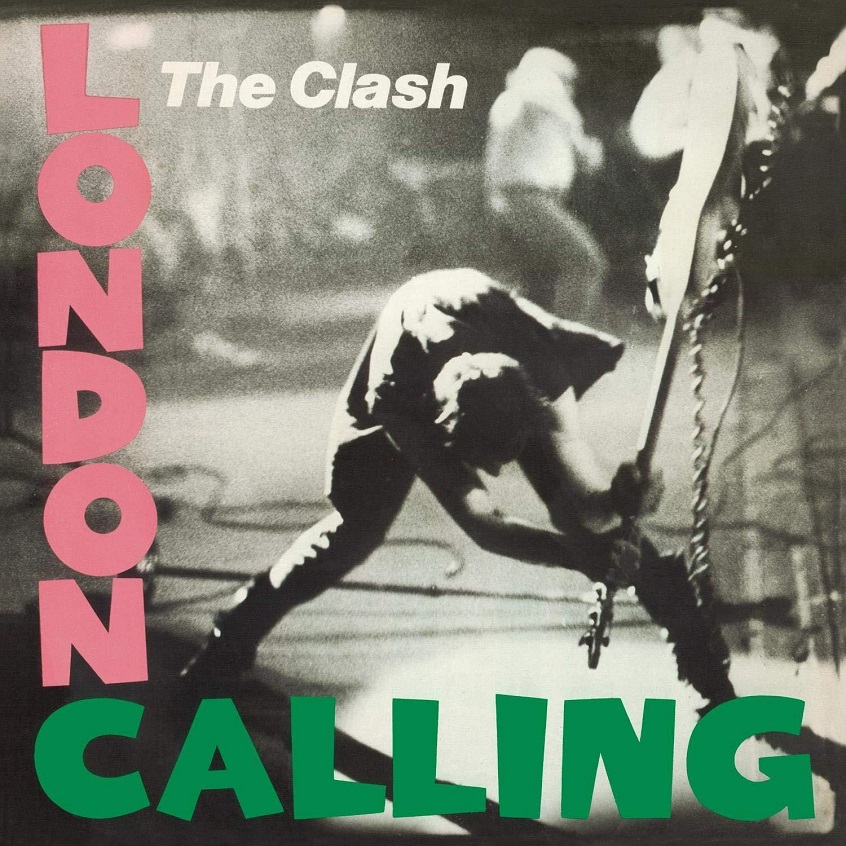Ricordo benissimo la prima volta che sentii la cassettina (e sì, erano decisamente altri tempi!) di “To Bring You My Love” della (già ) divina PJ Harvey, quella sensazione forte, come se qualcosa mi avesse scosso nel profondo, toccato dentro il mio animo di adolescente (avrei compiuto 18 anni da lì a qualche mese). Mi pare impossibile sia passato un quarto di secolo ma andando a ritroso è certo che di acqua ne sia passata sotto i ponti, non solo nella mia vita, o in quella dell’artista del Dorset, ma proprio nel mondo della musica.
Eppure, oggi come allora, l’ascolto di questo album, così oscuro, deviato, aggressivo, non può lasciare indifferenti. Polly Jean era ancora molto giovane nel 1995 quando pubblicò il suo terzo album ma era già riuscita a creare molta curiosità e aspettativa attorno a sè e alla sua proposta musicale, così scarna, diretta, viscerale e che sembrava idealmente riallacciarsi a un’epoca lontana ma viva più che mai.
Magra, minuta, è diafana o strega, magnificamente fascinosa e senza peli sulla lingua, sin da quando in trio ti buttava in faccia le sue canzoni a colpi di punk e schitarrate selvagge. E con quell’attitudine aveva finito per stregare non solo in modo unanime la critica specializzata ma pure una flotta sempre crescente di fans, raccogliendo finanche gli apprezzamenti di celebri colleghi, fra tutti Kurt Cobain che non volle perdere occasione di vederla esibirsi in concerto.
“Dry” nel 1992 fu un esordio di notevole impatto, a cui fece seguito a distanza di un solo anno l’altrettanto urticante “Rid of Me”, se vogliamo ancora meno disposto a scendere a compromessi con il mercato discografico. Poco importa, nel mercato la nostra PJ aveva fatto irruzione in modo naturale, senza cercare scappatoie o facili consensi, semplicemente esprimendo se stessa e tutta la sua forza compressa in quell’esile corpicino.
I suoi primi compagni di viaggio, Rob Ellis e Steve Vaughan (seppur funzionali e sul pezzo) quasi scomparivano dinnanzi alla sua potenza espressiva, che nei live si manifestava anche nel look, con cui in quel periodo le piaceva giocare.
Tutto sembrava mutato però all’altezza del terzo album, quello che col senno del poi ne sancì la piena affermazione. Cambiarono in primis i collaboratori, e di fatto ufficialmente il nome PJ Harvey divenne quello di una solista vera e propria, ma a differenziare questo lavoro dai precedenti furono soprattutto le circostanze e gli eventi, con la Nostra che dichiarò in una nota intervista che mentre scrisse le canzoni di “To Bring You My Love” si sentiva letteralmente “persa”.
Nemmeno la scrittura fu la stessa, così come diverso fu il modus operandi nella composizione e, soprattutto, il topos letterario: le tematiche scelte, il suo “mondo” interiore per essere proiettato al meglio e condiviso aveva necessariamente bisogno di un vestito più adatto. E gli abiti per forza di cose non erano più quelli scarni ed essenziali (concedetemi la metafora) del punk/garage rock degli inizi ma presentavano più strati, più rifiniture.
La musica infatti si fa complessa, ancora più aspra e acida, e non poteva essere altrimenti, visto che PJ Harvey ci consegnò una raccolta davvero pregna di significati e di rimandi, una scaletta densa dalla prima all’ultima traccia, per un’atmosfera elettrica, tesa, con nessuna ma propria nessuna concessione alla luce e alla melodia più rassicurante.
E’ una artista consapevole delle sue fragilità , della sua femminilità e dei suoi desideri, sulla piena strada della maturità e che non teme (ma di fatto non le è mai mancato il coraggio) di mostrarsi per quello che è, anche quando si tratta di scendere a patti col diavolo o di profanare un Dio. Emblematica in tal senso è la prima canzone, quella che intitola il disco, e che lo introduce con i suoi suoni marziali, rallentati, in un blues rock scarnificato e moderno che ci fa immergere prontamente nel mood dell’intera opera.
La successiva “Meet Ze Monsta” non attenua il clima obliquo, anzi come in un climax ascendente delinea le coordinate dell’album, con la cantante nei panni di un’oltraggiosa ninfomane. In “Working for the Man” i toni cambiano ma attenzione a non farsi ingannare dalle vesti dimesse della protagonista, intenta com’è a mostrare la sua vera faccia all’uomo che non sembra amarla come meriterebbe.
“C’mon Billy” è con ogni probabilità il brano più diretto del disco, e qui la figura femminile è quasi antitetica a chi l’ha preceduta, con le sue tenaci esortazioni all’uomo che ama. Polly però ama giocare con i controsensi e difatti anche qui scopriamo in realtà che la forte donna è invero implorante il ritorno a casa dell’amato che l’ha lasciata dopo averla messa incinta. Con “Teclo” si ritorna a un blues carico di suggestioni che ci conduce in un impervio viaggio negli inferi e che sembra anche idealmente allacciarsi con il successivo episodio “Long Snake Moan”, anch’esso giocato su paradossi ed efficaci, quanto cruenti, simbolismi.
In questo modo l’artista “maledetta” prepara il terreno per “Down by the Water”, canzone cardine dell’album, quella che non è assolutamente sbagliato definire una murder ballad: sì, proprio una di quelle che da lì a un anno avrebbe egregiamente divulgato in un album epocale il cantautore australiano Nick Cave, tra l’altro invitandola a collaborare in un brano. D’altronde erano già in molti quelli che associavano PJ a Cave, in modo alquanto preveggente poi, se pensiamo che avrebbero fatto coppia per qualche anno nella vita!
Tornando all’episodio citato, “Down by the Water” nascondeva dietro a un fatto abominevole (una madre che affoga la propria piccola creatura in un fiume) una potenza evocativa incredibile e una personalità di artista e musicista davvero pronta a prendersi la scena, anche narrando storie che avrebbero potuto allontanare le luci dei riflettori. Luci che al contrario divennero abbaglianti, sin dal video che accompagnava il singolo in questione, già magnifico per arrangiamento e interpretazione.
Il resto della scaletta non può gareggiare per impatto emotivo ma se possibile si erge ancora di più per pathos e impeto, dalla dichiarazione d’intenti “I Think I’m a Mother”, sorta di litania che sembra provenire dall’oltretomba, all’intensa, struggente, commovente “Send His Love to Me” (in cui l’artista ci appare finalmente umana con tutte le sue imperfezioni e debolezze), fino alla sensualissima e onirica “The Dancer”.
L’album fu senza dubbio una bella botta a un primo ascolto, certamente non facile ma fu, come dire, capito e in seguito apprezzato ad ogni latitudine, lanciando in orbita il fenomeno PJ Harvey, artista che seppe diventare presto pietra di paragone ed esempio da seguire per tante aspiranti rockstar.
Il successo lo ottenne in modo fragoroso e nemmeno troppo inaspettatamente in fondo, poichè erano tempi in cui il rock era oltremodo centrale nella vita di tante persone.
Fu un exploit da oltre un milione di copie quello di “To Bring You My Love”, in cui tutti gli ingredienti finirono miscelati nel modo giusto, a partire dalla squadra formata con i produttori – musicisti e poi fidi collaboratori – Mark Ellis (noto come Flood, davvero in auge all’epoca, basti pensare che praticamente in contemporanea a questo disco lavorò anche su “Mellon Collie and the Infinite Sadness” dei lanciatissimi Smashing Pumpkins) e John Parish, il quale diverrà negli anni quasi il suo alter-ego musicale.
Era soprattutto cresciuta lei, capace disco dopo disco di affermarsi e riaffermarsi, esplorando linguaggi e mondi musicali nuovi, e diventando sempre più inafferrabile, lassù, nell’Olimpo del Rock.
PJ Harvey – To Bring You My Love
Data di pubblicazione: 27 Febbraio 1995
Tracce: 10
Lunghezza: 42:27
Etichetta: Island Records
Produttori: Flood, PJ Harvey, John Parish
Tracklist:
- To Bring You My Love
- Meet Ze Monsta
- Working for the Man
- C’mon Billy
- Teclo
- Long Snake Moan
- Down by the Water
- I Think I’m a Mother
- Send His Love to Me
- The Dancer