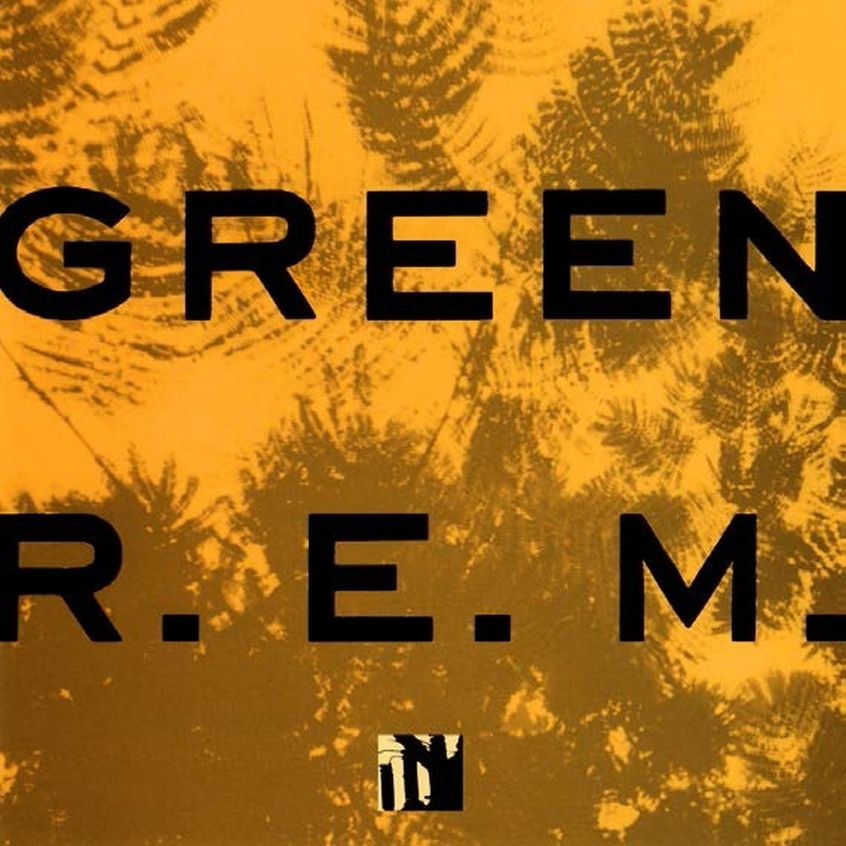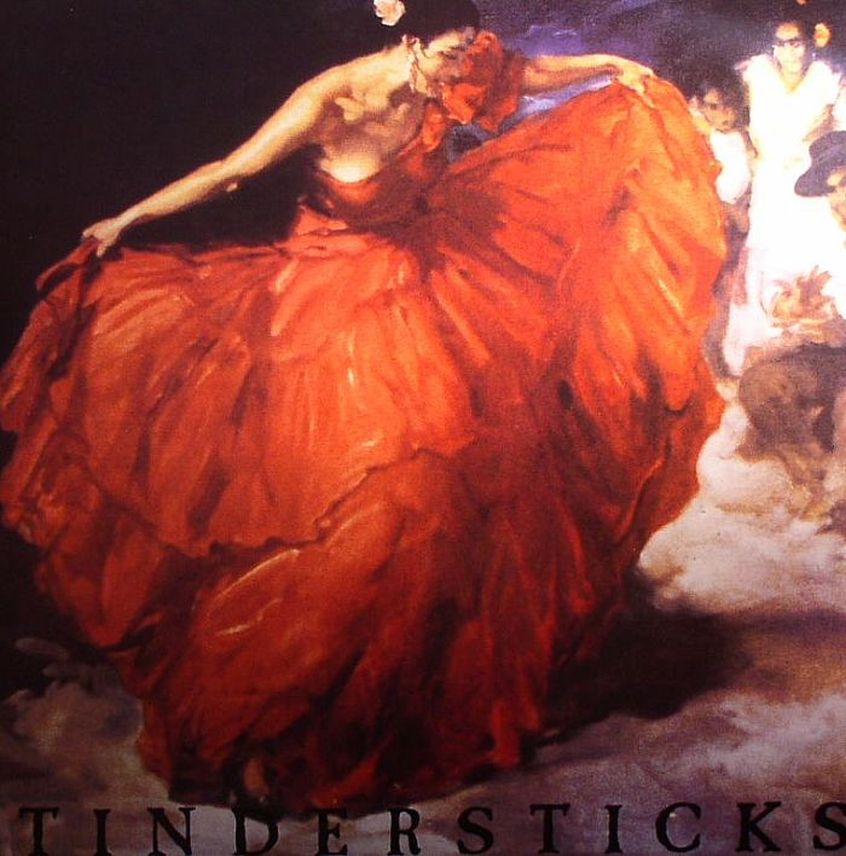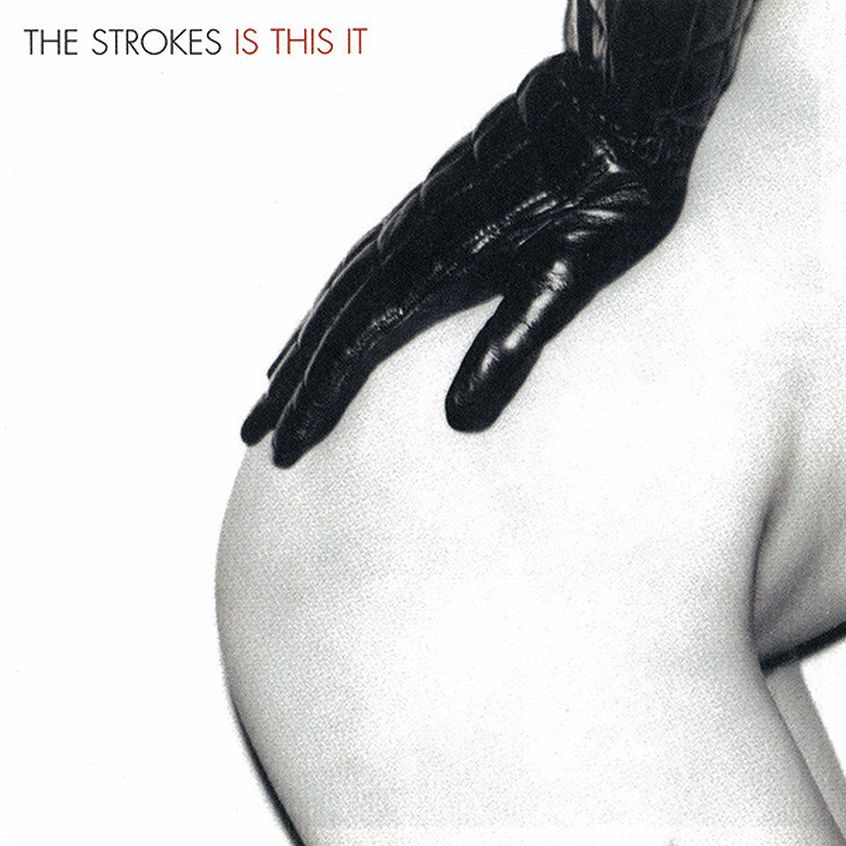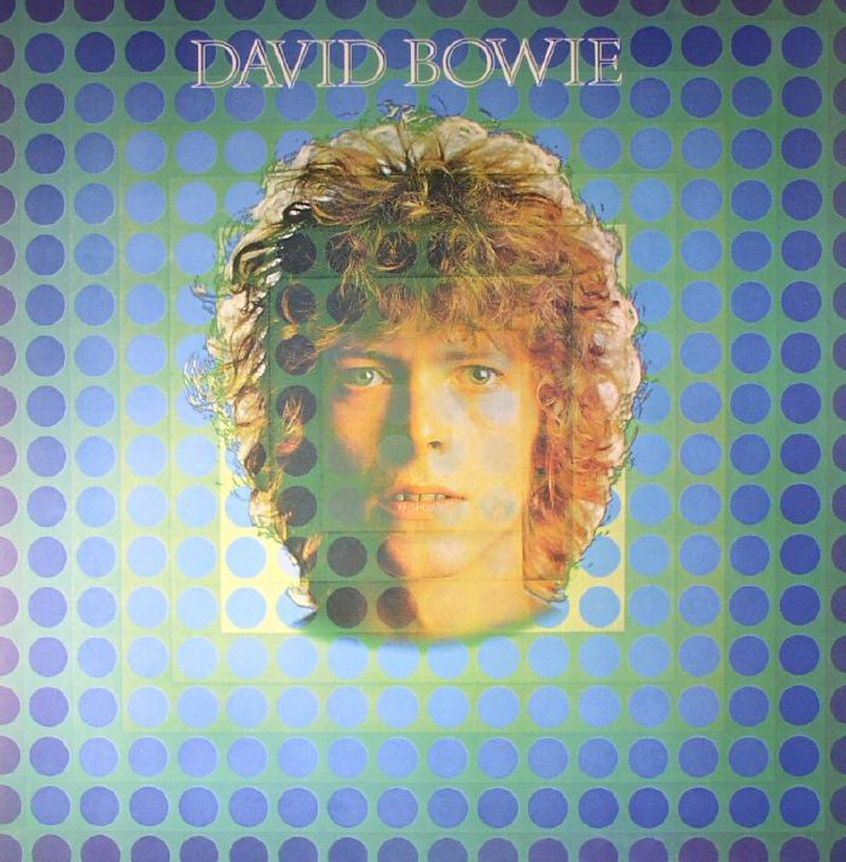Una band sull’orlo di una crisi di nervi: questi erano suppergiù i Verve all’uscita di “A Northern Soul”, secondo mattoncino di una carriera che, numeri alla mano, non era ancora possibile capire come si sarebbe potuta sviluppare.
Già , perchè Richard Ashcroft e soci, sin dal principio della loro avventura (iniziata nel 1993 con “A Storm in Heaven”), non erano facilmente etichettabili a livello artistico, in un periodo in cui la musica inglese stava cercando di accaparrarsi un posto al sole, schiacciata dall’incedere imperioso del grunge, con i gruppi a stelle e strisce dominatori delle charts d’Albione.
L’Inghilterra, all’invasione in jeans e flanella americana, stava rispondendo a suon di baggy e shoegazer, in attesa che fosse poi il britpop – guarda caso in coincidenza con il tremendo sparo di Kurt Cobain che segnò rapidamente il declino di quella corrente musicale – a sparigliare le carte in tavola una volta per tutte.
In mezzo a tutto questo, i Verve furono sempre dei pesci fuor d’acqua, mai associabili direttamente a nessun filone, nonostante poi “Urban Hymns” – loro album della piena consacrazione – sia diventato un istant classic del britpop, facendo vacillare non poco lo scettro dei pesi massimi Oasis e Blur.
La strada per arrivare alla piena affermazione, però, aveva previsto una tappa interlocutoria, rappresentata proprio dalla seconda prova dei Nostri, concepita e realizzata in un clima tutt’altro che sereno.
Riavvolgendo il nastro della memoria, i The Verve (mai come nel loro caso l’articolo davanti non era un vezzo, bensì fu obbligato per evitare guai legali con l’etichetta statunitense di stampo jazz Verve Records) erano reduci da un album affascinante, misterioso e lancinante come il già citato”A Storm in Heaven”, imbevuto di quella magica psichedelia che sapeva tenerlo sospeso in una bolla spazio-temporale, fluttuante e onirico.
Erano le chitarre dilatate e spaziali di Nick Mc Cabe e le argute e sfuggenti melodie di Richard Ashcroft a connotarlo al meglio, finendo così per incuriosire il pubblico, tuttavia non del tutto ancora pronto ad abbracciarli musicalmente.
Non ci fu solo la rivalità sottesa fra i due amici di vecchia data all’origine dei gravi problemi in sala d’incisione per il successore del debut-album: era soprattutto l’abuso di droghe sintetiche (cui non si tiravano certo indietro il bassista Simon Jones e il batterista Peter Salisbury) a minare rapporti interni e resa artistica.
Non tutto fu perduto però, e per fortuna nostra quelle intuizioni musicali (pur tra registrazioni affrontate spesso e volentieri in mezzo a deliri e fughe momentanee) sono infine state fissate su nastro, in un momento in cui sembrava davvero che Ashcroft (soprannominato presto Mad Richard) avesse preso in mano le redini della situazione, causando però l’allontanamento volontario di Mc Cabe.
Le nuove canzoni avevano un respiro diverso, intrise com’erano di spiritualità e del calore di arrangiamenti che prevedevano l’utilizzo di sonorità acustiche e di archi, perfetti per conferire solennità e definire i contorni di un pop rock che si stava delineando e che sarebbe poi sfociato pienamente nel successivo “Urban Hymns”.
Paradigmatico in tal senso è un brano come “History”, che contiene già tutti gli elementi caratteristici che avrebbero contribuito a fare le fortune del gruppo in ambito commerciale. Sonorità piene, maestosi violini a sorreggere il tutto, il cantato di Ashcroft che si fa mantra ipnotico, soave e limpido, la melodia indimenticabile: tutti ingredienti che avrebbero dovuto garantirgli maggiore fortuna.
Come la suddetta canzone, ve ne sono altre che ben disegnano la nuova traiettoria musicale cercata dal gruppo: penso a “On Your Own”, più variegata e policroma o alla sognante e struggente “Drive You Home”.
Altrove emerge prepotentemente l’anima psichedelica di Mc Cabe, nelle strutture ondivaghe di “This is Music” o nella frizzante title track, ma in generale in questo album si è assistito a un pregevole connubio delle due facce di una stessa medaglia, quella ancorata ai primi vagiti della band e quella che si sarebbe sviluppata in seguito.
Perfetti esempi di questa brillante alchimia sono l’energica e coesa “A New Decade”, che apre la scaletta in modo perentorio e la raffinata e intensa “Stormy Clouds”.
Il trend iniziale dell’album fu positivo, con i singoli “This is Music” e “On Your Own”, per non dire di “History”, in grado di lanciarlo in top 20 ma nel frattempo, al posto del dimissionario bizzoso chitarrista, era giunto in sostituzione l’eclettico Simon Tong per portare in tour i brani di “A Norther Soul”. Poco prima il leader aveva già sciolto la band per poi riunirla nuovamente e ispirare un brano struggente come “Cast No Shadow” all’amico Noel Gallagher degli Oasis, che verrà poi inserito nel loro epocale “(What’s the Story) Morning Glory?”.
Credo nessuno nel 1995 si sarebbe potuto immaginare che da lì a un paio d’anni Richard Ashcroft, riassestata la band in un quintetto con il reintegro di Nick Mc Cabe, l’avrebbe condotta verso l’empireo della pop music ma è indubbio che, riascoltando col senno di poi “A Northern Soul”, ci fossero già tutti i prodromi per un simile exploit.
The Verve – A Northern Soul
Data di pubblicazione: 20 giugno 1995
Tracce: 12
Lunghezza: 62:59
Etichetta: Hut Recordings/Virgin
Produttori: Owen Morris, The Verve
Tracklist
1. A New Decade
2. This Is Music
3. On Your Own
4. So It Goes
5. A Northern Soul
6. Brainstorm Interlude
7. Drive You Home
8. History
9. No Knock on My Door
10. Life’s an Ocean
11. Stormy Clouds
12. Reprise