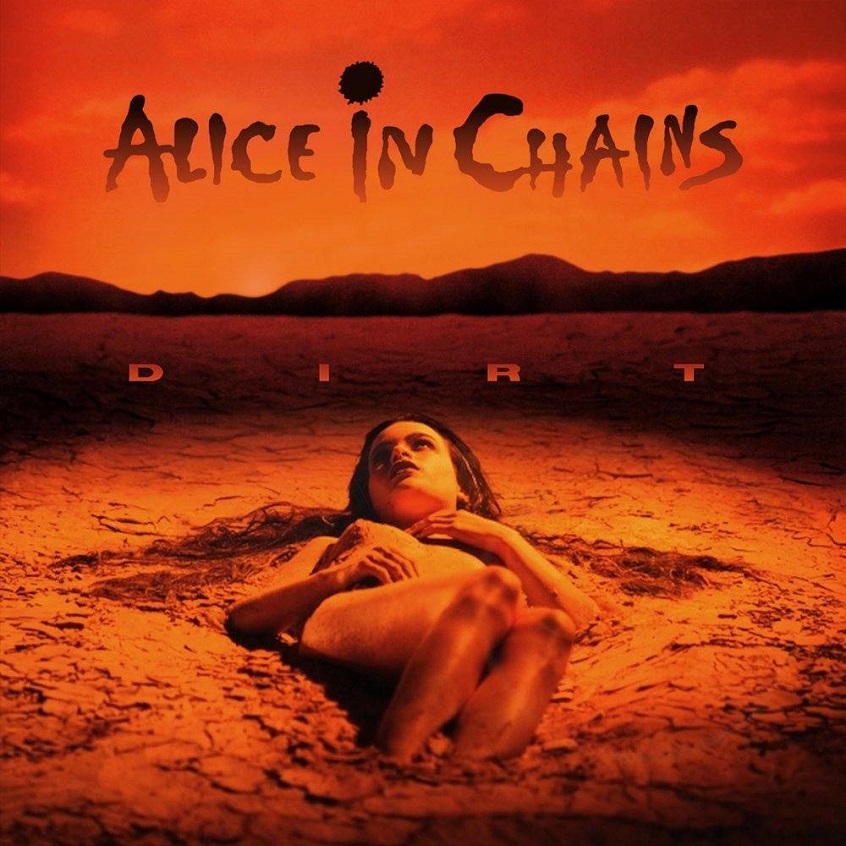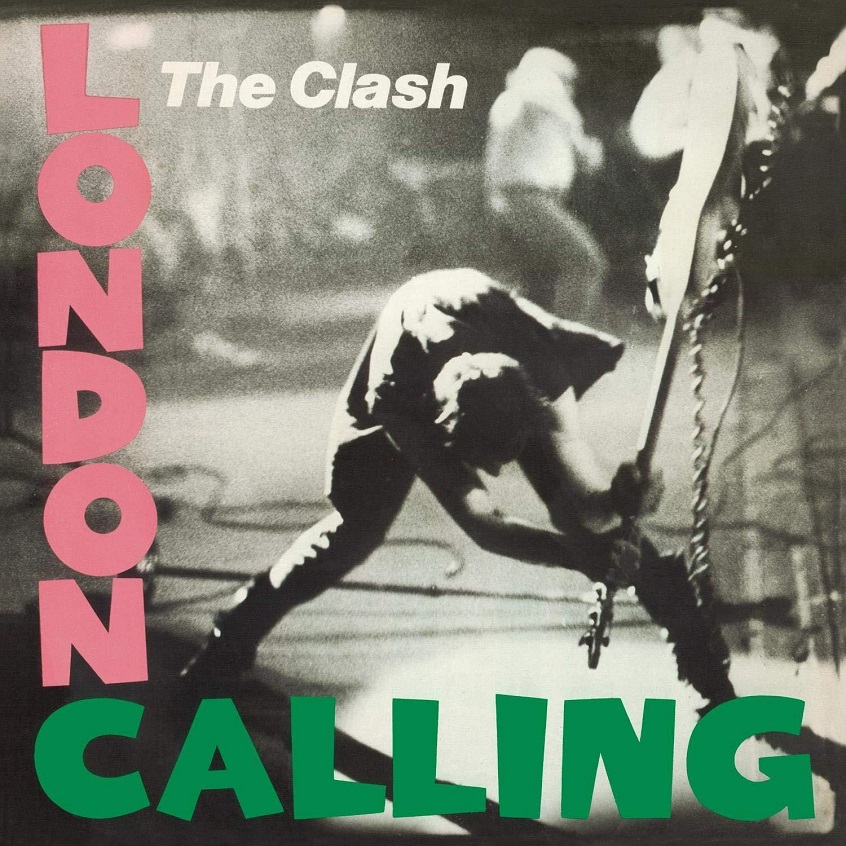Abbiamo recentemente analizzato le origini post-punk di uno dei gruppi pop di maggior successo degli anni ’80, i Simple Minds di Jim Kerr e Charlie Burchill. La loro improvvisa rivalutazione (qui un bell’articolo di Rolling Stone) mi ha lasciato abbastanza basito: ascoltavo questo gruppo da ragazzino, quando non se li filava nessuno (a quei tempi era tutta campagna, grunge e brit-pop), e questa riscoperta non può che farmi piacere.
Comunque, dopo quella fase a metà strada fra avanguardia tedesca e glam-pop, la band scozzese passò dall’Arista alla Virgin e si tramutò in uno dei nomi del nuovo romanticismo britannico, dediti ad un proto-synthpop che fruttò gli album migliori della carriera: “Sons and Fascination / Sister Feelings Call” (1981) è un magniloquente esercizio di stile su atmosfera e ritmo, ma non disdegna i primi refrain accattivanti; “New Gold Dream” (1982) è il lavoro che rende ragione al mito, e fissa il loro standard in un art-pop sinuoso, liquido e seducente; “Sparkle in the Rain” (1984), curato dal produttore degli U2, Steve Lillywhite, gira la manopola del volume e trasferisce quel format dai palazzetti agli stadi.
In effetti, all’inizio del 1985 i Minds erano già un nome di grido nel panorama europeo, ma i tentativi di penetrare anche le charts americane erano stati deludenti. Il caso volle che un brano che doveva finire nella colonna sonora di un film cult per adolescenti, “The Breakfast Club” (che, mi permetto di aggiungere, è davvero ben fatto e merita una visione), fosse stato offerto alla band, che gentilmente declinò l’invito. Il motivo? Troppo pop.
L’intercessione di Chrissie Hynde (cantante dei Pretenders) fece addivenire a più miti consigli il marito (Kerr), e i Simple Minds ne registrarono una nuova versione che sbancò le classifiche di mezzo mondo. Quel pezzo era “Don’t You (Forget About Me)” e cambierà per sempre la storia di un gruppo che, ringalluzzito, assaporò uno sbarco oltreoceano in grande stile.
Il piano d’attacco al pubblico americano passa innanzitutto per la scelta dei collaboratori: Jimmy Iovine, ingegnere del suono di Bruce Springsteen e produttore di classici come “Damn the Torpedoes” di Tom Petty e “Easter” di Patti Smith, era la testa di ponte per intingere il sound nell’umore heartland-rock e scaldare i cuori yankee; e pure Bob Clearmountain, anch’egli al lavoro col “Boss“, oltre che con David Bowie e Bryan Adams, da par suo, sapeva bene come eccitare le arene degli anni ’80.
Sostituiti i sintetizzatori con un più cristallino pianoforte, sempre in evidenza, sterilizzata in formato dance-rock ogni insidiosa fuga in avanti, e adottate alcune scelte conservatrici in tema di arrangiamento (la voce nera Robin Clark al controcanto, i tanti la-la-la, pa-pa-pa, baram-bam-bam a chiudere i cori), “Once Upon a Time” è un disco col dichiarato intento di scalare le classifiche. Ci riuscì benissimo.
Gli scozzesi, d’altra parte, hanno molte frecce al loro arco: anzitutto lo straordinario talento melodico di Michael McNeil, che intrattiene le corti come un musico barocco; Burchill, che è tutto fuorchè un virtuoso della chitarra, conia invero un trademark fra i più riconoscibili del decennio; e Jim Kerr, in stato di grazia, è in quegli anni uno dei frontman più magnetici ed idolatrati dalla “MTV Generation”. Si perde invece la sezione ritmica, orfana di Derek Forbes e interamente delegata al battito metronomico e muscolare di Mel Gaynor.
La rincorsa agli U2 è esplicita nelle chitarre di “Ghostdancing”, con Burchill novello The Edge e le solite scorrazzate di McNeil a confezionare uno dei passaggi meglio riusciti. Poi “All the Things She Said” e “Sanctify Yourself”, due impeccabili numeri che giammai rinunciano a far salticchiare il pubblico. Chiude la rosa di hit l’arcinota “Alive and Kicking”, ma c’è spazio anche per la title track e soprattutto “Oh Jungleland”, una sferragliante scorribanda che è forse l’episodio più rappresentativo (se non il migliore) di questa mutazione genetica a stelle e strisce.
Ogni brano è costruito minuziosamente per accumulo graduale degli strumenti, con l’inalberarsi in un ritornello corale, lo sciogliersi in una pausa strumentale, e l’esplosione nel gran finale col sing-along collettivo. Questo genere di rock da stadio, alla ricerca del ritornello epico e sorretto da ritmi chiassosi e sincopati, verrà chiamato “Big Music” e interesserà una selezionata platea di gruppi britannici non inglesi (gli altri scozzesi Waterboys e Big Country, i gallesi Alarm, e gli irlandesi più famosi di tutti, i soliti U2).
Dopo “Don’t You” e quest’album, i Simple Minds divennero uno dei gruppi più acclamati a livello mondiale: il loro disco live del 1987 (“Live in the City of Lights”) battè ogni record di vendita un istante dopo essere stato annunciato. Purtroppo il germe del politicamente corretto e del terzomondismo peloso si saldò appassionatamente con la “fame di fama” di Jim Kerr. “Street Fighting Years” del 1989 (l’ultimo con McNeil alle tastiere: a posteriori, il suono dei Minds era al 51% suo) gioca la carta del’impegno politico e dei buoni sentimenti, e lo storno da epico a patetico sarà il giusto dazio da pagare per quel tradimento artistico. Da lì in poi, infatti, la band non riuscirà più a scrivere un solo brano che si ricordi con piacere.
“Once Upon a Time” è, in definitiva, l’ultimo album valido di un gruppo dalla lunga carriera che troppe volte ha cambiato strada, finendo inesorabilmente per perdere le coordinate. Certo, è un album pop. Certo, è un’operazione smaccatamente commerciale. E di certo, non è neppure il loro miglior lavoro. Ma a distanza di 35 anni regala ancora l’intimo piacere di tuffarsi nel bel mezzo di quegli anni ’80 tanto bistrattati, ma che alla fine quasi tutti ci portiamo nel cuore come vezzo nostalgico.
Data di pubblicazione: 21 ottobre 1985
Registrato: Townhouse Studios (Londra)
Tracce: 8
Lunghezza: 40:12
Etichetta: Virgin (distribuito negli USA dalla A&M)
Produttori: Jimmy Iovine e Bob Clearmountain
Tracklist
1. Once Upon a Time
2. All the Things She Said
3. Ghostdancing
4. Alive and Kicking
5. Oh Jungleland
6. I Wish You Were Here
7. Sanctify Yourself
8. Come a Long Way