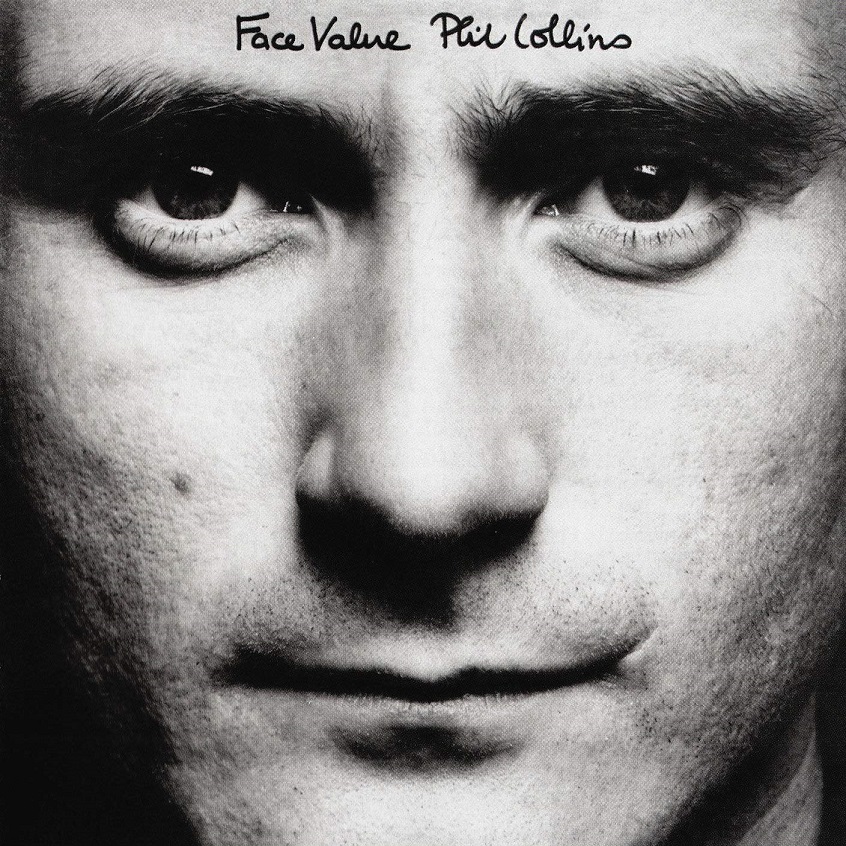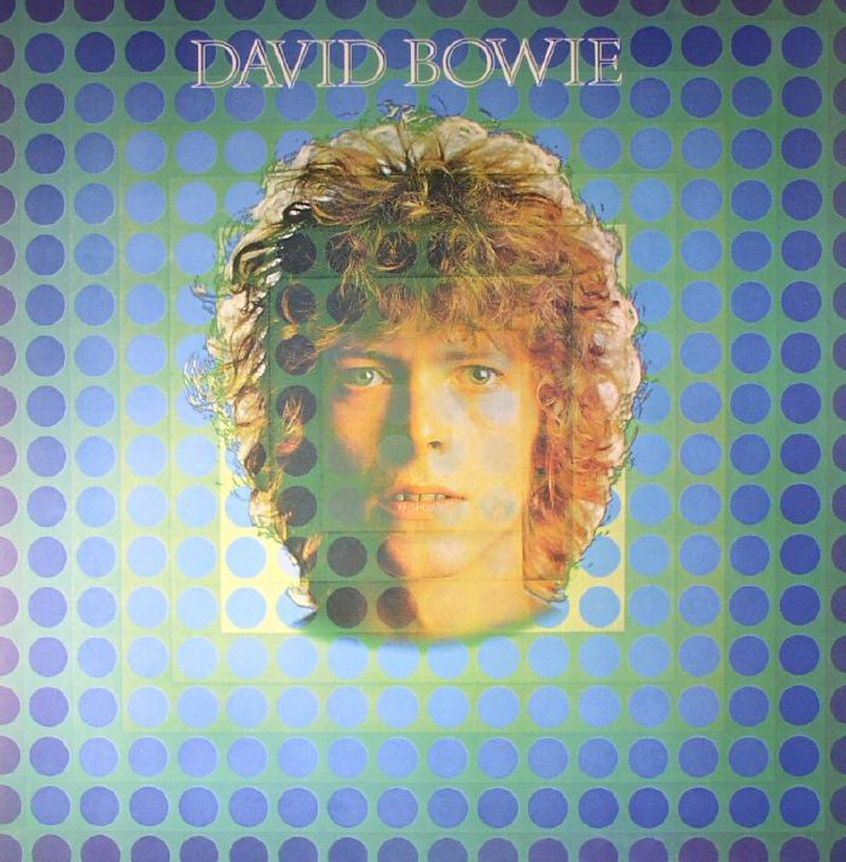In genere, riferendosi a un album come “All That You Can’t Leave Behind” degli irlandesi U2 (che, pubblicato il 30 ottobre del 2000, compie oggi vent’anni), ci si divide fra due correnti di pensiero: chi lo considera come il primo inequivocabile passo falso della gloriosa band, che si protrarrà inesorabilmente fino alle irrilevanti derive attuali, e chi invece lo relega a ultimo bagliore di luce, lavoro tuttavia accettabile prima dell’inevitabile e repentino declino artistico.
Qualunque fazione volessimo appoggiare, il risultato cambierebbe sostanzialmente poco: l’album, il decimo di Bono e soci, pur con delle attenuanti, mostra scarsa ispirazione e ancor meno personalità , e in tutta sincerità fa specie considerando come l’empatia, il pathos e l’intensità (oltre che la spinta innovatrice) siano state da sempre caratteristiche salienti e peculiari del quartetto, sin dalle loro primordiali e lontanissime esibizioni.
Non mi sento di giudicare brutte le undici canzoni che lo compongono (nè tanto meno se a queste aggiungiamo quella “The Ground Beneath Her Feet” – invero splendida – , precedentemente composta per la colonna sonora del film “The Millior Dollar Hotel” e poi recuperata in alcune versioni del disco a mo’ di traccia bonus), ma sembra mancare loro l’anima, a maggior ragione riascoltandole a distanza di due decenni
Dicevo delle attenuanti, e lo ribadisco pur rendendomi conto che si tratta di un esercizio in fondo pleonastico (oltre che applicabile alla maggior parte dei gruppi in sella da quarant’anni come nel loro caso): non era certo facile a quel punto della carriera estrarre dal cilindro un ulteriore capolavoro, continuando ad alzare un’asticella come inesorabilmente era stato fatto dai primi vagiti musicali, arrivando a percorrere amabilmente tutti gli anni novanta.
Gli U2 del nuovo millennio si trovavano a un bivio, reduci com’erano dalla sbornia di suoni e ritmi che risponde al nome di “Pop”, che aveva chiuso un decennio clamoroso a livello di successo commerciale e resa artistica, ed elevato all’ennesima potenza il concetto di modernità e rinnovamento applicato al gruppo, iniziato nel ’91 con lo splendido (e dal mio punto di vista ineguagliabile) “Achtung Baby” ed enfatizzato dal successivo, futuristico, “Zooropa”.
Negli ottanta invece avevamo assistito entusiasti e rapiti all’ascesa e alla piena affermazione di questi quattro ragazzi partiti da una scuola di Dublino nel 1976 e in grado di conquistare sul campo, a suon di dischi memorabili, il cuore di milioni di appassionati .
Era insomma difficile replicare quei fasti, ma ciò non toglie che, almeno all’epoca, era lecito attendersi qualcosa di più rispetto a un’opera che potremmo definire di restaurazione, o di reflusso, volta com’era (se non altro nelle intenzioni) al recupero di sonorità più acustiche, essenziali e di tematiche più esistenzialiste, senza tralasciare uno sguardo sulla società .
Il disco riesce soltanto a metà a soddisfare questo bisogno, proponendo praticamente in egual misura brani lenti, sulla falsariga di tante ballads presenti nel loro canzoniere passate poi alla storia, e altri veloci, dove se non altro rimane tangibile una certa freschezza e vivacità compositiva (alludo in particolare all’opener “Beautiful Day”, non a caso futuro cavallo di battaglia, mentre decisamente meno riuscita appare “Elevation”, piuttosto pacchiana e confusionaria, seppur baciata dal medesimo successo).
A conti fatti quindi, anche se le precorritrici rimarranno lontane mille miglia (voglio dire, nessuna nuova “With or Without You”, men che meno una “One” ma direi nemmeno un’epigona della meno celebrata “If God Will Send His Angels” all’orizzonte), sono proprio le canzoni più lente a risultare nel complesso gradevoli e degne di essere ricordate in questa nostra rubrica.
Dall’accorata “Peace on Earth”, a ribadire istanze ecumeniche di Bono dopo il feroce bombardamento dell’IRA nella città nord-irlandese di Omagh che costò la vita a ventinove persone, alla cadenzata e lirica “Walk On”, dedicata all’attivista birmana Aung San Suu Kyi all’epoca costretta agli arresti domiciliari; dall’ode amorosa “In A Little White”, con caldi toni soul a quella forse più classica del lotto, vale a dire “Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of”, così intrisa di malinconia e mestizia.
Fu proprio questo brano, uscito come secondo singolo, e dedicato all’amico Michael Hutchence, leader dei coevi Inxs morto suicida tre anni prima, a ottenere nell’immediato il maggior successo, arrivando al numero uno non solo delle classifiche inglesi ma anche in gran parte d’Europa, compresa l’Italia.
Troppo poco però per reggere il peso di un lavoro che, per il resto, si perde in altri episodi meno a fuoco, quasi tutti permeati da rassicuranti sonorità pop, senza particolare mordente e guizzi emotivi, componenti prima imprescindibili della loro musica.
Avrebbe potuto “All That You Can’t Leave Behind” essere soltanto un disco interlocutorio, in attesa di tempi migliori, finì invece come detto in apertura del pezzo, risultando senza infamia e senza lode.
Se vent’anni fa però era giusto (oltre che doveroso) aspettarsi ancora qualcosa di buono dagli U2 dopo questo primo ridimensionamento, da tempo ormai, ahimè, abbiamo finito di confidare in un ritorno dei quattro agli antichi splendori, alla ricerca di quella grandezza che sembra perduta per sempre.
U2 ““ All That You Can’t Leave Behind
Data di pubblicazione: 30 ottobre 2000
Tracce: 12
Lunghezza: 53:13
Etichetta: Island Records
Produttore: Daniel Lanois, Brian Eno
Tracklist
1. Beautiful Day
2. Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of
3. Elevation
4. Walk On
5. Kite
6. In a Little While
7. Wild Honey
8. Peace on Earth
9. When I Look at the World
10. New York
11. Grace
12. The Ground Beneath Her Feet (Bonus Track)