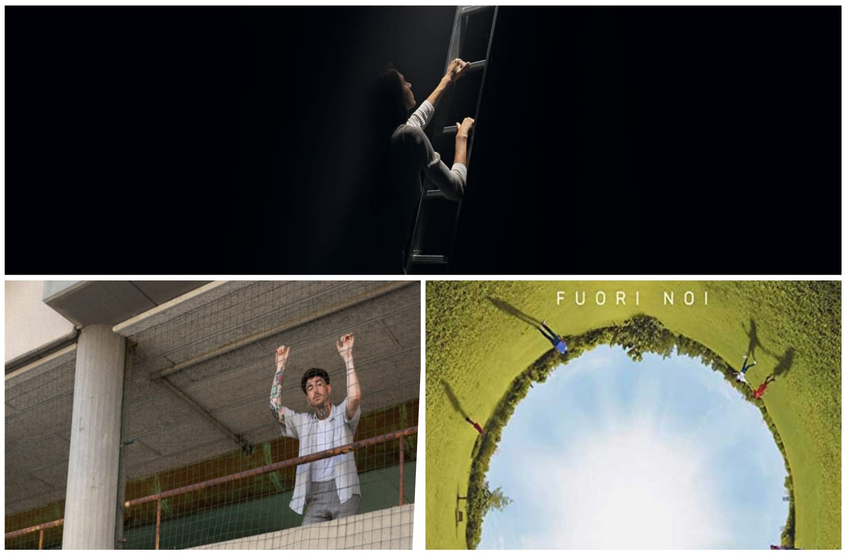Niente bollettino, quest’oggi: la musica italiana, infatti, è arrivata durante questa prima settimana di marzo, al suo annuale giro di boa, immobilizzando pubblico e artisti italiani nella contemplazione del nuovo catalogo discografico 2021: Sanremo è da sempre espressione di una cultura che in tutti i modi prova ad imporsi il movimento, solo per far credere a tutti di non essere incastrata da settantuno anni in quel loculo maleodorante e saturato che è la canzone all’italiana lagnosa.
Dalla prima edizione del Festival sono cambiate tante cose, dalla struttura della rassegna al livello di tolleranza che Sanremo sembra essersi autoimposto negli anni per avvicinare un pubblico sempre più disinteressato perchè deresponsabilizzato dalla scelta; è Sanremo che sceglie per il pubblico e non viceversa, e per questo mai come quest’anno l’attenzione sulla kermesse ligure era stata così alta.
Sì, perchè nelle compiacenti statistiche sciorinate ogni sera da Amadeus circa il coinvolgimento social che il festival ha saputo raccogliere sul web sta tutta la cifra sociologica prima che musicale di una direzione artistica intenzionata a coprire con il cerone le rughe profonde del proprio atavico invecchiamento attraverso un processo di copia/incolla spudorato delle principali playlist editoriali di Spotify.
Rendiamoci conto del fatto che i nomi presentati nella sezione BIG di Sanremo sono quelli che popolano i primi posti dei vostri contenitori Spoty, rafforzando ancor di più l’idea che, oggi più che mai, la crema della nostra canzone italiana altro non sia che il risultato di filtraggio e omogenizzazione manovrato dall’approccio quasi colonialista del colosso svedese, che di italiano ha ben poco; nella calibrazione dei valori qualitativi (?) e quantitativi che Spotify impone agli artisti per essere presi in considerazione dai vari selezionatori editoriali sta la misura di un processo inquietantemente globalizzante che vuol fingere di non sapere che ogni luogo, tempo e spazio possiede sfaccettature che ridurre ad un unicum stabilito e pre-settato altrove (senza interesse alcuno per le microsfumature culturali che, liberandoci dal nostro internazionalismo a tutti i costi, potremmo definire “locali” per quanto collegate, per rapporto di mutua interdipendenza, ad un organismo di significati sempre più allargato) non può far altro che farci arrossire ed imbarazzare ancor più nel nostro irrisolto complesso di provincialismo.
Fatto sta che quest’anno a Sanremo è salita sul palco l’avanguardia nostrana, scatenando l’interesse social della Generazione Z che come il più grasso ed ingenuo dei pesci ha abboccato all’amo del sistema; sì, perchè al netto delle nostre timide speranze di rinnovamento (vista, al di là di tutto, la qualità delle proposte selezionate), a prevalere è stata la sensazione che non esista miglior vaccino, per il pensiero borghese, della standardizzazione dell’avanguardia, appunto.
Nella debà cle del nuovo che avanza, Sanremo ha dimostrato che la nuova leva non possiede ancora i mezzi per fare qualcosa di intrinsecamente diverso dai propri predecessori: dalla ghigliottina dell’Ariston si sono salvati in pochi, dimostrando che, spente le luci dei riflettori, dello showbiz e dei salotti discografici che inventano fenomeni su adolescenti che rimarranno per sempre (e al potere va bene così) potenze di atti inespressi, a brillare rimarranno in pochi.
La musica italiana è sempre più al buio, e ora più che mai è necessario credere che, per quanto l’underground si sia messo il vestito migliore per non sfigurare al Ballo della Celebrità , esista ancora qualcuno che alle paillettes preferisce la nudità di un corpo martoriato dalla disattenzione di pubblico e sistema. Per un pubblico emergente, sì, che sappia riconoscere nell’inferno ciò che inferno non è, e dargli spazio facendolo durare attraverso una ginnastica di militanza che smetta di credere che l’essenziale sia sotto gli occhi.
Intanto, ecco quello che penso dei brani in gara a Sanremo 2021, in rigoroso ordine sparso.
Niente voti. Solo pensieri in libertà di un ascoltatore qualunque, sicuramente più incazzato di tanti.
MADAME, Voce
Madame è giovanissima ma morde il palco con la fame di un digiuno che sembra resistere da anni. Fame atavica che nella presenza dei violini e dei fiori sanremesi non lascia sfumare i contorni della propria identità , dimostrando che sotto il vestito della festa resiste qualcosa che non cambia a seconda delle mode o dei palchi calcati. Chiamatela urgenza, chiamatela ingenuità . Si chiama Madame e da martedì scorso lo sa tutta Italia.
IRAMA, La genesi del tuo colore
Una buona dose di sano populismo, un timido accenno di raggaeton e un inciso strumentale post ritornello a metà tra dragonsteadintei e “Vanità di Vanità ” di Branduardi (proprio a Sanremo!), con l’utilizzo dell’autotune a rendere ancora più messianica la voce di un Irama steso dal fato ma non dalla giuria demoscopica. Di per sè, il testo non è neanche male. Quello che frega è il gusto kitsch dell’arrangiamento con cui a Sanremo, edizione dopo edizione, vengono immolati sull’altare del consumo immediato e della faciloneria canzoni che potrebbero essere meno sanremesi di quello che poi irrimediabilmente diventano.
MICHIELIN ft. FEDEZ, Chiamami per nome
Boh, c’era bisogno di portare un pezzo del genere a Sanremo? Non ci bastava l’idolatria da playlist che incensa tutto quello che esce dallo sfintere della masscult per dare dignità ad un brano che, di per sè, non ha assolutamente niente di speciale? Fedez decisamente impalpabile, Michielin che prova a tenere in piedi un brano che non decolla mai, e che quando lo fa non smette di ricordare un mescolone in salsa 2018 (e sono stato generoso) di Elisa, Laura Pausini e tormentone Disney 2.0. Bel regresso sanremese, in formato duetto come piace al pubblico televisivo italiano.
COLAPESCE e DIMARTINO, Musica leggerissima
Per prima cosa, chiariamo che per quanto Colapesce e Dimartino ci abbiano fatto credere di essere in gara come tutti gli altri palesemente così non è stato. I due cantautori siciliani, infatti, mantengono alto a tal punto il livello della propria proposta da sembrare degli ospiti (e di caratura quasi internazionale) più che dei concorrenti. Un abisso intellettuale tra Cola/Dima e tutto il resto: un’estetica che si fa deliziosamente etica, un arrangiamento anni Ottanta che non recede alla smania del successo ma anzi, mette alla gogna ogni tipo di paraculismo sanremese con il bisturi di un’ironia sardonica, dimessa, sì, ma tremendamente caustica. “Musica leggerissima” è il pezzo antisanremese per eccellenza, in grado di mettere in imbarazzo il Festival in casa sua (e senza che il Festival, così pare, neanche se ne accorga): l’unico brano capace di reggere il peso culturale di una kermesse che non è solo una kermesse, parlando la sua stessa lingua e sovra-strutturando una babele di significati che sfuggono alla consumazione da primo ascolto sanremese nella direzione di un qualcosa che resterà .
ANNALISA, Dieci
Non stupisce, fin qui, il podio di Annalisa. Classico brano da Sanremo (anche se, dobbiamo dirlo, quanto si sono abbassate le nostre aspettative”…) che non meriterebbe, per dirla alla Guccini, due colonne su un giornale, ma che le mani adipose della discografia riescono a portare sotto i riflettori del palco più importante d’Italia giusto per ricordare a tutti che siamo ancora indietro anni luce, e in modo così squisitamente italiano da far impazzire anche lo Stanis Larochelle più paziente.
MANESKIN, Zitti e buoni
Tutto clamorosamente bello, dal look agghiacciante che tiene ormai a stento in piedi la credibilità rock di una band che fa di tutto per sembrare ciò che non è alle polemiche sul vero o presunto plagio al brano degli Antonhy Laszlo perchè dai, Sanremo è Sanremo e cos’è Sanremo senza bagarre e parapiglia da addetti al settore allenati al vaffanculo e allo scandalo? Due effetti positivi del brano dei Maneskin a Sanremo. Numero uno: hanno fatto scoprire al Belpaese un progetto (ho controllato martedì scorso gli ascoltatori mensili del progetto del primo Andrea Laszlo, ed erano 148: oggi sono circa 5000) che l’Italia non avrebbe mai avuto le palle di ascoltare se non per fomentare il gossip sanremese. Numero due: me lo sono dimenticato. Forse non è mai esistito. Rileggi il numero uno e immaginati che sia stato un po’ come vedere un Andrea Laszlo germinale a Sanremo, in fantastiche e ammiccanti tutine da rockstar che per fortuna danno qualcosa di cui parlare (perchè a livello musicale, c’è ben poco) ai saloni cosmetici di tutta Italia.
GAYA, Cuore amaro
Ho un problema, mi piace il pezzo di Gaya. O almeno, non mi disturba come quelli di altri colleghi della giovanissima debuttante. Trame alla Rosalìa, ritmo latin che però non stucca quanto altrove, un buon timbro evidentemente (visto il range di note toccate da Gaya sul Palco dell’Ugola) non suffragato da un’estensione potente: ingredienti giusti per un brano di passaggio, sì, ma che non fa male.
COMA COSE, Fiamme negli occhi
Potevano fare la Rivoluzione, hanno preferito la strategia degli scacchi. Ci sta. Se il brano, non fosse stato destinato al palco di Sanremo (che di per sè è un megafono potentissimo) appesantito dalle pretese di noi frustarti sempre aggrappati alla necessità di canzoni che ci salvino dalla mediocritas musicale nostrana, certo avrebbe meritato un posto tra i top del mio bollettino settimanale. Il punto è proprio questo: i Coma Cose sono rimasti nella loro comfort zone (e di per sè, il fatto già di per sè è una vittoria viste le performance di altri attesissimi profeti del cambiamento generazionale del Festival) senza cercare quello strappo di cui sono capaci ma che, evidentemente, hanno deciso di rimandare ad un futuro prossimo. I Coma Cose si sono presentati con discrezione al pubblico generalista italiano, rimanendo in piedi al centro della bufera emotiva e spersonalizzante di Sanremo guardandosi negli occhi. Per la Rivoluzione, c’è tempo. O forse no.
WILLIE PEYOTE, Mai dire mai (La Locura)
Viva il luogo comune travestito da ribelle, viva i lupi da interviste che divorano come agnelli i ragazzi sperduti della Generazione Z, in evidente crisi di valori e pronti ad aggrapparsi ad ogni barlume di riottoso retrogusto di rivolta post-adolescenziale per credersi dei rivoluzionari. Willie Peyote mette in tasca tutta la maleducazione sabauda originaria per farsi bello di un qualunquismo che gli sta stretto (viste le premesse del suo talento) ma in cui, evidentemente, il successo gli ha insegnato a sentirsi comodo. Willie è diventato “uno che ben pensa”, capace di far credere all’ingenuo pubblico televisivo sanremese che le barricate in piazza non si facciano per conto della borghesia, che continua a creare falsi miti di progresso anche (e sopratutto!) nella rassegna più teen di sempre. Negare tutto non serve a molto, se poi non si dice qualcosa di diverso da quello che ti aspetti di sentire dal solito Peyote sempre più incazzato a salve. Incensatelo come vi pare: io ci vedo solo tanta scaltrezza discografica, e nulla più. Quindi, alla fine, tutto in linea con ciò che Sanremo da sempre chiede come dazio da pagare ai suoi nuovi proseliti. Insomma, di “loco” c’è veramente poco nell’auto-sabotaggio dell’avanguardia che si fa sistema, senza il coraggio di ammetterlo a sè stessa.
FASMA, Parlami
Non sapevo chi fosse Fasma, e ammetto la mia ignoranza. Ora lo so, e la mia vita certo non è cambiata. Pezzo normale, testo anche ma con un buon ritornello che non fa sfigurare il ragazzo. Un po’ troppa roba (come sempre, dopotutto) nell’arrangiamento sanremese del brano, che comunque accompagna bene la metrica intelligente della canzone. Da Green Selection, più che da Sanremo. Ma questo passa al convento, e non è comunque male.
LA RAPPRESENTATE DI LISTA, Amare
Per La Rappresentante vale lo stesso discorso fatto per Franco e California: bel pezzo, che nel venerdì di uscite ci sta, un po’ troppo poco per l’hype che ci attanagliava il cuore sin dall’annuncio dei concorrenti del festival. Si può appuntare qualcosa al progetto toscano? Ottima resa, ottimo feeling col palco, ottima scrittura; ma non stupisce più, se non chi li conosce ora per la prima volta. Peccato per quel nocciolo di “fotta” genuina che anima tutto “Go Go Diva” e che qui, sul palco di Sanremo, sembra essersi confusa con il profumo ottundente dei fiori della riviera.
AIELLO, Ora
Aiello, grazie. Hai regalato una speranza a chiunque in Italia non abbia un minimo di talento e sogni comunque la carriera discografica. Con dischi d’oro annessi. Abbiamo un problema, Watson: questa democrazia musicale (che più democratica pare altamente demagogica) sta regalando alla mondovisione l’imago horribilis dell’italiano medio tutto passione e maccheroni, offendendo la storia di una kermesse che certo non ha mai spiccato per buon gusto, ma che oggi rasenta davvero il fondo della propria mediocrità . Specchio di una realtà che pare incubo, e che tutti i giorni viviamo sommessamente, al punto da farci salire il terrore di essere oramai abituati a questo torpore sonnifero.
LO STATO SOCIALE, Combat pop
Carino Lo Stato Sociale, che fa colpo nascondendo per tutta l’esibizione Lodo dentro uno scatolone. Ma l’ego del frontman (va bene, loro stanno provando a convincerci di essere un collettivo privo di capi e padroni ma oscurare il sole con le mani proprie non riesce bene alla band bolognese) si fa sentire e alla fine non riesce trattenersi dal “‘colpo di scena’ finale sull’esecuzione di un brano che comunque risulta ben scritto e simpatico. Meglio della loro ultima partecipazione sanremese, con qualche richiamo estetico e concettuale agli Skiantos (che forse ho visto solo io) utile a far rilassare un po’ la muscolatura facciale del sottoscritto. Dieci più, però, all’emozionante performance del giovedì che da voce ad un settore in crisi. E finalmente, direi.
MALIKA AYANE, Ti piaci così
Mamma mia, che lamento. Malika, mi piaci un sacco e trovo che la tua voce sia meravigliosa. Ma “Ti piaci così” è una mazzata all’entusiasmo, con tanto di regressione al piagnisteo della canzone italiana storica che ormai ha ammorbato tutti. Forse non tutti, visto il placet della giuria demoscopica. Che solo il concetto di “giuria demoscopica”, a me, fa agghiacciare.
RANDOM, Torno a te
Random, e non sto facendo riferimento al moniker dell’artista. Random, come il processo solo apparentemente casuale che ha portato “Torno a te” su quel palco prestigioso. “‘Arridatace Ed Sheeran, che Random lo imita davvero a random. Che qui significa, invece, “a cazzo de cane”.
GIO EVAN, Arnica
Ah, quindi la canzone che ti aspetti da Aiello l’ha cantata da Gio Evan. Nelle sliding doors del festival, le anime si scambiano e il cantautore/poeta/filosofo/pensatore/illuminato pugliese si dimentica dove ha messo il piacere di scrivere un pezzo che non sia costruito a tavolino, con una serie di immagini a cavallo tra ItPop e lamento neomelodiche che hanno asciugato l’inventiva anche delle sue seguaci sedicenni più accanite.
NOEMI, Glicine
Ho un debole per Noemi, che ho deciso di identificare come epigona di quel movimento autorale femminile che trova in Fiorella Mannoia il riferimento più vicino e stringente per l’ex vincitrice di X Factor (che vedi, ogni tanto qualcosa di buono e che resta lo ha tirato fuori). Il brano è emotivo, in linea con la richiesta dello showbiz, certo, ma potenziato dalla fortuna naturale di un timbro che riesce a scrollare di dosso da Noemi ogni possibile accusa di faciloneria. La scrittura della canzone, a tratti, ricorda echi bersaniani. La primavera di Noemi è arrivata, e lei è un fiore profumatissimo. A differenza di tanti arbre magique sanremesi.
MAX GAZZE’, Il farmacista
Vabbè, ma è palese che a Max della vittoria non freghi nulla. Non esiste smania del successo nello slancio naturale di un talento che a volte, in certe volute dei suoi testi, ammicca al genio; Max è l’ultima espressione felice di quella terza (se non quarta) generazione di cantautori a cui tutti i novelli della canzone dovrebbero guardare con ammirazione. Certo, “Il farmacista” ricorda un sacco di cose già sentite da Gazzè (compresa la sua “Sotto casa” sanremese), ma qui si tratta di un timbro e un’identità estetica costituitasi in venticinque anni di scrittura. E a me, personalmente, non stanca. Gazzè non ha nulla da dimostrare a differenza di altri, ma alza comunque l’asticella del Festival, svegliando il sonnacchioso pubblico tutto televisivo dell’Ariston.
FULMINACCI, Santa Marinella
Allora, cominciamo col dire che il brano è bello davvero. Ma c’è da stupirsene? Sì, se non conoscevate prima d’ora il talento di Filippo. Se invece il buon Utinacci avevate già avuto modo di apprezzarlo col suo disco d’esordio e attraverso le conferme di “Canguro” e “Un fatto personale” allora un po’ vi avrà dispiaciuto notare che il fenomeno classe ’97 (che invidia!) non abbia colto al volo l’occasione del festival per dare di sè un’immagine più coerente con gli ultimi sviluppi emozionanti della sua scrittura. “Santa Marinella” è un brano scritto due anni fa, e si sente. De Gregori sorride e Dalla, da lassù, guarda con interesse all’esibizione del nuovo enfant prodige della canzone d’autore; lo spauracchio che Sanremo potesse fraintendere e frustrare l’identità intellettuale del folksinger romano, qualora questa si fosse presentata priva dei filtri fioriti imposti dalla rassegna ligure, sembra però aver spaventato l’ambizione di Fulminacci che all’apparir del vero risulta incapace a tenere il passo di sè stesso, vincolandosi ad una forma già sentita (per quanto ben pensata e performata) di canzone all’italiana che, francamente, ritengo restrittiva rispetto alle potenzialità naturali di un progetto capace di essere intellettuale, senza diventare stucchevole e prosaico. Comunque buona la prima, in attesa di una seconda più coraggiosa.
ORIETTA BERTI, Quando ti sei innamorato
Grande Oriettona. Canta bene, come fosse il ’67. Anzi, sembra davvero di essere tornati al ’67. Così non è, e Tenco continua ad inveire dall’al di là contro un pubblico di merda che non smette di mandare sul podio brani che puzzano di rose plastificate. Non sto parlando di Orietta, che fa questo da una vita e continua a farlo con una dignità e una competenza capace di spaventare tutti gli improvvisati del Sanremo di oggi. Siamo noi, ad essere indietro.
ERMAL META, Un milione di cose da dirti
Una garanzia. La canzone è bella, comprensiva di quella “piangina” di default tipica del cantautore scuola Mescal che comunque non sottrae nulla all’estetica di gusto di Ermal. Non è il mio genere, ok. Però non per questo mi sento di dire che il brano, di per sè, non abbia valore. Sopratutto se raffrontato ai competitors attuali. Arriverà sul podio.
GHEMON, Momento perfetto
Da una parte Willie, d’altra Ghemon. Sembra un accostamento impossibile, ma non così tanto visto il terreno di partenza di entrambi. Solo che l’avellinese schianta per sincerità , urgenze e sound il rapper piemontese: uno scontro nello scontro che mette in luce l’incapacità del pubblico di massa di riconoscere il bello che vale senza la smania di dover brillare (come brillano le paillettes) a tutti i costi. A Venerus è piaciuto sicuramente, a Neffa anche. A me, sicuramente. No Ghemon, non sei secondo a nessuno, almeno su questo palco.
ARISA, Potevi fare di più
Vabbè, Arisa solo per la voce che ha meriterebbe un posto fisso ad ogni Sanremo. Certo, “Potevi fare di più” rappresenta quella declinazione leggerissima (e non come il brano di Colapesce e Dimartino) del festival che in qualche modo, anno dopo anno, dalla prima edizione della rassegna vediamo riproporsi sul palco dell’Ariston; ma è un male, se la canzone melodica trova dei rappresentanti così credibili come Arisa? Sanremo non è solo una gara, ma lo specchio di un’approccio culturale che, pur nei suoi tentativi di pretesa evoluzione e di ricambio generazionale, continua a voler mantenere immobile il manierismo di certi linguaggi. E Arisa, oggi, è il meglio che possiamo aspettarci dalla canzone leggera storica, al di là del nostro amore per le nicchie intellettuali che soffocano l’analisi lucida del fenomeno.
BUGO, E invece sì
E’ tornato! Vorremmo chiedergli “dov’eri finito?”, ma la verità è che la bagarre sanremese dello scorso anno ha portato il buon Bugo sotto i riflettori nazionali al punto che liberarcene, ad un certo punto, sembrava essere diventato impossibile. Insomma, tutti sapevano dove fosse Bugo. Bugo, invece, sa dove si trova il succo del successo: rimpastare, con l’ingenuità del bambino (sincera o fittizia che sia), il passato con nonchalance senza tema alcuna di citare anche fin troppo esplicitamente nel suo brano in gara “E penso a te”, capolavoro di Lauzi interpretato da Battisti. Di per sè, in fondo, il brano non mi dispiace. Ma forse perchè avevo l’impressione di averlo già sentito più e più volte, prima del primo ascolto.
FRANCESCO RENGA, Quando trovo te
Pronto per la rottamazione. Rimane solo una gran pena per la fine tremenda fatta da una delle voci più iconiche della mia adolescenza (ammissioni scomode). Il botox, purtroppo, non cancella l’anagrafe laddove l’invecchiare non viene preso come occasione di maturazione, ma come ineluttabile appuntamento con un destino spietato. Insomma, riscrivere “Se piovesse il tuo nome” di Elisa e Calcutta non aiuta a piacere ai giovani, Francè.
EXTRALISCIO ft DAVIDE TOFFOLO, Bianca luce nera
Goran Bregovic e Manu Chao approvano, io anche. Influssi sospesi tra i Balcani e i Caraibi, senza alcuna intenzione di piacere a tutti i costi. I veri outsider di questo festival sono loro, gli scartati dalla leva del mainstream che con coraggio da anni portano avanti una rivoluzione culturale che a Sanremo trova la sua massima occasione di sfidare il senso comune.