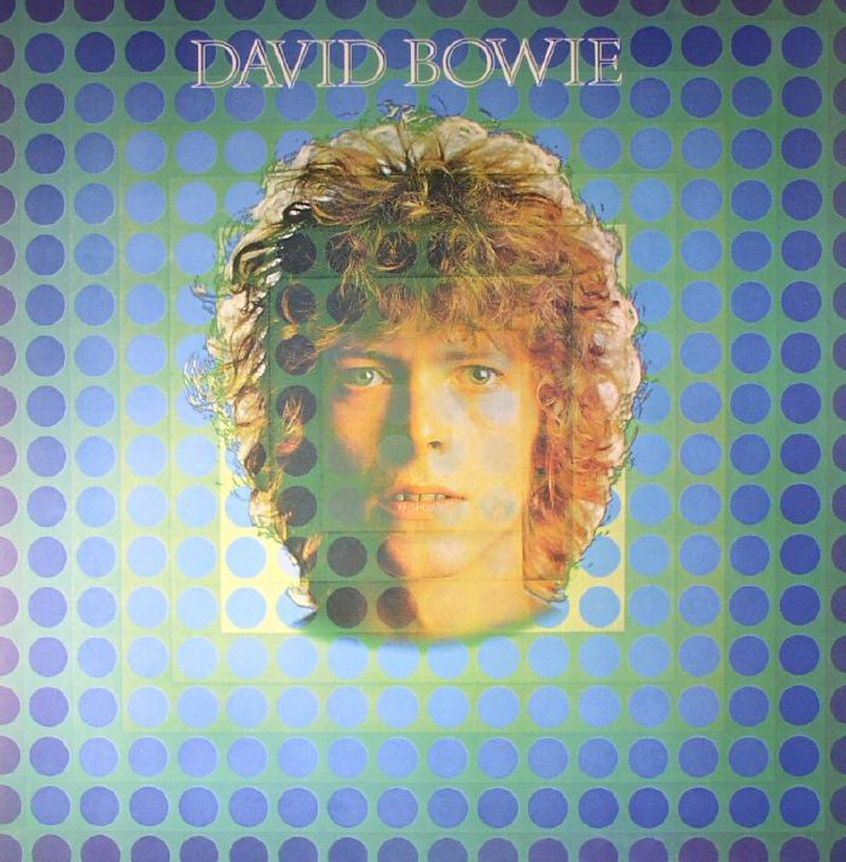di Stefano Bartolotta
Agli inizi del 2001, fare musica rock non era ancora un’attività considerata degna solamente di rimastoni retrogradi, ma era ancora visto come perfettamente normale, e anzi, naturale, che un gruppo di giovani avesse la voglia, l’esigenza, la necessità , di esprimersi con canzoni basate su chitarre potenti, un ritmo incalzante, un cantato a piena voce e testi che mettevano in piazza il senso di inadeguatezza di quando hai vent’anni o poco più e non riesci a capire quale possa essere il tuo posto nel mondo. Del resto, era successo così per decenni, ma di lì a poco, con l’avvento degli Strokes e della loro coolness, la percezione del pubblico sarebbe cambiata per sempre, e attenzione, non sto attaccando gli Strokes, il cui debutto è meraviglioso, ma sto semplicemente constatando un fatto, ovvero che da lì in poi chi ha fatto musica semplicemente definibile come “rock” è stato visto in modo diverso, ed è così ancora oggi.
Comunque, per fortuna i My Vitriol sono arrivati con il proprio disco di debutto quando ancora chi faceva musica di quel tipo poteva legittimamente ambire a un posto di rilievo nelle varie riviste musicali, ed è vero che internet c’era già , ma certamente il cartaceo aveva ancora una rilevanza ben maggiore. Comunque, il disco arrivò, le recensioni entusiastiche si sprecarono, il pubblico comprò e la band si imbarcò subito in un tour di spalla a un nome affermato come gli Ash. E sì, successe anche in Italia, in una domenica milanese semplicemente indimenticabile.
Il pubblico comprò, dicevamo, e intanto sorrise per il ringraziamento “for buying/borrowing/stealing this album” scritto sul booklet, e poi mise il CD nel lettore e si trovò di fronte fin da subito a una vera e propria esplosione di chitarre, di melodie, di batteria che picchiava, e non era solo un’esplosione che magari dura un attimo e poi porta con sè il silenzio, ma era un treno in corsa inarrestabile, un fiume in piena che continuava a scorrere, un martellamento continuo e incessante che non finiva mai, e tu, ascoltatore, volevi effettivamente che non finisse mai.
Oggi, una certa coscienza critica è decisamente più diffusa tra tutti gli appassionati di musica, e sarebbe quindi facile dire che gli ascoltatori vennero colpiti da come la band riportò in vita certi concetti musicali legati allo shoegaze, in un periodo in cui questo stile musicale sembrava essere stato messo definitivamente al bando. Si potrebbe poi parlare dell’invidiabile compattezza sonora, della varietà compositiva, della versatilità vocale di Som Wardner, di come, in definitiva, il disco risulti sempre interessante perchè, pur con coordinate stilistiche subito messe in chiaro, era difficile capire cosa aspettarsi nel suo sviluppo, quindi, insomma, c’era sì la carica giovanile, ma c’erano anche una perizia da veterani e il coraggio di aver ripreso qualcosa che era finito nel dimenticatoio e che sarebbe poi tornato a ispirare tanti altri gruppi solo diversi anni dopo, e chissà se sarebbe successo senza un disco come questo.
All’epoca, però, i dischi si ascoltavano certamente con meno consapevolezza, ma più col cuore, e, personalmente, i venti li avevo passati da qualche anno, ma non da moltissimi (ne avevo 26), il mio posto nel mondo l’avevo, forse, appena trovato, ma mi ricordavo bene quanto mi sentissi in balia di qualcosa che non capivo nemmeno cosa fosse solo pochi anni prima, e non potevo che immedesimarmi totalmente in qualcuno che mi urlava in faccia, con tutto il gusto e l’abilità esecutiva del mondo, ma sempre un urlo era, o almeno io così lo sentivo, “I wish I could, sometimes I wish I would, always your way; you want it all, I did everything I could“. Come rappresentare meglio di così uno stato d’animo prolungato che ti fa venir voglia di scappare ma senza sapere da cosa? Perchè poi, come detto, c’erano le chitarre, quelle chitarre, e quella batteria che pestava, e quella voce così bella, così forte e rotonda, così espressiva. E quello era solo l’inizio.
E poi si andava avanti, ma le altezze a cui ti portava “Always: Your Way” venivano mantenute da tutte le altre canzoni, nessuna esclusa, e anche gli stacchi strumentali erano semplicemente perfetti, e non te ne fregava niente dello shoegaze, del gusto, della perizia, di tutte quelle cose da coscienza critica diffusa, ti interessava solo che qualcuno, in quel modo lì e con quella veste musicale lì, ti dicesse “they’ve left you out on your own and they’ve broken all of your bones“, perchè sì, qualcuno che ti aveva lasciato lì da solo rompendoti tutte le ossa ci doveva pur essere, perchè non ci eri finito da solo a sentirti così, o forse sì, forse era colpa tua e quel qualcuno eri tu, OK, potevi accettarlo, bastava saperlo, e quel passaggio quantomeno serviva a far sì che una moltitudine di persone che si sentiva in quel modo cercasse di pensare a chi davvero avesse fatto in modo che si arrivasse a quella situazione.
E si andava ancora avanti, e mi piacerebbe dedicare un capoverso a ogni canzone, perchè sarebbe solo giusto, ma ve la farò più breve. Si andava avanti e ci si sentiva sempre più immersi in questo viaggio nella frustrazione e nella voglia di rivalsa, e anche quando i ritmi rallentavano, c’erano sempre quelle chitarre micidiali, che un momento ti prendevano per mano e quello dopo ti sballottavano senza pietà , ed era sempre incredibile e sempre emozionante, canzone dopo canzone, ascolto dopo ascolto. Non c’era un singolo passaggio chitarristico, o vocale, o ritmico, che non fosse azzeccato, forte ed efficace, non c’era un solo secondo di stanca e, ripeto, se oggi possiamo dire che era così grazie al sapiente uso di circolarità e riverberi da un lato e vuoti e pieni dall’altro, allora era il messaggio che contava, e quello di “Finelines” era declamato e diffuso come meglio non si sarebbe potuto fare.
Quando “Under The Wheels” si avvia alla conclusione, con quell’ultimo giro di batteria e le acque che si calmano ma, sotto sotto, la tensione rimane, è difficile non voler premere nuovamente play e ricominciare, però, in realtà , anche fare così è considerato ormai anacronistico, perchè adesso il venerdì di ogni settimana propone 10, 15, 20 dischi nuovi, e cosa stai a perdere tempo. Invece, allora, gli unici giorni in cui non ero contento erano quelli, rari, in cui non ero riuscito a farne due completi, di ascolti, e per settimane, per mesi, è stato così. Magari almeno oggi, per questo ventennale, farò come allora e glieli darò questi due ascolti, e chi se ne frega se è proprio venerdì e bisogna assolutamente ascoltare il disco di quello e di quell’altro. E anche se Som e gli altri non hanno più dato davvero un seguito degno a questo capolavoro, illudendo noi fan diverse volte, tra l’altro, io sarò loro grato per sempre, perchè di dischi che mi hanno coinvolto così tanto ce ne sono davvero pochissimi nella mia vita.
Pubblicazione: 5 marzo 2001
Studio registrazione: Linford Manor
Genere: indie-rock, shoegaze
Lunghezza: 48:02
Label: Infectious
Produtore: Chris Sheldon, Som Wardner
Tracklist:
1.Alpha Waves
2.Always: Your Way
3.The Gentle Art of Choking
4.Kohlstream
5.Cemented Shoes
6.Grounded
7.C.O.R. (Critic-Orientated-Rock)
8.Infantile
9.Ode to the Red Queen
10.Tongue Tied
11.Windows & Walls
12.Taprobane
13.Losing Touch
14.Pieces
15.Falling Off the Floor
16.Under the Wheels