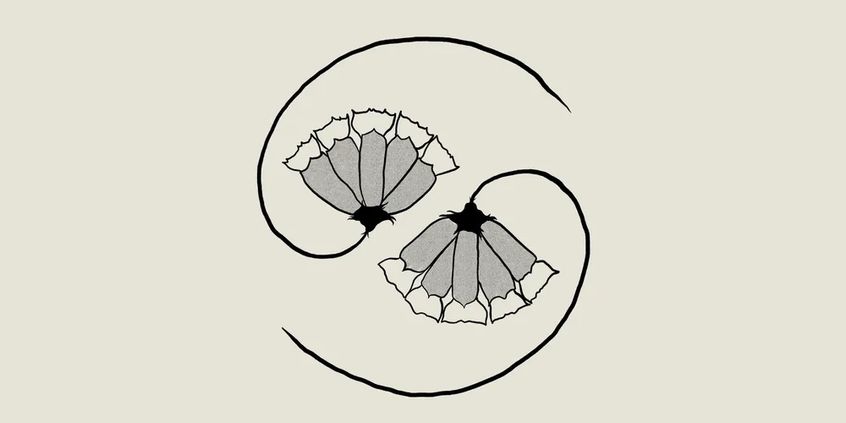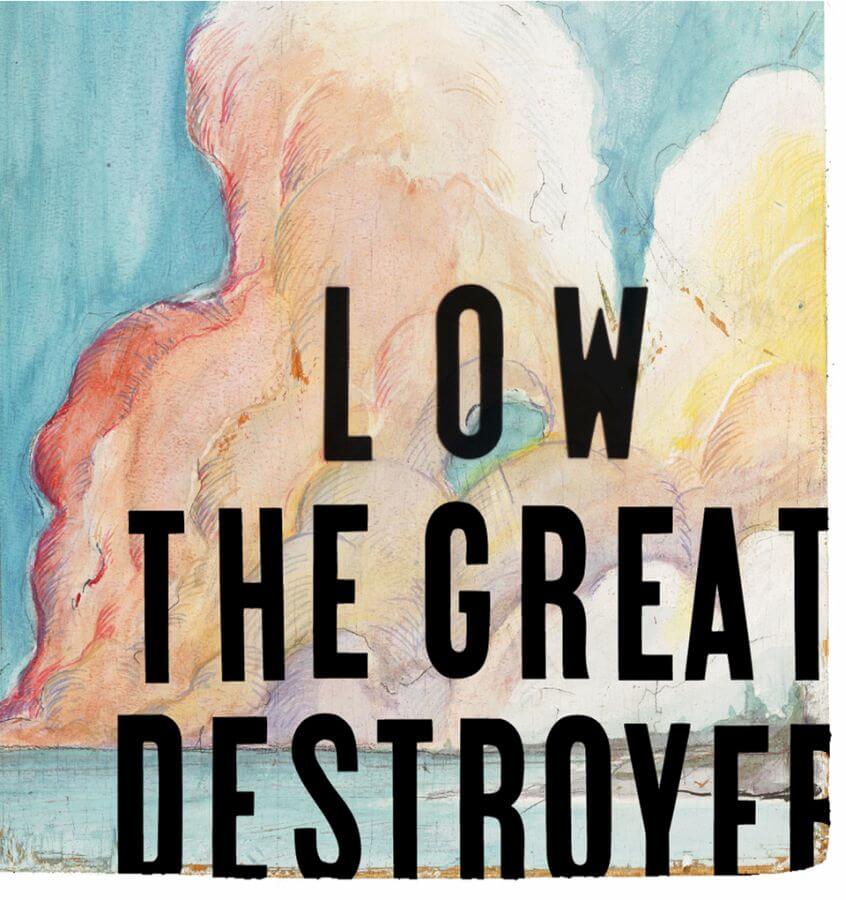Assolutamente fuori da ogni trend musicale, avvolti da una narrativa un po’ misteriosa, da un’aura un po’ dimessa, distanti da tutto eppure familiari e vicini, obliquamente “cool” in certe emanazioni sonore, i Low continuano imperterriti, tra quiete serafica e la proverbiale controllatissima tensione, a offrire riparo per chi vuole fuggire da una società della performance che tutto centrifuga e inghiotte, risputandolo fuori in frammenti irriconoscibili.
Ma è proprio una poetica del frammento quella che emerge dalla nuova musica dei coniugi Sparhawk.
Rimettere insieme i cocci per ritrovare una bellezza perduta benchè imperfetta come avviene nel kintusgi, riscoprirla nel riverbero fioco della scheggia più piccola, conficcata sul dorso del tempo, un flusso inarrestabile che impietosamente ci passa attraverso e tutto cambia, e tutto lascia uguale.
Questo nuovo approdo della lunga carriera dei Low potrebbe essere accostato facilmente al lavoro precedente, quel fenomenale e destrutturato “Double Negative” che faceva leva su pesanti tocchi industriali e deformanti, a sfregiare la delicata creatura sonora della band. Chi si aspettava il ritorno dei Low più folk/slowcore, quelli semi-acustici su tappeti ritmici spazzolati e superminimali troverà di nuovo un progetto artistico proiettato fortemente nel futuro, carico di un sapore liturgico-cosmico-tecnologizzato di grande fascino.
Sarebbe un errore però farsi influenzare troppo dagli ascolti del penultimo Lp: anche “Hey What” spesso non ci va leggero con le mutazioni digitali, ma cerca di ritrovare una maggiore ariosità , senza mai sfociare nella pienezza di una luminosità consolatrice certo, ma anzi rimanendo sul sentiero di una sorta di torva etereità . Prova di quanto stiamo dicendo, cioè di una sensazione di respiro accentuata, è il maggiore risalto dato alle parti vocali (sempre da manuale le armonie), qui meno imbrigliate in clangori e distorsioni distopiche.
In un certo senso, le texture sonore di “Double Negative” mostravano la crisi dilaniante di una macchina che schiacciava l’elemento umano in una deriva quasi “antagonistica”, mentre qui si avverte l’urgenza se non di una riappacificazione, di un tentativo di riabilitazione post-traumatica.
I Low tornano a giocare molto con gli strumenti dello studio, creando architetture sonore di densa spettralità , senza rinunciare a gettare qua e là semi rock che probabilmente germoglieranno in sede live (si veda la prima parte di “Days Like These”, la struggente “Don’t Walk Away” o “More” ) in tutta la loro fierezza. Queste impalcature poi divengono vere e proprie cattedrali di cristallo, che finiscono per dissolversi in un’onirica cascata di detriti (vedi sempre “Days Like These”, “Disappearing”, l’incredibile “Hey”). Ad inaugurare e chiudere la scaletta troviamo poi due pezzi alquanto granitici come “White Horses” e “The Price You Pay (It Must Wearing Off)” (con quest’ultima che spegne il disco al suono di una marcia pachidermica di batteria e convulsioni strumentali varie), sospesi tra speranza e cupo fatalismo.
Da ascoltare e riascoltare per coglierne appieno la bellezza, “Hey What” certifica l’eterno stato di grazia di un progetto artistico fuori dal tempo, eppure sempre necessario per ridefinire i confini del rock “alternativo” e connettersi allo stato attuale delle cose.
Credit Foto: Nathan Keay