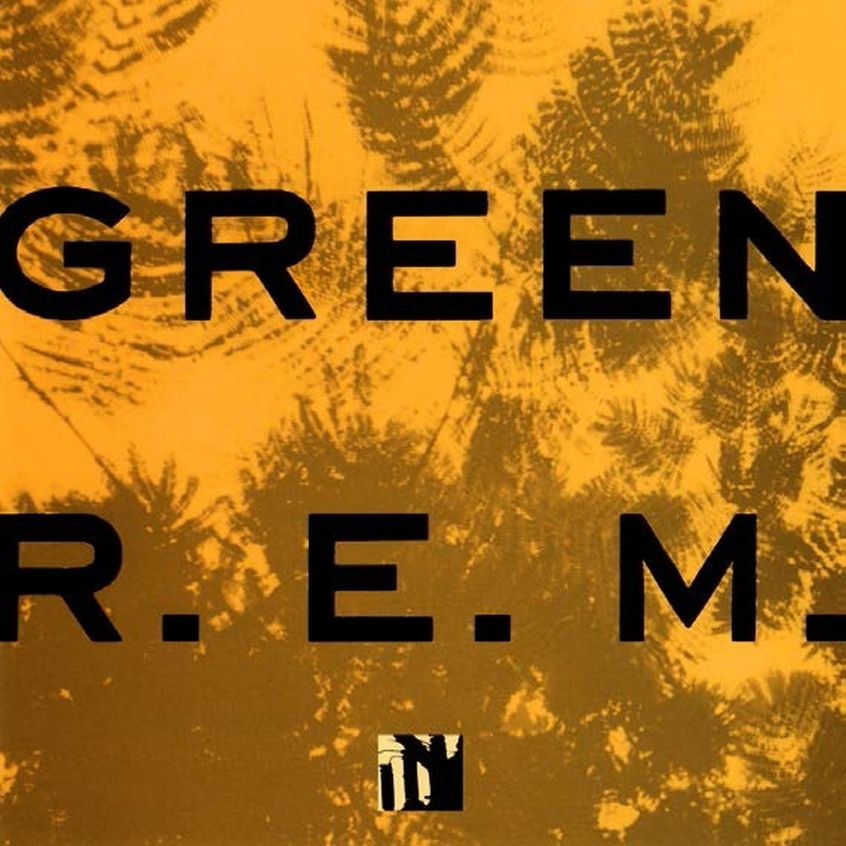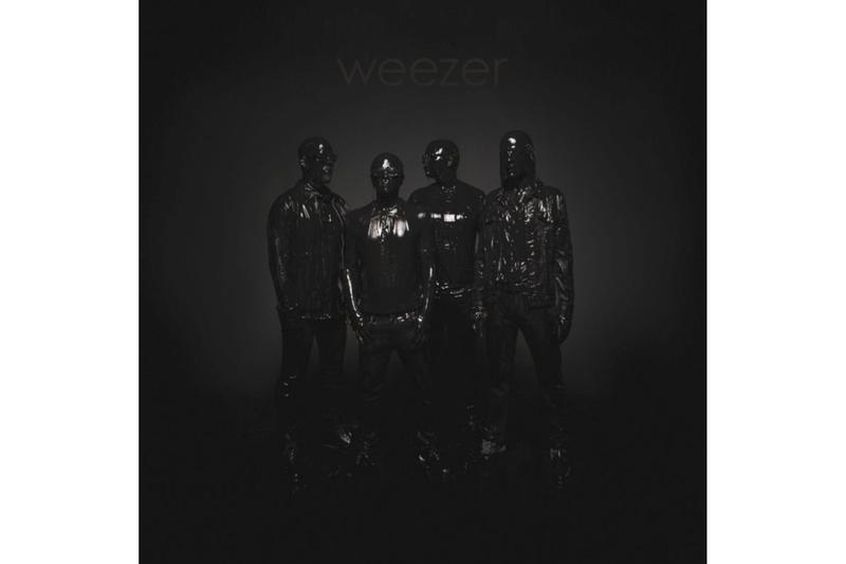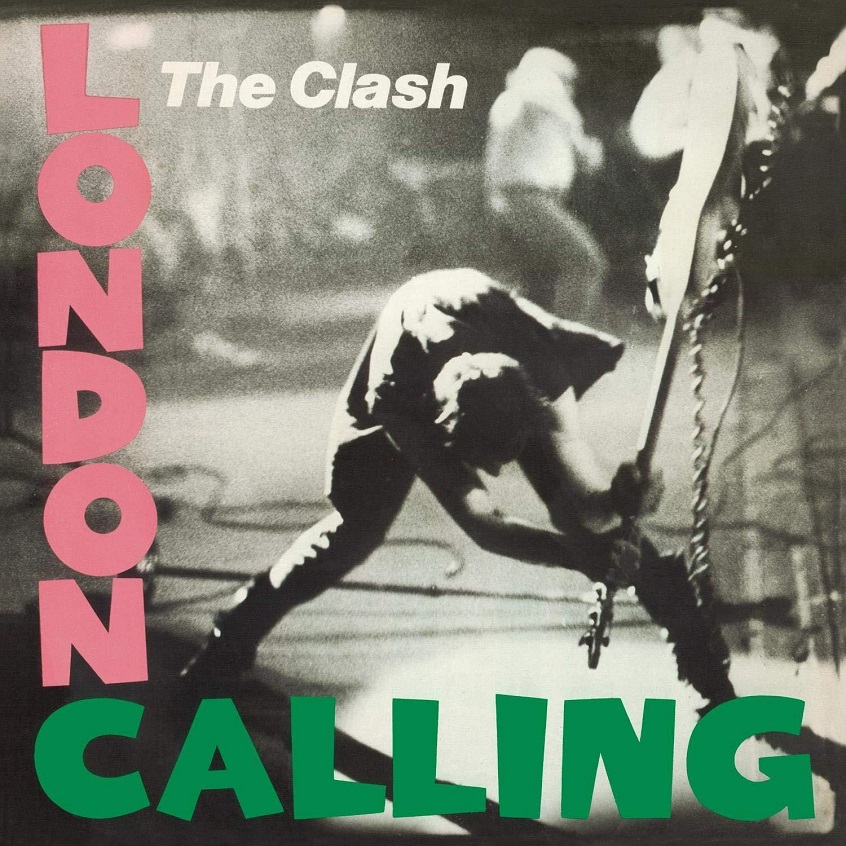Nella prima metà degli anni novanta irruppero sulla scena i giovani Weezer, capitanati dal talentuoso Rivers Cuomo e subito in modo alquanto frettoloso associato al fenomeno delle college band.
D’altronde il sound fresco e coinvolgente e l’attitudine power pop mischiato al look nerd del quartetto (completato dal chitarrista Brian Bell, dal bassista Matt Sharp e dal batterista Patrick Wilson) erano tutti elementi che facevano presa sui giovanissimi, ma la forza del gruppo (e il suo conseguente fulmineo successo all’altezza dell’esordio eponimo, poi passato ai posteri come “The Blue Album”) è stata anche quella di tracciare una nuova possibile strada al rock a stelle e strisce, la cui spinta propulsiva e dirompente del grunge si stava irrimediabilmente esaurendo con lo sparo di Kurt Cobain.
La gente rispose entusiasta e copiosa quindi al cospetto di canzoni, magari semplici in apparenza, ma che nascondevano in ogni caso nobili discendenze, oltre che passaggi sonori (un nome su tutti, i Pixies) cari anche ai Nirvana. Oltretutto i Weezer furono assoldati dalla Geffen Records, in molti insomma lo vedevano come un passaggio di consegne, in chiave però completamente differente per temi e suggestioni.
Il successo fu pertanto acclarato e globale, spinto anche dalla super hit “Buddy Holly”, corredato da un video indimenticabile diretto da Spike Jonze, in cui i ragazzi della band sono catapultati in una puntata di “Happy Days”.
Le cose però mutarono clamorosamente con l’uscita del successore “Pinkerton”, 29 settembre 1996, un album che mostrava l’altra faccia della medaglia, vale a dire l’altra personalità di Cuomo che, detta così, può suonare vagamente sinistra come affermazione.
Di fatto però qualcosa accadde nella testa del riconosciuto leader, che sin dai tempi dell’adolescenza si era ritrovato a fronteggiare non senza difficoltà alcuni risvolti personali, gli stessi che avevano acuito un senso di inadeguatezza nel rapportarsi con gli altri, specie col sesso femminile. Questioni appunto che potrebbero essere etichettate come figlie del suo tempo, in una fase di crescita ed esplorazione di se’ e del mondo esterno ma che, a quanto pare, si erano sedimentate in lui, fino a condizionarne il percorso, proprio ora che il grande successo era giunto grazie anche alle sue inequivocabili doti di artista e comunicatore.
“Pinkerton” divenne così cassa di risonanza di un malessere diffuso, quasi una seduta psicanalitica, un urlo di disperazione, una ricerca di attenzione.
Sarebbe oltremodo sbagliato però identificarlo come un lavoro triste, uggioso e introspettivo, perchè l’arma usata per far uscire tutto questo dalla testa del suo autore, fu una soltanto, quella della musica, che non tradisce certo le sue passioni e le sue influenze e anzi vanno ad amplificare lo spettro delle emozioni.
L’album trasuda un rock sanguigno, tirato e a tratti disturbante, ma ad eccellere è sempre la componente melodica, con brani che si fanno canticchiare al secondo ascolto, e l’interpretazione diretta, senza filtri, come a dire: “questo sono io, nel bene e nel male”. A posteriori non suona scorretto collegare questo lavoro al fenomeno emo, ma all’epoca il tutto uscì spontaneamente, senza pensare a generi ed etichette.
Il mix tra parole taglienti, amare e consapevoli, e il suono dirompente, arioso e cristallino – prevalentemente con accordi in maggiore – risulta essere il vero punto di forza del disco, che altrimenti avrebbe corso il rischio di ripiegarsi troppo sulle paranoie e le depressioni di Cuomo.
Eppure, nella percezione della critica della prim’ora, questo aspetto limitante deve aver prevalso in fase di giudizio, altrimenti non si spiegherebbe la stroncatura quasi unanime di un’opera che, invece a distanza di venticinque anni, mostra intatto il proprio intrinseco valore.
Quella stessa critica ha poi in parte rivisto voti e impressioni, comprendendo in che fase delicata si trovasse la band, e riuscendo così a far pace con queste liriche, così autentiche, schizofreniche e rabbiose, e a tutt’oggi “Pinkerton”, oltre ad essere diventato un album di culto degli anni novanta (ed emblematico di una fase di passaggio di un’epoca) è uno dei dischi più amati dai fans, al pari probabilmente dell’album blu, del quale appare come credibile contraltare.
Oggi celebriamo questo disco perchè in realtà non lo abbiamo mai dimenticato, in quanto contiene canzoni nelle quasi magari non sarà facile immedesimarsi, visto quanto sono autobiografiche, ma che non possiamo fare a meno di sentirle come autentiche, vere, genuine. In qualche modo destabilizzanti in primis per il gruppo – che da lì a poco vivrà una profonda crisi, con strascichi anche pesanti, vedi l’allontanamento di uno dei fondatori, il carismatico bassista Matt Sharp (che da lì a poco si butterà anima e corpo nel progetto The Rentals) – e poi anche per la vasta platea di fans, non pronti in quel momento a un così drastico cambio di direzione musicale e soprattutto concettuale.
Scorrendo la scaletta ci si rende conto del flusso inarrestabile di pensieri ed emozioni che sgorgava in seno alla band, in tracce intense e viscerali, scritte di pancia senza pensare a conseguenze su possibili reazione di un pubblico, che voleva e si aspettava un fragoroso bis dei Nostri.
Dalla paradigmatica “Tired of Sex”, autoironica e spiazzante nei versi e policroma nell’arrangiamento, alla potente “Getchoo”; dalla malinconica “No Other One” alla cavalcata elettrica di “Why Bother?”, l’ascoltatore entra in un frullatore per uscirne stordito ma pure affascinato.
I ritmi vanno pertanto smorzati e ci pensa ad assolvere il compito la poetica “Across the Sea”, con un cantato malinconico e aggraziato e con i caratteristici cori a dare un senso di familiarità al tutto; lo stesso che pervade “The Good Life”, sorta di fotografia degli stati d’animo dell’autore, di cui si ricorda anche un video girato a basso budget e fedele all’idea di non suscitare grandi clamori.
Il disco nella sua seconda parte mostra forse il suo lato migliore, con l’anomalo singolo “El Scorcho” e i suoi cambi di ritmo (l’andatura alla Pavement sfocia al centro del pezzo in uno sbilenco punk, per poi tornare ondivago), completamente differente da quanto ci avevano abituato i Weezer nel disco precedente.
Alza il livello anche la dolce “Pink Triangle”, romantica (almeno nelle intenzioni) quanto improbabile storia d’amore, sorretta da una melodia memorabile.
In chiusura due brani antitetici, a testimoniare una volta di più la natura ambivalente dell’intera opera, la cruda e disarmante “Falling for You” e una “Butterfly”, sorta di ninna nanna rappacificante, completamente acustica in cui si ascolta Rivers Cuomo quasi svuotato nell’animo, dopo un viaggio interiore estenuante seppur probabilmente salvifico, visto che dopo il punto più basso a livello personale e come band, saprà definitivamente rialzarsi, portando i Weezer all’eccellenza con l’album successivo.
Tuttavia dovranno passare ben cinque anni, utili e necessari per rimettere a posto i cocci, ricostruirsi, e dare nuova linfa alla propria esistenza: “Pinkerton” infatti aveva lasciato nel bene e nel male un segno profondo ed è impossibile da allora non farci i conti, nonostante i tentativi di infilarlo nel dimenticatoio, in una scatola nera.
Weezer ““ Pinkerton
Data di pubblicazione: 29 settembre 1996
Tracce: 10
Lunghezza: 34:36
Etichetta: Geffen Records
Produttore: Weezer
Tracklist
1. Tired of Sex
2. Getchoo
3. No Other One
4. Why Bother?
5. Across the Sea
6. The Good Life
7. El Scorcho
8. Pink Triangle
9. Falling for You
10. Butterfly