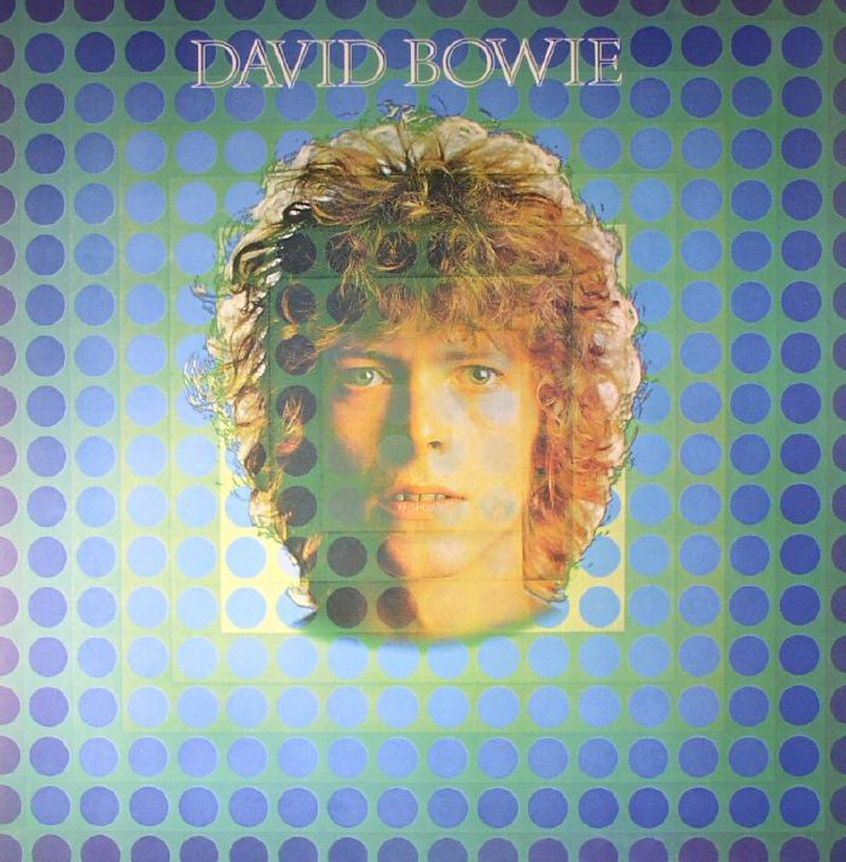Sto scrivendo queste parole nella giornata di giovedì 3 febbraio, al termine dell’ascolto e del ri-ascolto di quanto successo a qualche centinaia di chilometri da casa mia sul palco dell’Ariston di San Remo, nei primi due giorni del settantaduesimo Festival della Canzone Italiana.
Ignoro cosa succederà stasera e come un vero e proprio addetto stampa (comodamente in servizio dal divano di casa propria) mi sbilancio, come hanno fatto i miei colleghi dalla ben più scomoda sala stampa del teatro, sui venticinque concorrenti della kermesse della canzone italiana più seguita nel mondo, raccontandovi quello che penso delle loro canzoni e restituendovi una lista di giudizi assolutamente poco oggettivi e largamente influenzati dalla solita sicumera arrogante con la quale approccio, da ventisei anni a questa parte, ad ogni sfaccettatura dell’esistenza.
No, non è una classifica perchè, in merito alla questione “Sanremo come gara”, condivido la lucida visione che della cosa seppe restituire, ormai mezzo secolo fa, Fabrizio De Andrè: quello che segue, in effetti, è il resoconto emotivo di un Festival che assomiglia sempre più ad un catalogo degli umori e delle mode che negli ultimi dodici mesi hanno attraversato l’Italia, nel segno di una rassegna che vive il paradosso di essere ostaggio del gusto (discutibile) di un popolo italico che il Festival stesso ha contribuito a consolidare attraverso le sue settantadue edizioni.
Insomma, “Sanremo è Sanremo” proprio perchè non può essere diverso da quello che è sempre stato, specchio di una “società di ascoltatori” che non concede alternative al Festival perchè il Festival non gliel’ha mai concesse, in un tripudio di auto-referenzialità che oggi sembra aver trasformato il palco dell’Ariston in un supermarket generalista e isterico, capace di svalutare i propri prodotti proprio perchè ossessionato dall’idea di venderli, mescolando sugli stessi scaffali la canzone d’autore di Truppi con la prosopopea finto-impegnata di Massimo Ranieri, i teen idol Sangiovanni e Aka 7even con le operazioni di recupero Morandi–Zanicchi, la italo-dance di Rettore e Ditonellapiaga con la balera balcanica di Dargen D’Amico, la delicatezza poetica di Elisa con i megafoni di Giusy Ferreri.
Guardare Sanremo è un po’ come uscire per prendere il caffè al discount, e nello scaffale preposto trovare così tanti altri prodotti che alla fine ti dimentichi perchè sei uscito di casa e te ne torni indietro con una busta piena di ogni cosa, tranne che di quella che ti serve per cominciare bene la giornata. Anche se succede, ogni tanto, di trovare nel sacchetto qualcosa che non ti aspettavi meritasse la tua attenzione e che, invece, si rivela capace di farti cambiare idea dopo il primo assaggio.
Ecco dunque qui di seguito, in rigoroso ordine di apparizione, la lista completa di oggetti più e meno sconosciuti che mi sono ritrovato in saccoccia dopo due serate passate a gironzolare (da fermo) nel supermercato musicale più importante d’Italia.
ACHILLE LAURO, Domenica
L’idolo di tutte le casalinghe d’Italia (fino, almeno, ad un paio d’anni fa) fa a botte con Dio e ne esce vincitore; Dio, qui, non è quello che sta nei Cieli, e nemmeno Damiano dei Maneskin (che, per inciso, è sicuramente additabile come colui il quale, da un paio d’anni a questa parte, ha scippato al buon Laurone gran parte delle fan over45 di cui sopra): Dio, in questo caso, è Achille stesso, che da tre anni gioca a fare “colui che tutto può” presentandosi con la stessa copia dello stesso pezzo al festival della canzone più impomatato del mondo. A tanti, è sembrato segno di una scarsa vena creativa di chi, ormai, non può far altro che buttarla in caciara per non finire ante tempore nel dimenticatoio; io, invece, arrivato al terza riproposizione sanremese di “Rolls Royce”, penso che il tutto nasconda un “concept” artistico più ampio, preciso e assolutamente non casuale. Anche perchè, comunque, il brano (che è lo stesso da tre partecipazioni di Lauro a questa parte, l’abbiamo capito) continua a funzionare. Il battesimo a fine performance resta qualcosa di agghiacciante. Insomma, tutto “divino”.
YUMAN, Ora e qui
Non mi è dispiaciuto, sono onesto. Yuman, direttamente dal vivaio sanremese, è quello che al Festival si presenta sempre con tutto quello che serve per vincere: una buona canzone, una buona ugola, delle buone idee ritmiche, una scrittura dignitosa. Insomma, quel trionfo della “normalità ” sanremese che il mondo dello showbiz continua a costruire attorno alle nuove leve del pop destinandole a naufragare insieme al loro passaggio meteoritico sul palco più fiorito d’Italia. Lo rivedremo? Sono onesto? Non penso. Ma gli auguro che questa recensione invecchi malissimo.
NOEMI, Ti amo ma non lo so dire
Ecco, anche lei come Achille Lauro presenta lo stesso pezzo da quando l’abbiamo vista la prima volta al Festival. C’è una differenza: a differenza della “Rolls Royce” di Achillone, la prima volta di Noemi a Sanremo la ricordano in pochi, e tra questi di certo non ci sono io. Eppure, ho la certezza che la canzone che Noemi ha presentato quest’anno sia uguale a quella dell’anno scorso. E dell’anno prima. E dell’anno prima ancora: minimo comune denominatore? Sono tutte canzoni di cui ci dimenticheremo una volta spenti i riflettori sulla Riviera Ligure. Il drop sul ritornello gasa anche, ma è esattamente come te lo aspettavi. Forse che, allora, non ne avessimo bisogno?
GIANNI MORANDI, Apri tutte le porte
Si è emozionato ad inizio brano, mi sono emozionato anche io, si è emozionato anche Jovanotti al pensiero di aver dato in mano (e che mani!) di Gianni Morandi un brano che farà schizzare alle stelle gli introiti televisivi ed autorali del buon Lorenzo. Non perchè il brano meriti, anzi, è forse uno dei passaggi più insignificanti (artisticamente parlando) di un festival dinamico quanto zoppo; ma perchè dai, Gianni è come Mattarella: uno che doveva ritirarsi da tempo, ma che avverte ancora il bisogno di salvare il proprio Paese. Da chi? Forse anche da sè stesso, e dall’affetto incondizionato suscitatoci dalle leggende che non sanno accettare di essere già Storia. Nel dubbio, il popolo lo acclama.
LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, Ciao ciao
Credo che il progetto siculo (perchè a Palermo nasce, cresce e si evolve) abbia saputo rappresentare, nelle ultime due edizioni del Festival e negli ultimi dieci anni di militanza artistica, una delle più interessanti realtà del panorama indipendente nazionale, al punto da diventare icona di stile (musicale e non) e artefice di un linguaggio che, negli ultimi due dischi soprattutto, sembra aver confermato la propria voglia di farsi “timbro” diretto sempre più verso il pop. Per questo non stupisce poi troppo l’approccio nazional-popolare (e, a primo ascolto, un po’ sottotono rispetto al solito alto livello d’impegno emotivo offerto da LRDL) di “Ciao ciao”, che a tratti sembra aver perso lo smalto “riot” degli ultimi lavori discografici (pur non privandoci, a fine esibizione, di un pugnetto chiuso che, sta volta, sembra più retorico delle altre) facendosi più digeribile e democratico. Quasi, a tratti, democristiani per l’intrinseca voglia di risultare profondi (senza riuscirci del tutto) e allo stesso tempo “di tutti”: un po’ come una bella parabola che, però, abbiamo sentito ormai troppe volte e non riusciamo più a distaccare dal ricordo di quel prete simpatico (e magari anche di sinistra) ma alla lunga un po’ troppo pedante che ce la leggeva tutte le volte a catechismo.
MICHELE BRAVI, Inverno dei fiori
Questo bollettino è il mio, e a me Michele Bravi non piace (mai piaciuto) quindi mi prendo il diritto di non usare mezzi termini per dire che sto ancora combattendo contro le crisi d’ansia provocatemi dal primo ascolto del brano, imprigionato nel range di sei note su cui si muove l’intera canzone: il mio, sembra un loop infinito che non sa risolversi nè in un qualcosa di tanto pesante da portarmi a fondo, nè in uno slancio verso l’alto capace di farmi volare. Un brano mediocre, che conferma la pedanteria della “datata” (negli intenti e nei risultati) squadra di autori che affianca il buon Michele, che pur avrebbe una voce fatta apposta per strappare lacrime. Vere, e non disegnate come quelle che hanno tutti coloro che, oggi, fingono di essersi emozionati di fronte ad un brano che, già dal titolo, sa di Sanremo 1969.
MASSIMO RANIERI, Lettera di là dal mare
Premetto che Massimo mi è nel cuore, e quindi dire quello che sto per dire mi farà sanguinare l’anima: è ora di rimettere in remi in barca e godersi la pensione, o quanto meno rigettare ogni pretesa di parlare di contemporaneità (come sembrava dovesse fare questo brano), sopratutto se l’attualità raccontata è quella spinosa della cronaca migratoria. Sì, perchè il brano parla effettivamente di migrazione, ma lo fa con il linguaggio e le circostanze di almeno un secolo fa: qualcuno dirà “eh, ma la disperazione dell’emigrante è identica a qualsiasi latitudine, sempre di dolore si parla che sia con vista sull’America o su Lampedusa“. Non è così, ma se anche così fosse il filtro Disney che accompagna tutto il brano rende la sensazione di alienazione destata dall’ascolto della canzone ancora più violenta. E, se vogliamo, spinge il cuore verso la tenerezza nei confronti di chi sembra avere ancora il fisico per correre (al di là delle emozionate imprecisioni vocali della prima sera), ma senza saper più che direzione prendere per non farlo a vuoto.
MAHMOOD E BLANCO, Brividi
Decisamente uno dei brani più interessanti di questa edizione, “Brividi” suscita per larghi tratti della sua prima esecuzione quelle increspature della pelle e dell’anima a cui il titolo allude: sarà che i due, è evidente, possiedono numeri e stelle capaci di farsi sentire e brillare anche con le luci spente e con le voci a terra, sarà che il feeling tra i ragazzi, a livello artistico e musicale, sembra ben più che evidente, sarà che la concorrenza non è che sia proprio agguerritissima. Ma fatto sta che, per la prima volta a Sanremo, due uomini cantano una canzone d’amore intensa e sentita guardandosi negli occhi e facendolo con amore vero e palpabile, capaci di andare oltre ogni tipo di sovrastruttura retorica o modaiola per farsi “sinceri”. Peccato per il freno a mano tirato alla vocalità di Blanco, che interpreta benissimo la parte del “cantante melodico” ma che lascia in bocca quel sapore dell’inespresso, del non detto come avrebbe potuto. Il brano, comunque, è bello davvero.
ANA MENA, Duecentomila ore
Ah, era in gara? Scusate, pensavo fosse il momento ospite straniero. E mi stavo in effetti anche chiedendo perchè invitare un’artista spagnola per cantare un brano neomelodico.
RKOMI, Insuperabile
Sono sincero, e vi svelo che per tutta la durata della sua performance sono stato concentrato sul riprendermi dallo shock che mi è stato dato da un’amica che, prima dell’inizio del brano, mi ha rivelato che “Rkomi” altro non è che “Mirko” incastrato in modo diverso. Quello che intanto arrivava alle mie orecchie, fra un anagramma e l’altro, era un pezzo normalissimo con il solito ritornello da bad boy con tanto di chitarrone. Sicuramente, meno interessante del giochino di lettere che ha generato il nome d’arte dell’autore.
DARGEN D’AMICO, Dove si balla
Se il titolo diventa una domanda che Dargen vuole porci, la mia risposta è sicuramente lontano da musica come la tua, cacchiarolina. Pessimo gusto che piove a iosa sull’Ariston nei tre minuti di canzone che D’Amico dedica al proprio desiderio di ritorno alla normalità condito da un’aria di denuncia che sa di qualunquismo, clichè e pericolosi luoghi comuni. E pensare che le prime strofe un po’ vascorossiane mi avevano quasi quasi fatto salire la curiosità di ascoltare il resto: pessima scelta, la mia. Peggior canzone del festival (perchè continuo a pensare che Ana Mena non sia in gara).
GIUSY FERRERI, Miele
Addirittura il megafono! La buona Giusy aveva paura che non si “sentisse” abbastanza il suo imbarazzo ad essere su un palco che non sa reggere, e allora l’ha reso “megafonico” regalando al brano l’unico slancio di interesse pubblico grazie all’escamotage performativo di un’espediente che, comunque, serve a poco e rimane tale. Non c’è trippa per gatti, nè gatti attirati dall’odore di qualcosa che, tutt’al più, sa di occasione persa per starsene a casa. No, non basta il miele per addolcirmi.
SANGIOVANNI, farfalle
Sale sul palco con la stessa disinvoltura di chi sta andando al parchetto per fare due tiri al canestro, abbraccia Amadeus come fosse il proprietario del centro sportivo in cui ha festeggiato tutti i suoi dodici compleanni (sono di più?), canta una canzone che nessuno si ricorda (a parte le orde di ragazzine under nove che, prendendo troppo sul serio il nome dell’artista, lo hanno già pontificato santo) e se ne va lasciando agli italiani che lo hanno scelto al Fantasanremo una manciata di punti in più che comunque non colmano il vuoto esistenziale creato da tutta questa mediocrità al potere. In linea coi tempi.
GIOVANNI TRUPPI, Tuo padre, mia madre, Lucia
Canottiera di ordinanza, muso storto (per il disappunto di Amadeus malcelato dietro una battutina sull’outfit) e una canzone che conferma a chi lo segue da tempo lo spessore artistico di una proposta autorale che non trova confronti sul mercato perchè Truppi si è creato il proprio, di mercato, partendo da una proposta che vuole e dev’essere fortemente culturale. Detto questo, Giovanni dimostra di voler andare a Sanremo rimanendo fedele a sè stesso: calmando da una parte la paura degli affezionati, frustrando dall’altra la voglia di chi – come me – era curioso di vedere come Truppi avrebbe moderato l’incontro fra due parti lontanissime (quella dello showbiz e quella della ricerca poetica che da sempre caratterizza l’operato del cantautore napoletano) in un qualcosa di inedito per lui, prima ancora che per noi. Alla fine, il brano è truppianissimo con qualche sfumatura deandreiana che compiace ancor prima di piacere, e come tutti i pezzi di Truppi da riascoltare con attenzione. Resterà , ma ha bisogno di tempo.
LE VIBRAZIONI, Tantissimo
Tantissimo, anche troppo. Imbarazzo, dico. Sono onesto, per uno come me cresciuto a pane e Vibrazioni, vederli e sentirli così fa star male. Fa male tantissimo. Il brano è la solita rengata (“da Francesco Renga“, chi vuol intendere intenda) suonata con la divisa da rocker: carnevalata.
EMMA, Ogni volta è così
Ragazzi e ragazze care che devo dirvi, a me Emma gasa e il pezzo oggettivamente (e per oggettivo intendo ciò che, qui a Sanremo, può dirsi opportuno) ci sta. Le strofe salgono con calma arrampicandosi verso un ritornello che, al momento dell’esplosione finale, vuole ricordare e non poco la Loredana Bertè di “Sei bellissima”; alla fine, gira che ti rigira, si torna sempre lì. Ma il momento più bello rimane quello in cui la Michielin, acclamata coram populo a dirigere l’orchestra del Festival per festeggiare i suoi dieci anni di carriera (insomma, la metà degli anni di studio fatti dal più giovane dei musicisti dell’ensamble) decide di consegnare il suo mazzo di fiori al primo violino. Francesca brava e umile ragazza.
MATTEO ROMANO, Virale
Di Matteo, con la lungimiranza propria solo dei grandi scrutatori di musica indipendente (?) quali siamo noi, siamo stati fra i primi a parlare (e con arroganza mi prendo il merito di questa scoperta) in un disperso bollettino di qualche tempo fa, quando raccontai la sua “Concedimi” che di lì a poco avrebbe fatto numeri incredibili sui social. Matteo ha talento, ha voce, ha anche un discreto gusto nella scrittura e nell’interpretazione: la produzione di Dardust (il vero vincitore bancario di questo Festival, di cui ha scritto più o meno tutte le musiche e arrangiamenti) regala al tutto un tono pericolosamente Mahmood che sticazzi, gasa anche se è già sentito. Non vincerà , ma ambisce alle prime sei posizioni.
IVA ZANICCHI, Voglio amarti
Anche io voglio amarti Iva, e lo faccio solo perchè sei una delle signore indiscusse della storia del Festival e quando attraversi quel palco sembri me quando rientro da un lungo viaggio e taglio in diagonale i binari della stazione di La Spezia, sentendomi padrone della ferrovia e della mia città . Senza alcun merito artistico reale naturalmente, e con il rischio che un treno mi tranci a metà . Rimane solo da capire chi sia la signorina, vagamente simile all’Ivona nazionale, che hanno usato a Sanremo come “figurina” dell’original Zanicchi.
DITONELLAPIAGA E RETTORE, Chimica
Decisamente la canzone più furba del festival: appeal contemporaneo (gentilmente offerto da Ditonellapiaga, che da San Romolo a Sanremo è n’attimo e beata lei, fateme ‘n po’ rosicà ) che incontra la storia della italo-dance, riproponendo in effetti un brano a là Rettore che diventa tossico da quanto si attacca alla pelle e alla salute di tutti. Insomma, c’è poco da dire se non che il brano funziona – ma ci mancava che fosse il contrario, visto che la ricetta seguita è quella scritta, più o meno quarant’anni fa, dalla stessa arzillissima Rettore, che sul palco mescola passato e futuro lanciando nell’etere il nome di una cantautrice giovanissima tutta da scoprire.
ELISA, O forse sei tu
Arriva lei, e il velo cade. Elisa è l’ammazzafestival, sparigliatrice di palchi, la verità che fa capolino dal sipario e rivela la menzogna ad un pubblico stordito, che non può che battere le mani con la bocca spalancata. Sì, Elisa è la rovina di questo Sanremo, impegnato a mettere insieme i rottami del Belpaese per provare a convincerci che, la nostra, non sia musica da discarica; poi arriva Elisa, nel suo sciamanico abito bianco da sposa vergine, perchè questo è Elisa: purezza creativa che non sa darsi in pasto al consumo del mercato; tutto quello che l’ha preceduta e la seguirà diventa un orpello di cattivo gusto, una kermesse simile alla corrida che funge da antipasto e titoli di coda di quello che dovrebbe essere il “vero” Festival della Canzone Italiana. E il festival, quest’anno, è durato ben 3 minuti e 53 secondi.
FABRIZIO MORO, Sei tu
Avevo una decina di anni (forse anche meno) mentre canticchiavo “Pensa” di Fabrizio Moro e pensavo che era un gran figo, quel Fabrizione. Ora che sono grande, penso che Moro avrebbe potuto fare molto di più nella sua carriera comunque ricca di soddisfazioni, che in pochi l’abbiano capito relegando il nome del cantautore alla risma di artisti del trash musicale italiano, che Fabrizio soffra molto di tutto questo e che l’effetto finale di questa diaspora sia il continuo perpetuarsi della stessa canzone sul palco dell’Ariston, ad ogni nuova apparizione del cantante romano. Un loop, insomma, che sa di maledizione e condanna auto-imposta.
TANANAI, Sesso occasionale
Occasionale, spero, come il lavoretto da discografico che fa chi lo ha portato lì. Perchè se “‘sta gente è “del mestiere”, allora meglio per tutti cambiare lavoro.
IRAMA, Ovunque sarai
Oh regà , con questo look da principe del vento Irama mi convince il doppio, anche se ormai quello che il ragazzo voleva dire già l’anno scorso si era capito. Insomma, la minestra è quella con la differenza che stavolta Irama riesce a cantare il pezzo in presenza e non da uno schermo in collegamento.
AKA 7EVEN, Perfetta così
Fa la gioia di tutti i Fantasanremisti (madonna, che agonia che è stata ‘sta ridicolata del Fantasanremo“…), canta bene (quasi benissimo) il suo pezzo, risulta caruccio, educato e simpatico. Perfetto per Sanremo, forse un po’ meno per la vita fuori dai social e dalle turbe adolescenziali.
HIGHSNOB E HU, Abbi cura di te
Allora, ai nastri di partenza del mio divano mi sono presentato con un forte scetticismo nei confronti di un’accoppiata che boh, non mi sarei mai immaginato. La mia storia di ascoltatore mi ha portato negli anni a farmi un’idea precisa di Highsnob che, insomma, non è proprio uno dei miei ascolti prediletti; di Hu, colpevolmente, conoscevo poco e niente. Fatto sta che l’inedito duo funziona fin dalle prime note cantate dal rapper spezzino d’adozione (lui, invero, è avellinese di origini), pur rievocando in modo un po’ troppo speculare l’esibizione dei Coma Cose dell’anno scorso – quantomeno a livello puramente performativo. Il risultato finale è un brano che strugge al punto giusto, e lascia ri-scoprire all’Italia la voce interessante di Hu.