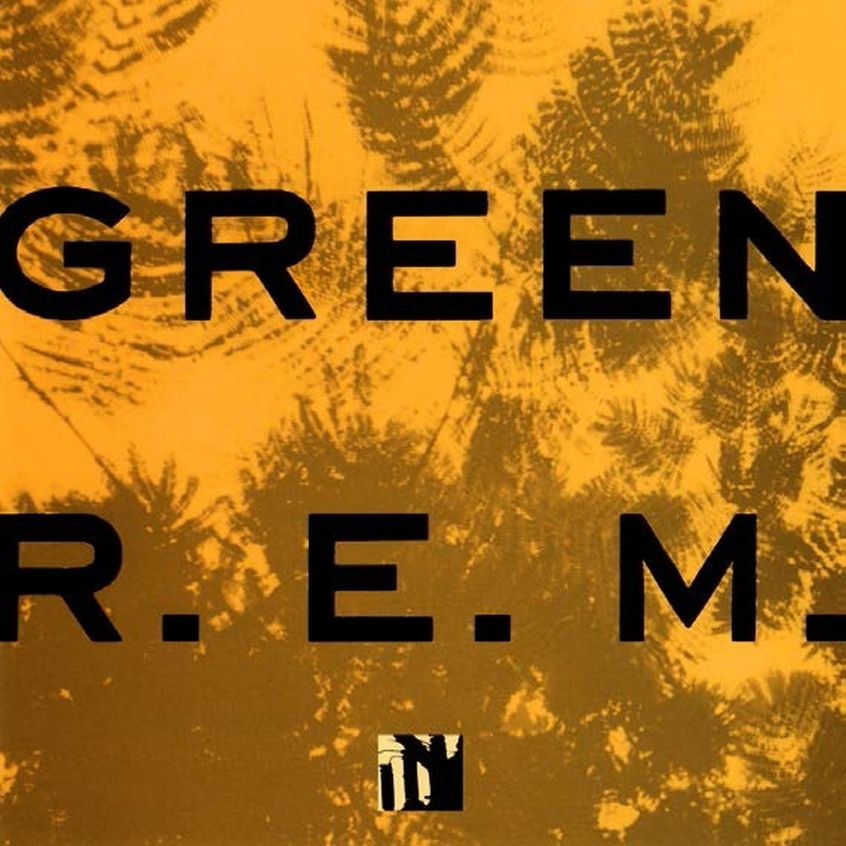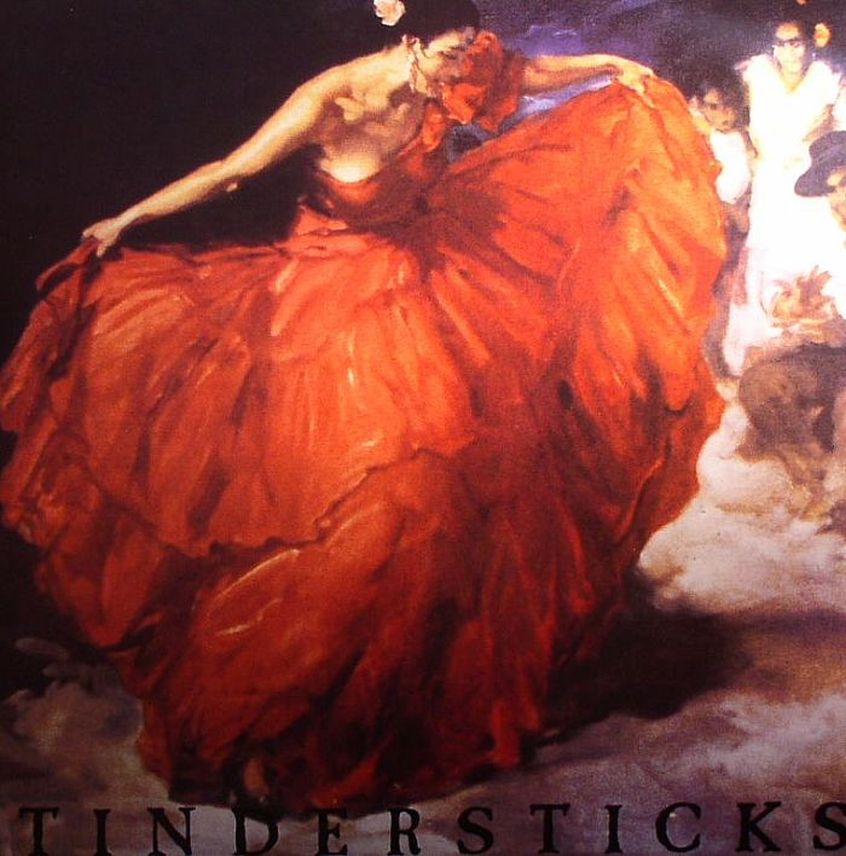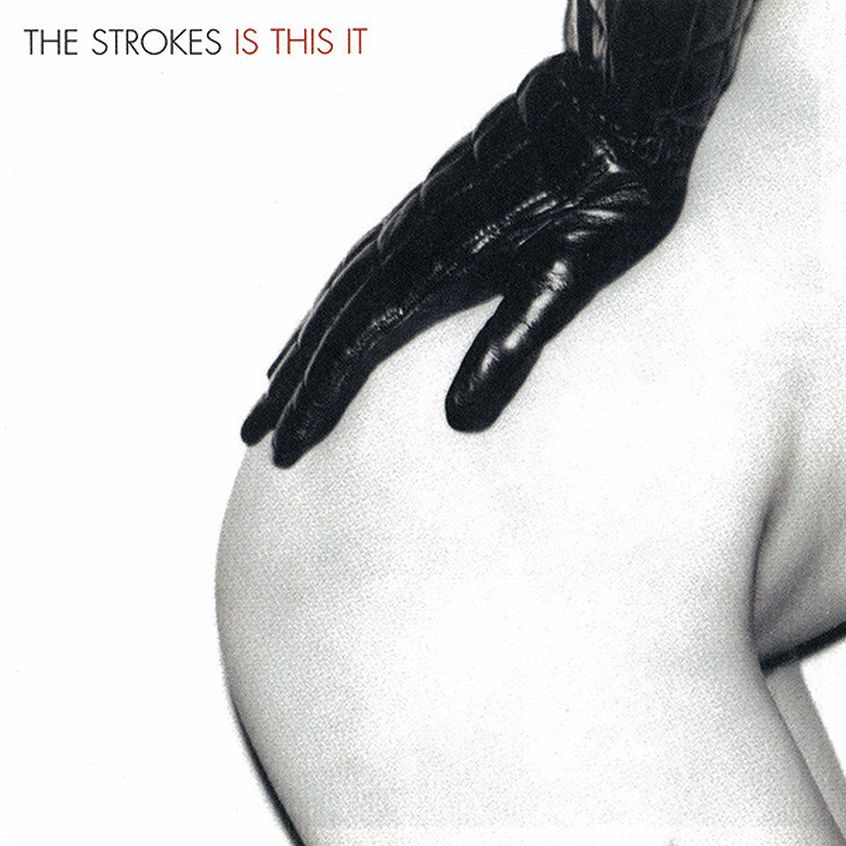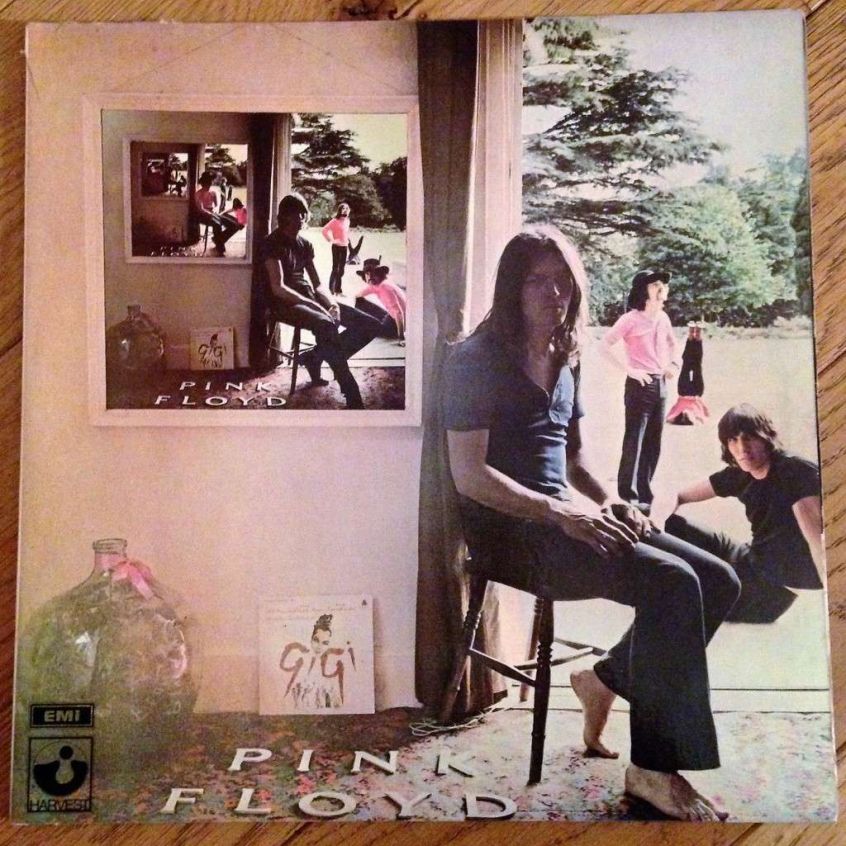Dura la vita per i gruppi cosiddetti post-grunge (almeno a posteriori, visto che “in diretta” molti di loro seppero beneficiare di grandi consensi di pubblico), accusati sostanzialmente di non avere inventato nulla (come se fosse sempre facile risalire all’ideatore principe di un suono o di un genere…), di salire sul carro dei vincitori, e in ultima di raschiare quel fondo del barile nel quale erano finiti tutti i sogni di milioni di adolescenti rimasti soli dopo il tremendo addio del loro uomo simbolo, Kurt Cobain.
Inutile girarci attorno, l’eco dello sparo improvviso che pose fine all’esistenza del leader dei Nirvana ha lasciato grandi strascichi, ma soprattutto un vuoto immenso: con l’esplosione del grunge era stata data voce a tante persone, soddisfacendo, o almeno attenuando, quel bisogno impellente di gridare contro le difficoltà , i disagi, le brutture di un mondo che sembrava sempre più emarginare chi non rispondeva a determinati canoni.
Molte di quelle persone decisero pure di imbracciare degli strumenti, e la cosa successe in differenti punti del globo, d’altronde quello passato alla storia come il Seattle-Sound aveva avuto il merito di rimettere al centro le chitarre, il rock… e per quanto poi, come ogni cosa, anche quel germoglio verrà poi fagocitato dal “sistema”, è indubbio che almeno agli inizi il tutto sembrava quanto di più genuino potesse sgorgare dalle menti e dai cuori di quei tormentati protagonisti, gente che metteva nero su bianco, con parole e note, le proprie vite e i propri demoni.
Con ogni probabilità dall’altro capo del mondo rispetto agli Usa, precisamente in Australia, anche i giovanissimi Daniel Johns, Ben Gillies e Chris Joannou rimasero letteralmente folgorati dalla potenza abrasiva emanata da quei dischi e pensarono che mediante la musica sarebbe stato possibile esprimere tutto il magma emozionale che un adolescente riesce a contenere dentro di sè.
E loro, i futuri Silverchair, adolescenti lo erano per davvero, essendo nati tutti e tre nel 1979 e quindi appena sedicenni all’epoca del debut-album intitolato “Frogstomp”.
Un disco quello in grado subito di imporli all’attenzione generale, grazie a una manciata di singoli dall’elevatissimo appeal commerciale, a una notevole presenza scenica e alla freschezza di una proposta che, seppur chiaramente derivativa (col nume tutelare Cobain ben presente), lasciava aperte interessanti prospettive future, ma soprattutto faceva nutrire tanta speranza nel presente.
Fu un successo clamoroso di pubblico, e pure la critica evitò di stroncarne le intenzioni, concedendo il beneficio del dubbio in virtù appunto dell’età dei protagonisti, per i quali era legittimo prevedere ampi margini di crescita.
Nel 1997, con i Nostri in transito verso la maggiore età (il carismatico frontman Daniel Johns avrebbe compiuto 18 anni ad aprile), i tempi erano maturi per un degno successore, e parecchie le attese riposte in “Freak Show”, che vide la luce il 4 febbraio.
Già il singolo “Freak” non tradì le grandi aspettative sul ritorno in pista del trio, rimanendo fedele al sound dell’esordio, forte quindi di un apparato musicale memore ancora una volta della lezione delle grandi grunge-band, sia per la struttura musicale (in fondo semplice, nel suo alternarsi di “piano” e “forte”, con tanto di ritornello deflagrante), che per testi disillusi, dove il mix di ironia e disperazione la faceva nuovamente da padrone.
Tutte componenti che si potevano ritrovare non solo negli altri episodi salienti di un album (ottimamente prodotto da Nick Launay) in grado di confermare il boom del suo predecessore (ampliando oltretutto a dismisura la fanbase del gruppo), ma un po’ in tutte le tracce, non facendo evidenziare chissà quale scarto qualitativo tra un brano e l’altro.
Certo, a fare la parte del leone, comparendo in alto nelle charts internazionali, saranno le famose “Slave”, “Abuse Me” e “Cemetery”, tutti episodi intensi, orecchiabili e dal buon tasso melodico (indubbi meriti in tal senso vanno al missaggio di Andy Wallace, nome che per gli avvezzi a certo rock del periodo non ha bisogno di presentazioni), ma non sono da meno l’adrenalinica “The Door”, la più cadenzata “Roses” – con i suoi potenti riff alla Alice In Chains -, la dolente ballad “Petrol & Chlorine”, dal gustoso arrangiamento d’archi, e le le paradigmatiche “Learn to Hate” e “Lie to Me”, figlie illegittime di Cobain e soci (l’ultima in effetti a esser buoni sembra una cover non riconosciuta della rabbiosa “Territorial Pissings”).
Qualche seme di un futuro cambiamento iniziava ad albergare già qui dentro, ma sarà decisamente col prossimo passo, testimoniato da un solido album come “Neon Ballroom”, che i Silverchair entreranno a piedi uniti in una fase più matura e consapevole, smettendo i panni dei ragazzini arrabbiati per provare a incanalare i loro sentimenti in maniera più profonda e ragionata.
“Freak Show” rimane ad ogni modo, a distanza di ben venticinque anni dalla sua pubblicazione, un lavoro dignitoso e assolutamente ben congegnato, e con un pugno di canzoni che si fanno ricordare (e amare) ancora adesso, cosa che non si può dire con la stessa facilità di altre band loro coeve.
Data di pubblicazione: 4 febbraio 1997
Tracce: 13
Lunghezza: 52:08
Etichetta: Murmur/Sony Records
Produttore: Nick Launay
Tracklist
1. Slave
2. Freak
3. Abuse Me
4. Lie to Me
5. No Association
6. Cemetery
7. The Door
8. Pop Song for Us Rejects
9. Learn to Hate
10. Petrol & Chlorine
11. Roses
12. Nobody Came
13. The Closing