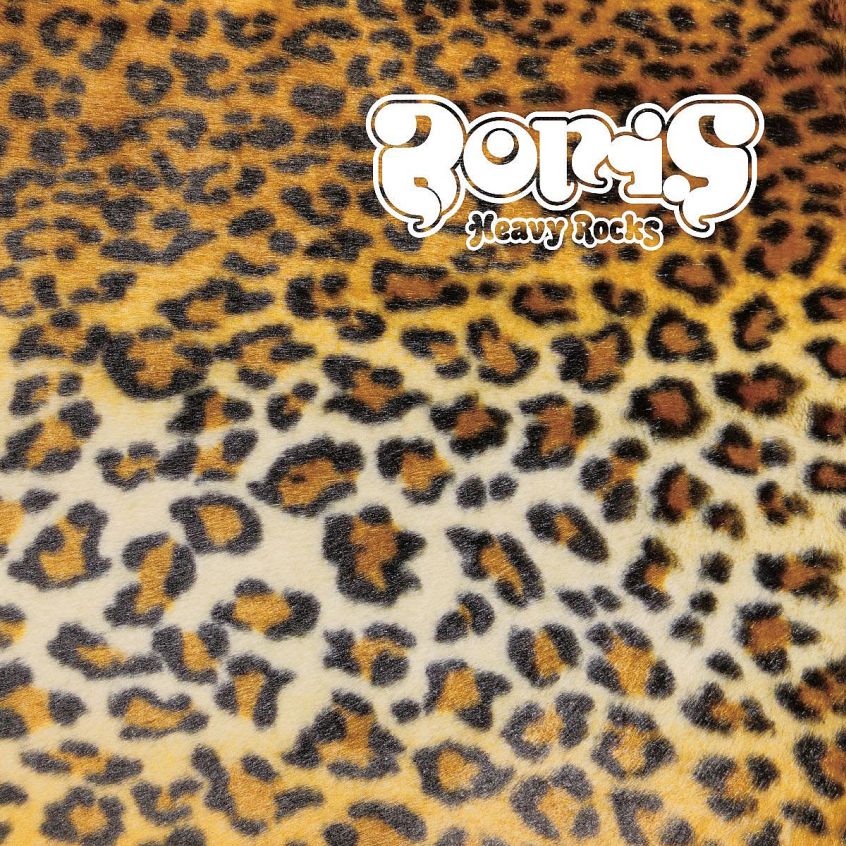Dopo averci cullato con le note dolci e sognanti di “W” all’inizio dell’anno, i Boris tornano ad alzare i volumi con il terzo capitolo della serie “Heavy Rocks”. Una copertina leopardata e superkitsch per accompagnare un disco a dir poco fragoroso, caratterizzato com’è da sonorità forti, crude e un po’ vintage. Un’opera dalla spiccata natura live, con pochi fronzoli e tanta energia, che il trio giapponese ha affermato di aver concepito come umile omaggio al proto-metal degli anni ’70.
Una sfida di un certo livello con cui la band di Tokyo celebra il trentesimo anniversario di una carriera multiforme e in perenne crescita, segnata dalle continue e talvolta imprevedibili evoluzioni stilistiche disseminate nelle decine e decine di uscite sparse nel corso del tempo. Questa nuova pagina del ciclo “Heavy Rocks”, nonostante il forte legame con un genere tanto arcaico quanto poco definito come il proto-metal, rappresenta per i Boris l’ennesima buona scusa per improvvisare, rinnovarsi e allargare ulteriormente i propri confini.
Una prova ambiziosa che il gruppo affronta con maturità , curiosità e il consueto spirito “jammistico”, senza aver paura di buttare nel piatto elementi estranei per un contesto hard & heavy “preistorico”. La potenza punk che incendia le note di “My Name Is Blank” e “Chained”, così come le evidenti influenze industrial metal che trasformano la già di per sè devastante “Ghostly Imagination” in una gragnola di mazzate, sono quanto di più moderno abbia da offrire un lavoro che, seppur ricco di contaminazioni e screziature, il più delle volte sembra rivolgersi a un passato decisamente lontano ma degno di essere ricordato, che vive di richiami alla psichedelia e al progressive più selvaggi (“She Is Burning”, “Blah Blah Blah”) ma anche di esplosioni incontrollate di rabbia primigenia (vedi i fiati impazziti alla John Zorn sparsi qua e là per tutto il disco).
Come accaduto un paio di anni fa nell’eccellente “NO”, in “Heavy Rocks” è la pesantezza pura e cruda a farla da padrona. I Boris rielaborano alla loro maniera le origini del metal e, pur concedendo qualche minimo spazio alla melodia, tramortiscono gli ascoltatori a colpi di thrash, noise, stoner, doom, drone e garage, in una spaventosa successione di rumorose bastonate dalla quale è impossibile trovare rifugio.
C’è un po’ di pace solo nella conclusiva “(Not) Last Song”, una lunga piano ballad molto intensa e sofferta. Un brano inquietante e spettrale che ben si inserisce in un album violento, grezzo e diretto che non regala troppe sorprese ma conferma l’ottimo stato di salute dei veterani Boris.