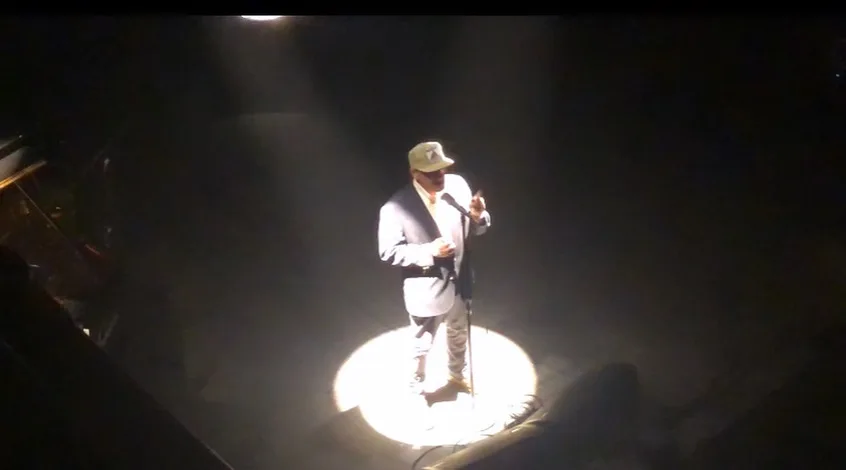Non c’è alcuna traccia di religiosità nella lunga carriera dei Lambchop, non c’è stata alcuna azione votiva in queste decadi di onorata esposizione del fottuto materiale nashviliano, ma evidentemente è giunto il momento di scontrarsi con una necessità oltremodo terrena di esprimere la propria spiritualità , il sacro che pulsa dentro di noi, le parole che aprono comunque uno squarcio di infinito che il buon Kurt Wagner ha voluto far coincidere con questa manciata di brani di “The Bible”, il titolo beffardo ma azzeccato di questa ennesima prova del suo gruppo copertura preferito.
L’album raccoglie i momenti salienti della recente vita del leader intrisi nella profondità e densità del tema della mortalità , coincidente con quella vera del padre, fonte da cui attinge in diverse misure l’album fin dall’iniziale toccante ” A song is sung” , ma più ampiamente con la fragilità non eterna dei nostri pensieri, sulle riflessioni che un 65enne può avere il lusso e la libertà ambiziosa di fare, a partire proprio sull’inesorabile passare del tempo (“Every child begins the world again”), sulle dolorose sliding doors sentimentali che riappaiono come lampi nella memoria affettiva (“Daisy”), in generale sulla percezione della sensibilità che non riusciamo ad afferrare nella solitudine del nostro io (“Whatever, mortal”), appeli mistici di presenze lontane ma apparentemente reali (“A major minor drag”) con tutta la consapevolezza di questi tempi di routine banale in cui siamo sommersi ma che non ci deve impedire di avere uno sguardo oltre, un azzardo di vera realtà .
E di azzardi questo album ne è pieno, soprattutto musicalmente parlando, con una sommessa vitalità di sperimentazione coerente con l’ultimo periodo dei Lambchop, ma che qui si accompagna ad un ambiziosa eterogenia di stili, che vanno dalle ballad stile Bacharach/Cohen (“Daisy”, “Every child…”) a cose nu soul (“Little black boxes”, “Police dog blues”) care all’amico Bon Iver di cui ha preso in prestito l’ala produttiva nella figura di Ryan Olson, con tutti gli annessi e connessi dell’utilizzo diffuso dell’audiotune e della tecnologia applicata all’uso della voce; dopodichè, lentamente ad ogni ascolto cresce l’ammirazione per la minuziosità degli arrangiamenti, che appunto prendono livello dal perfetto incastro della pletora di musicisti utilizzati, che si allineano con la loro maestria a questa delicata sacralità di trattamento a cui queste canzoni sono sottoposte (la chitarra ed il coro gospel in “Police dog blues”, il beat di “Little black boxes”, il superbo basso nu jazz di “Whatever, mortal”, ad esempio)
Ne esce un disco a tratti sontuoso, carico di significati e dall’ascolto pretenzioso, di un livello di scrittura molto elevato, che non vuole sorprendere ma narrare lo spirito di questi tempi, un libro musicale aperto, vario ,leggero e profondo insieme, anni luce dalle rivisitazioni country dei primi Lambchop, molto più in linea con tutto quello che la tradizione americana degli ultimi 30 anni ha prodotto in termini musicali. Insomma un disco d’autore, sempre più raro e sempre per meno persone, straniante e stridente se per questo intendiamo ad esempio l’inflazionato uso dell’audiotune ad una voce del tutto slegata da questa finzione tecnologica e certamente lontana anni luce da ciò che mediamente i fan della band amano e avrebbero voluto continuare ad ascoltare, ammesso che i primi fan dei Lambchop si siano già dimenticati da tempo delle fortune del nostro; ma Wagner un pò fuoriclasse lo è sempre stato, trova l’umiltà e il coraggio di pretendere di migliorare, di sfidare il suo pubblico verso nuovi territori con la sola forma di contatto col passato data dalla coerenza e profondità del percorso, si potrebbe dire dal modo in cui propone le cose, come nel caso di questo “The Bible” dove si compie il mezzo miracolo di rimanere al passo coi tempi musicalmente, permettendo comunque di rendere questa apologia della fase adulta della vita un pò meno decadente di quanto in realtà amaramente consiste.