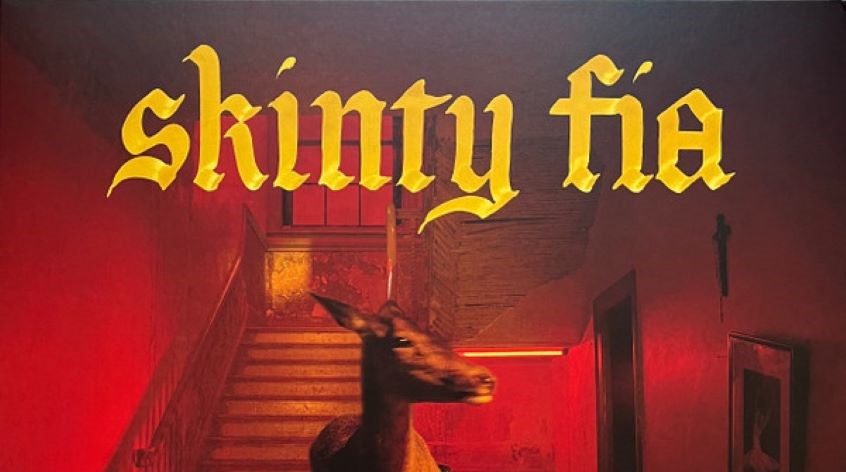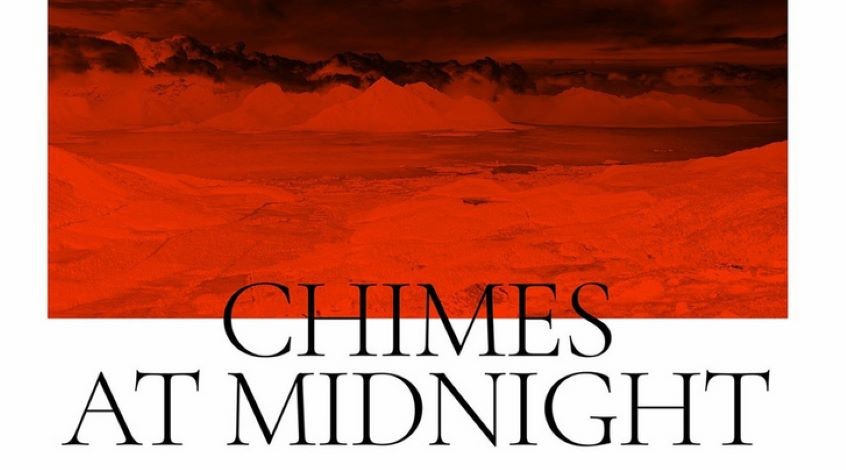10. SWEET TRIP
10. SWEET TRIP
Seen/Unseen
[Darla Records]
La nostra recensione
Canto del cigno per i californiani, tornati in auge per un breve lasso di tempo lo scorso anno con il tardo “A Tiny House, in Secret Speeches, Polar Equals“, prima del definitivo scioglimento a causa di circostanze mai del tutto chiarite, che hanno ammantato con un drappo di vergogna questo epitaffio. Trattasi di una raccolta di scarti, b-side e out-takes, un blocco di 50 pezzi registrati nell’arco d’un trentennio, che può servire da base, a chi lo vorrà , per scoprire uno dei gruppi di eccitanti dell’indietronica anni 2000.
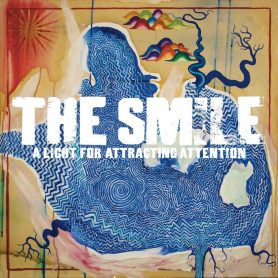 9. THE SMILE
9. THE SMILE
A Light for Attracting Attention
[XL]
La nostra recensione
Spin-off dei Radiohead, o, come dicono i maligni, il disco che i Radiohead non hanno avuto il coraggio di far uscire a proprio nome? A noi non ce ne frega nulla, e ci godiamo questo lavoro degli Smile con i suoi arabeschi elettronici, gelidi e rarefatti (“Open the Floodgates” su tutti) che ci riportano indietro di una ventina d’anni, più o meno ai tempi di “Kid A” (guarda un po’), scossi dagli improvvisi movimenti tellurici di “We Don’t Know What Tomorrow Brings” e “You Will Never Work in Television Again”.
 8. BIG THIEF
8. BIG THIEF
Dragon New Warm Mountain I Believe In You
[4AD]
La nostra recensione
Dopo alcune prove discrete, i Big Thief si elevano decisamente al di sopra della media dei gruppi indie-folk loro coevi, con un mastodonte di 80 minuti che raccoglie flussi e suggestioni ad ampio spettro, arrivando a lambire anche l’alternative rock anni ’90. Degna menzione per la spettrale title track, ma irraggiungibile è la sensazionale “Simulation Swarm”, umile e toccante canzone d’amore, cullata da un basso slide basculante che la proietta tra le più incantevoli intuizioni armoniche del decennio.
 7. DUSTER
7. DUSTER
Together
[Numero Group]
La nostra recensione
I Duster tornano con il quarto lavoro, che segue di circa due anni l’omonimo album che aveva rotto un silenzio quasi ventennale. Band di culto dell’era di internet, il loro space-slowcore narcotizzato si cimenta in un’appassionato elogio della lentezza, spezzettato in tredici frammenti che trasudano pigrizia da routine, malessere quotidiano e riflessioni sul tempo che sembra sfuggirci di mano. Almeno fin quando non gli dedichiamo i nostri attimi di raccoglimento più intimi.
 6. BEACH HOUSE
6. BEACH HOUSE
Once Twice Melody
[Sub Pop]
La nostra recensione
Ed ecco il compendio definitivo di una delle band che hanno marchiato a ferro e fuoco l’ultimo quindicennio di storia del rock. “Once Twice Melody”, centellinato a puntate, è una specie di antologia dell’arte di Scally e Legrand, quasi alla pari del dittico che li elevò nell’Olimpo del genere – sì, sto parlando dell’accoppiata “Teen Dream” (2010) / “Bloom” (2012). “Superstar” potrebbe essere il loro capolavoro. Forse troppo lungo, ma, parlando dei Beach House, questa è solo una buona notizia.
 5. BLACK MIDI
5. BLACK MIDI
Hellfire
[Rough Trade]
La nostra recensione
Ormai senza limiti, i black midi, alla sfrenata ricerca della formula più cervellotica possibile. Giù per la china già colata dall’ottimo “Cavalcade” (2021), è ancora il progressive d’avanguardia il punto d’abbrivio del loro post-rock avveniristico, se possibile ancor più imprevedibile e stordente dello scorso capitolo. Il batterista Morgan Simpson può essere già considerato tra i più rivoluzionari di questo primo quarto di secolo. Manca solo un ultimo ingrediente: un “‘classico’ che si faccia ricordare negli anni (“Welcome to Hell”?, “Eat Man Eat”? “Sugar/Tzu”?).
 4. FONTAINES D.C.
4. FONTAINES D.C.
Skinty Fia
[Partisan]
La nostra recensione
Al terzo tentativo, dopo l’acclamato “Dogrel” (2019) e il più divisivo “A Hero’s Death” (2020), gli irlandesi conquistano definitivamente il mio cuore. “Skinty Fia” abbandona del tutto l’aspetto più giocosamente “punk” per concentrarsi su un lirismo cantautorale, schiena a schiena con una produzione che richiama tanto gli Interpol quanto il post-punk delle origini nella sua veste più cupa e “dark” (Joy Division, Bauhaus), il tutto declamato con un amabile accento da teppista di borgata. Vi sono margini di miglioramento? Assolutamente sì, e non potremmo rallegrarcene di più.
 3. BOBBY JOE LONG’S FRIENDSHIP PARTY
3. BOBBY JOE LONG’S FRIENDSHIP PARTY
Aoh!
[Aldebaran]
La nostra recensione
Al quarto album, l’Oscura Combo Romana, aka BJLFP, alza la posta e si trasforma in un gruppo synth-pop/punk a tutti gli effetti, una specie di incrocio fra Suicide, una goth-band, gli Offlaga Disco Pax e Lando Fiorini. Henry Bowers conquista definitivamente la palma di Andrew Eldritch della Prenestina, coatto al punto giusto per differenziarsi con onore dall’originale. Ne escono perle come l’amara “Chi ha ucciso Laura Palmer?”, la gustosa “Bela Lugosi’s Tanz”, e la truce danza sintetica di “Stuff da Night Starker”, ma l’esame di maturità è passato a pieni voti e l’album scorre senza riempitivi di sorta.
 2. ALVVAYS
2. ALVVAYS
Blue Rev
[Polyvinyl]
La nostra recensione
Terzo disco e terzo centro per la banda canadese capitanata da Molly Rankin e Alex O’Hanley, che perfezionano il loro connubio rètro fatto di My Bloody Valentine, Smiths e Cocteau Twins, il tutto corroborato da una sana spruzzata di brit-pop. Qui si supera pure il passato, grazie anche alla sezione ritmica nuova di zecca, che, in tandem con la chitarra di O’Hanley, mai così ispirata, si permette di sfuriare in lungo e in largo tra shoegaze (“Pharmacist”), il country & western di Johnny Marr (“Pressed”), punk (“Pomeranian Spinster”), new wave e synthpop (“Tom Verlaine”, “Velveteen”, “Very Online Guy”), in aggiunta al marchio di fabbrica, il jangle-pop anni ’80 di ascendenza C86. Ultima nota di merito: evitando accuratamente la struttura strofa-ritornello, l’estro si affranca finalmente dalle pastoie del dèjà vu.
 1. BLACK COUNTRY, NEW ROAD
1. BLACK COUNTRY, NEW ROAD
Ants From Up There
[Ninja Tune]
La nostra recensione
Dopo il celebrato “For the First Time” abbiamo speculato a più riprese su come si sarebbero fatti trovare i BCNR di fronte all’impegnativa prova del secondo album, citando decine e decine di casi in cui l’attesa ha presto lasciato il passo alla delusione, e, infine, all’indifferenza: ebbene, questi ragazzi ci hanno umiliato. “Ants From Up There” non è solo il miglior disco dell’anno, ma è forse uno dei lavori più affascinanti ed imprevedibili dai tempi di “Funeral” degli Arcade Fire (2004…sono proprio i canadesi a soppiantare gli Slint quali coordinate maestre, ma il risultato d’insieme suona come una nuova forma di post-rock da camera, con picchi di pathos degni della musica colta (“Bread Song”, “Haldern”, “Snow Globes”, “Basketball Shoes”), il tutto mantenendosi nel perimetro di una struttura “pop” di innovativa orecchiabilità (“Chaos Space Marine”, “Concorde”, “Good Will Hunting”, “The Place Where He Inserted the Blade”), senza mai azzardarsi a scadere nel banale. Qua dentro non c’è un singolo minuto di musica che non valga la pena di essere ascoltato: GRAZIE.