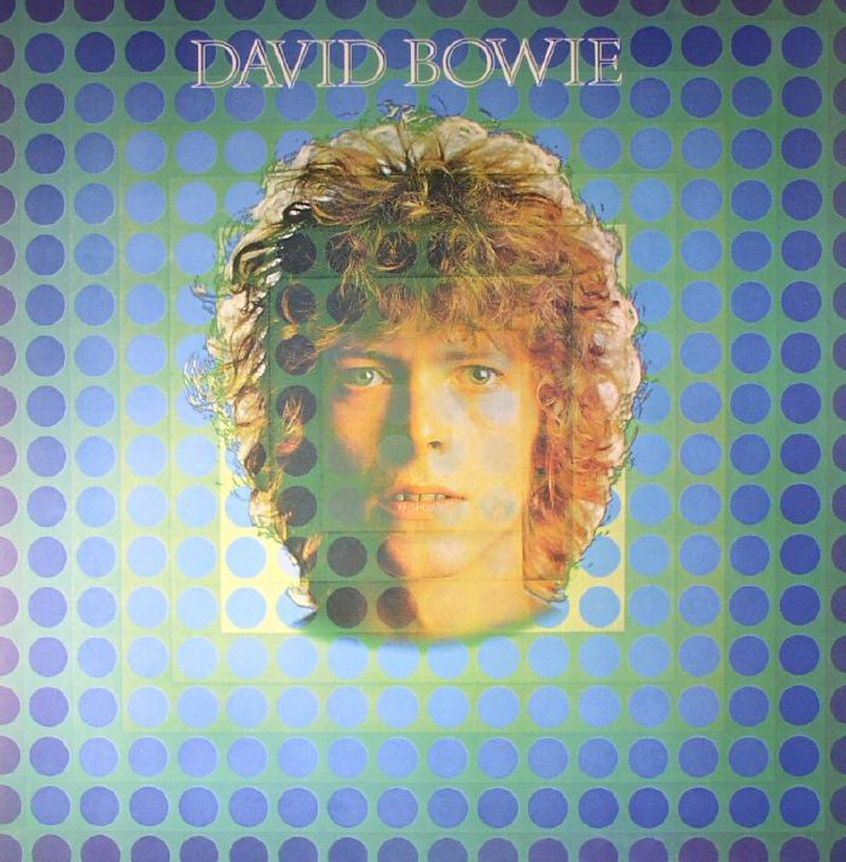Anche quest’anno è arrivato febbraio e il freddo, e con il freddo e con febbraio è arrivato anche l’evento culmine della discografia nazionale, la passerella fiorita del Festival di Sanremo, che quest’anno compie settantatré anni di musica, intrallazzi, lupi da interviste, accidentali resurrezioni e sacrifici umani ed artistici, contro-cultura istituzionalizzata e suicidi metaforici e concreti che in settantatré anni hanno lasciato davvero poca musica memorabile rispetto al monte di chiacchiere che da sempre accompagna la sfilata del Festival, riducendo ad un cicaleccio convulso e confuso quel posto magico in cui tutto è possibile e nulla è credibile, in cui gli opposti si attraggono e si uniformano nella proposta unica e ripetibile (sì, perché ad ogni edizione di fondo la solfa è la stessa) di una rassegna che sta assumendo, di anno in anno, sempre più le fattezze di un qualcosa di rinunciabilissimo a cui davvero non ci riesce di rinunciare.
Il sottoscritto, certo, lo sa bene, e ugualmente non riesce a rinunciare ai suoi papirozzi d’occasione, perché io da pecora nera non ho intenzione di morire, e unirmi alla schiera di petulanti avvocati difensori o giudici di Sanremo non mi dispiace affatto: la compagnia è in effetti pessima, ma chi sono io per tirarmene fuori, soprattutto se chiamato all’opera dalla mirabolante redazione di IFB? E allora, eccomi qui, sulle ultime battute del Festival, a condensarvi tutta la mia frustrazione di uomo senziente nel papirozzo vagamente moralista che segue.
Va detto, però: è un papirozzo, il mio, che in effetti non prova nemmeno lontanamente a rivaleggiare con l’assoluta nullità dei monologhi sanremesi, è una morale, la mia, che nemmeno lontanamente può ambire a confrontarsi con la caratura intellettuale di influencers che predicano la liberazione del corpo disegnandosi un paio di tette su un vestito costato una fortuna (trovo incredibile scoprire che qualcuno possa pagare chissà quante migliaia di euro per un abito che prova a riprodurre la naturalezza della nudità – “ci tengo a tranquillizzare tutti, non sono mica nuda!”, cit. -, con il quale lanciarsi in un monologo egoriferito sulla naturalezza della nudità che prova pure ad essere “scandalistico” e caustico ma che alla fine riesce solo a disegnarsi lo scandalo addosso perché di scandalizzato, al giorno d’oggi, non c’è più nessuno – e ci mancherebbe lo fosse per così poco).
Non ha di certo, il mio papirozzo, neanche la pretesa di apparire linea guida interpretativa di un fenomeno di costume, quello dell’italiano un po’ boomer che si rivede esattamente nella figura di Amadeus, vaso di terracotta tramutatosi in vaso di ferro (per non si sa ancora quale precipua chiamata del destino) che fa la parte di quello che ama la gioventù dimostrando di non conoscere altro che i nomi che l’industria discografica associa ad un’idea mercificata di gioventù; che resuscita dall’obitorio musicale con la scusa del revival artisti di cui ci ricordiamo solo perché ad un certo punto sono scomparsi dalle scene (e a ragion veduta); che fa tutto quello che può per fare la parte dell’anti-social prestato al mondo dei social trasformando alla fine il Festival della Canzone Italiana nel Festival del Selfie e del Tag Instagram, in un’esaltazione proprio non necessaria e anche un po’ fastidiosa del mondo del network partita come “gag” della rassegna e poi divenuta unico filo conduttore e chiave di interpretazione di una kermesse che, quest’anno più che mai, ha voluto sottolineare che l’immagine conta molto più del contenuto; che chiama per questo la Ferragni a fargli da spalla (perché la donna, quella vera, resta sempre un passo dietro l’uomo) e a tenere un monologo squisitamente egoriferito sulle donne per poi sottolineare al termine della cosa (dico “cosa” perché altrimenti non saprei definirla), con la solita dose di plateale disonestà intellettuale orgogliosamente nazionale, quanto fosse stupefacente che quel monologo l’avesse davvero scritto la Ferragni “tutto da sola!” (questo momento, davvero, è stato incredibile); che dimostra che in Italia chiunque può diventare direttore artistico – a parte quelli che hanno studiato per farlo. E gli effetti, indubbiamente, si vedono e si avvertono anche al di fuori del Festival, nella vita di tutti i giorni.
Un papirozzo, il mio, che in effetti parla poco (anzi, per niente, fin qui) di musica, ma solo perché in fondo la musica è diventata nient’altro che la scusa per organizzare un ricco festival di cinque giorni in diretta mondiale, l’occasione per ritrovarsi ogni anno a contemplare l’assoluta nullità della nostra idea di intrattenimento all’italiana, di varietà di periferia che si arroga la nobiltà della kermesse artistica; la musica come sfondo di una rassegna della “Canzone” per la quale qualcuno è stato disposto a morire (e non simbolicamente) e che oggi diventa la mangiatoia di chi s’ingrassa a confezionare (e con sempre meno attenzione, anche “commercialmente” parlando) fenomeni che non sono altro che fenomeni, transitori e destinati a depauperare la nostra idea nel mondo di “italianità” sconvolgendo alla base la natura di una kermesse nata per promuovere la “canzone italiana” come fatto culturale, come eredità e allo stesso tempo sviluppo di un patrimonio artistico ben preciso.
Sì, perché “Canzone Italiana” non è semplicemente una locuzione un po’ attempata (e dal vago retrogusto di Ventennio, che fa sempre gongolare anche il più progressista degli italiani) con la quale identificare qualsiasi parola vergata in Italia, ma una “forma” ben precisa che identifica un certo tipo di proposta, di scrittura, di ricerca estetica, un certo tipo di Storia, che chi organizza un Festival dedicato alla “canzone italiana” dovrebbe conoscere e possedere, sia che voglia organizzare una kermesse “ri-evocativa” dei fasti passati sia che sia intenzionato ad allestire un’edizione rivoluzionaria.
Sì, perché le rivoluzioni partono, in primis, dall’analisi: senza analisi, senza conoscenza dei “perché” e dei “per cosa”, si finisce solo con il distruggere senza cambiare proprio un bel niente e senza neppure poter godere dell’aspetto escatologicamente creativo della distruzione; e allora i Maneskin diventano come i The Who solo perché scassano chitarre e alla domanda “perché hai distrutto il palco dell’Ariston?” Blanco risponde che “eh, non sentivo la mia voce in cuffia” (ma sono del mestiere, questi?!) e che “la musica è così, bisogna divertirsi e io mi sono divertito”, perché divertirsi è uguale a distruggere senza sapere nemmeno perché lo fai. E poi il ragazzo “è giovane, ha vent’anni è normale fare queste cose!”, come se tutti i ventenni fossero così o come se, al di fuori dello showbiz, a tutti i ventenni fosse permesso di “comprarsi” il Green Pass riscuotendo persino l’appoggio, a mo’ di rassicurazione, di una vasta parte della pubblica piazza, o di distruggere casa/scuola/uffici impunemente.
No, non sono così i giovani d’oggi, e non per qualche manifesta superiorità morale rispetto agli artisti della loro generazione, ma semplicemente perché non possono esserlo, non possono permetterselo, e se lo fanno è giusto che paghino o abbiano la forza di motivare i loro gesti, e non solo a vent’anni ma anche a trenta, cinquanta, ottanta: la distruzione fine a sé stessa, concreta o simbolica che sia, è appannaggio dei privilegiati e dei criminali, nulla ha a che vedere con la normalità, a nessuna età.
Non sto cadendo nel cliché del “che messaggio diamo alle nuove generazioni, Amadeus!” o polverose sentenze simili, chiedo molto meno da spettatore della Gen Z rappresentata largamente sul palco dell’Ariston, chiedo che non venga lanciato proprio nessun messaggio, nessuna esaltazione un po’ bonaria dei giovani ribelli di oggi: non stiamo ad incensare un’idea di gioventù che nulla ha che vedere con una dimensione generazionale (io me ne dissocio!), ma che assume piuttosto le fattezze di una distorsione di massa alla quale, dai che ti ridài, finiscono col credere anche i miei coetanei. Anche perché là fuori, nel mondo vero, se rompi paghi. Metaforicamente ma sopratutto fuor di metafora.
Senza analisi, della rivoluzione rimane solo il simulacro del gesto e poco più: un palco devastato, un pubblico fintamente indignato o fintamente compiaciuto (il confine fra gli opposti, nella diseducazione sentimentale contemporanea, è labile se non inesistente), un’idea denigratoria di gioventù, di canzone all’italiana, di qualità, di normalità e di straordinarietà, di rivoluzione. Ecco, questo è Sanremo, una kermesse piena di gesti, di bei ceroni e miracoli della genetica e della chirurgia, che stanno alla Canzone Italiana come Maneskin e Blanco stanno al rock’n’roll: come un bel vestito da mettere sullo specchio, per non scoprire che, riflesso nello specchio, non c’è proprio niente. E dal momento che di musica non s’è parlato nel mio infuocato e forse fin troppo riottoso papirotto moraleggiante, beccatevi ‘ste pagelle infuriate, in rigoroso ordine di apparizione degli artisti, che provano a raccontare le prime due giornate di un Festival sempre più triste, anno dopo anno. E ridiamoci sopra.
N.B.: le valutazioni personali che seguono (così come il papirozzo introduttivo) sono state tutte scritte – rigorosamente a caldo – al termine delle esibizioni dei primi due giorni di Festival, e non tengono perciò conto né dei duetti, né delle successive reinterpretazioni dei brani, né del podio finale maturato nell’ultima sera. Questa nota la scrivo oggi, domenica 12 febbraio, perché nel corso della rassegna non ho cambiato idea su nulla di ciò che ho scritto, e ci tenevo a ribadirlo.
ANNA OXA, Sali
Parte così il Festival, con il ritorno a Sanremo di una delle voci più importanti della recente storia nazionale prestata per l’occasione ad una performance che richiama la dimensione del rito, della sabba, dell’incontro ultraterreno: la vocalità della Oxa “sale” e non scende più, il testo finisce un po’ col perdersi ma, al netto di tutti gli imbecilli che hanno fatto ironia sulla prestazione decisamente “drammatica” dell’artista, ad averne di artisti tanto competenti.
gIANMARIA, Mostri
Lui è proprio caruccio, mi piace la sua spontaneità e anche il look sbarazzino ma semplice, elegante, con cui si presenta sul palco dell’Ariston. La canzone si fa ascoltare, nulla di eclatante ma nemmeno di insopportabile; metterlo per secondo, dopo la performance un po’ spiritata di Anna Oxa, è un po’ come dire al pubblico “tranquilli, andrà tutto bene”. Grande bugia, nell’evolversi dei fatti.
MR RAIN, Supereroi
Ti piace vincere facile? Allora sali sul palco di Sanremo, canta una canzone ben scritta, magari cantala anche bene (che oggi vuol dire, quantomeno, non andare a pesca delle note giuste nella grande cloaca dei rigurgiti da bevitore che la preparazione media sanremese degli interpreti delle ultime edizioni del Festival “offre” all’ascolto) e porta con te dei bambini. Comunque, a mio parere, una delle migliori canzoni della kermesse.
MARCO MENGONI, Due vite
La miglior voce maschile del festival, aiutata da una scrittura che permette a Mengoni di muoversi nella sua comfort zone – che è quella della canzone sanremese: quindi tutto ok Marco, almeno tu hai capito dove ti trovi e non cerchi alcun sensazionalismo per colmare lacune che, in effetti, dimostri di non avere. Quantomeno a livello tecnico: abbiamo mai cercato da Sanremo qualcosa di più del “belcanto”? Ecco, negli anni in cui Sanremo sembra aver dimenticato cosa sia la “canzone italiana” che promuove, Mengoni ricorda a tutti la differenza tra un professionista e un amatore.
ARIETE, Mare di guai
Indie-dream team per la scrittura collettiva di un brano che, nell’interpretazione di Ariete, diventa un incubo riuscito. La canzone dice poco, ma quel poco che dice rimane compassato nell’interpretazione amatoriale di una voce che sembra aver esaurito tutta la sua forza espressiva nell’immagine che la contiene. Ma siamo davvero sicuri che le nuove generazioni si rispecchino in Ariete? O forse Ariete è l’unico specchio che si è deciso di imporre agli occhi di una generazione passivizzata dalle scelte del mercato? Siamo davvero in un mare di guai.
ULTIMO, Alba
Dopo il guanto di sfida lanciato contro la sala stampa durante gli strascichi infuocati della sua ultima partecipazione sanremese, Ultimo torna al Festival con il più classico dei suoi brani che da un lato conferma il timbro autorale dell’artista, dall’altro non mostra nulla di diverso da ciò che l’artista fa da anni. Con il risultato che Ultimo continuerà a piacere a chi è sempre piaciuto, a meno che la noia della ripetizione seriale non faccia la sua parte anche sui fedelissimi. Fedele a sé stesso, nel dubbio, lui lo è rimasto.
COMA_COSE, L’addio
L’esclusiva mini-intervista regalata da Morandi al duo prima dell’esibizione (unici artisti ad averne effettivamente beneficiato durante la prima serata del Festival) aiuta il pubblico a stringersi nell’abbraccio di una canzone che, al di là della performance (non proprio esaltante a livello tecnico, anche se California sembra aver fatto passi avanti importanti dal punto di vista della consapevolezza vocale), racconta qualcosa di “vero”. Magra consolazione, ma in tempi di guerra ogni buco è trincea e lo spiraglio di autenticità offerto da “L’addio” diventa un riparo sicuro dall’anonimato della rassegna.
ELODIE, Due
Lei è brava, sa cantare molto bene e la sua presenza buca l’occhio. Sulla canzone, c’è poco altro da dire, ma già il fatto di non trovare debolezze macroscopiche nel brano di Elodie e nella sua interpretazione del tutto non è mica male.
LEO GASSMANN, Terzo cuore
Leo è un bravo ragazzo, si vede subito, e di bravi ragazzi in giro ce ne sono tanti. Poi, comunque, sa anche cantare, e anche di bravi ragazzi che sanno cantare, in giro, ce ne sono tanti (a differenza dei talent scout, che invece sembrano aver abdicato alla semplificazione sempliciotta dei talent show). Se poi ad un bravo ragazzo che sa cantare metti in mano una canzone di Zanotti nell’era dell’egemonia dei PTN sul pop italiano, allora il risultato è garantito. Con la scadenza sul retro, ma intanto aiuta la digestione del tutto.
CUGINI DI CAMPAGNA, Lettera 22
Raga, giuro che tutto mi aspettavo tranne che, alla fina della prima giornata di Festival, i miei preferiti sarebbero stati loro: gli inossidabili Cugini della canzone italiana si re-inventano mostrando la continuità tra passato e presente (sul futuro, non me la sento di sbilanciarmi) all’insegna della scrittura di qualità. Un plauso, grande, va agli autori: LRDL ha saputo cucire la canzone giusta sulle paillettes del quartetto.
GIANLUCA GRIGNANI, Quando ti manca il fiato
Esautorato da Blanco dalla responsabilità di “fare del macello a Sanremo perché è ruock’n’roooll”, Grignani mostra i denti all’Ariston che non sono più quelli affilati, smaltati e brillanti degli inizi, ma risplendono della forza e del coraggio di un uomo, dietro l’artista, che ha compreso quanto coraggio ci voglia per essere fragili. Il brano è una delle poche cose autentiche che ho ascoltato durante questo Festival, e la sua emozionata interpretazione genuinamente claudicante è superiore agli sbiascicamenti (persino voluti e studiati!) delle nuove leve della canzone italiana.
OLLY, Polvere
Per Olly e i Colla Zio (che seguono qui sotto), vale lo stesso discorso: pur non rientrando esattamente nel tipo di canzone che amo, entrambi i progetti dimostrano che le cose migliori di Sanremo quest’anno le hanno tirate fuori le vecchie glorie e i nuovi arrivi. Un buon mood a metà tra pop, trap e urban che rotola bene, aiutato dalla sincera e quasi incredula felicità di Olly, che ha saputo trasmettere all’ascoltatore tutta la gioia che aveva in corpo nell’essere su quel palco da sogno.
COLLA ZIO, Non mi va
Allora, a primo acchito sono rimasto un po’ sconvolto dalla saltellante presenza scenica del gruppo, che per un attimo (un attimo piuttosto lungo, a dire il vero) mi ha dato l’impressione di trovarmi di fronte al revival dei Backstreet Boys offerto dal miniclub di un qualsiasi villaggio turistico del Gargano; la verità è che, nell’acerbità dei suoi interpreti, si profilano comunque talenti da tenere d’occhio. Non so quanto dureranno insieme (perché le boy-band funzionano finché si è “boy”), ma all’esordio sui grandi schermi si presentano con simpatia e con una discreta qualità che fa pensare bene per il futuro. E la canzone è caruccia.
MARA SATTEI, Duemilaminuti
Arriva in chiusura della prima tornata, e la posizione è simbolicamente opportuna per chiudere il primo girone con qualcosa che sappia lasciare il ricordo coerente di quanto successo fino a quel punto: una canzone che (toccando tasti anche delicati) sta in piedi senza brillare, cantata in modo non brillante da una cantante normale. Senza infamia e senza lode.
WILL, Stupido
E parte così, la seconda serata del Festival, e capisci che la solfa più o meno sarà la stessa del precedente giro; però, a dire il vero, Will al suo esordio sanremese riesce comunque a presentarsi con una canzone che gira, spinto dall’entusiasmo di un presente che non conosce confronti con il passato, perché il passato non c’è (almeno, a livello “pubblico”). Staremo a vedere.
MODA’, Lasciami
Non li sentivamo da un po’, eh? Che bei ricordi, l’infanzia, l’ingenuità, il trash-pop italiano dei primi Duemila, il gel nei capelli alla “italian playboy” di Kekko e la tua fidanzata che piangeva ascoltandoli e tu che facevi lo stesso, da giovane rocker e novello amatore, ma per motivi e con finalità diverse. Sono sempre loro, niente paura: un po’ più opachi e “albanizzati” rispetto al passato. Ma la canzone, per Sanremo, va più che bene.
SETHU, Cause perse
Canzone buona per andare a correre. Lontano dal televisore.
ARTICOLO 31, Un bel viaggio
Mi salta il cuore nel petto, perché sono comunque un sentimentale nostalgico, appena vedo i due incerati di bianco apparire lì sopra; poi, rimane solo il vuoto lasciato dal ricordo, al netto di un testo che, in stile “Memorie di Adriano”, sembra raccontare la parabola di quello che fu un imperatore, e che ora sembra vivere nei libri di storia. Però, a loro due, non smetto di volere un bene profondo e sincero che si esprime tutto nell’emozione di J-Ax a fine performance.
LAZZA, Cenere
Una delle performance più interessanti del Festival, una scoperta per chi non conosceva Lazza, una conferma per chi invece ha seguito dagli inizi il percorso dell’artista: il brano è ben pensato, ben arrangiato e ben scritto. In più, lui canta bene e quindi fa felici anche quelli che, di fronte al declino della canzone italiana come “forma” (e ben venga, se non venisse sostituita da Frankenstein autorali mal riusciti e barcollanti), si aggrappano al “belcanto”.
GIORGIA, Parole dette male
Ci sono rimasto un po’ male, perché l’aspettativa mi ha bruciato e forse tutto questo “mare di silenzio” che ha segnato gli ultimi anni di Giorgia ha rafforzato ancor più la mitologia di una voce perfetta, sublime, inappuntabile, quasi – appunto – disumana. Così, una buona prestazione canora appare sottotono perché lì, sul palco, c’è Giorgia e mica l’ultima delle arrivate, e una canzone che comunque si fa ascoltare (non è certo il capolavoro dell’artista, ma non è nemmeno qualcosa di così tremendo) risulta a primo ascolto un po’ deludente. A dire il vero anche il secondo, di ascolto, non aiuta un granché.
COLAPESCE, DIMARTINO, Splash
Se davvero Sanremo premiasse la “miglior canzone” della rassegna, se davvero l’Ariston fosse il luogo in cui celebrare la rigenerazione, di anno in anno, della “forma canzone italiana”, se sul serio fossimo tutti onesti intellettualmente e non fingessimo di poterci accontentare di belati amatoriali e personalità posticce e inamidate che amiamo chiamare “futuro”, allora dopo l’esibizione di Colapesce e Dimartino avremmo dovuto dichiarare conclusa la competizione per manifesta superiorità. Con la consapevolezza che, al netto dei meriti dei due bravi cantautori, nel regno dei nani anche gli uomini normali paiono giganti.
SHARI, Egoista
Sento vibrarmi tutto dentro ad ogni nota un po’ sostenuta di Shari, tipo l’effetto della poltrona rilassante ad intensità massima, con conseguente calo della tensione tempo zero. Non sono un grande amante di questo tipo di interpretazione “nu-soul”, ma c’è da dire che la giovanissima Shari rappresenta il “ricambio” generazionale che salva Sanremo dal tripudio del dilettantismo giovanilista dei colleghi coetanei.
MADAME, Il bene nel male
Madame è certamente il talento più fulgido della sua generazione, con una spiccata capacità di colmare le “lacune” (che i puristi bacchettoni – tipo me – potrebbero con grande fatica individuare nella sua proposta) attraverso un surplus di identità e personalità che indubbiamente non hanno pari tra i compagni di palco. Il brano di per sé, come tutti i brani di quest’anno, non è niente di speciale ma lei è magnetica, e il ritornello della canzone sarà l’unica cosa che rimarrà in testa alla fine dei giochi.
LEVANTE, Vivo
Impreziosisce di certo il finale della seconda giornata di Sanremo, Levante, che dimostra che la qualità musicale del festival sembra essersi davvero concentrata sul mercoledì. Arrivato fin qui, però, mi rendo anche conto di aver scritto più o meno lo stesso commento per tutti, e non capisco se la colpa è mia o di una rassegna che, di anno in anno, convince gli artisti affermati che a Sanremo ci si vada solo per passerella (e che quindi, insomma, anche se il pezzo è così così amen, perché la canzone conta davvero poco e l’importante è esserci) e assicura alle nuove leve un confronto artistico che, invece che creare modelli, mostra facili scorciatoie per un successo virtuale, inconsistente artisticamente e, in fin dei conti, anche commercialmente. Con tutto l’amore per Levante che comunque fa il suo, con un brano che non lascerà traccia di sé anche se decisamente tra i più gradevoli della rassegna.
TANANAI, Tango
La miglior sorpresa del Festival, con un netto miglioramento sotto ogni fronte: l’unico artista che, entrato da outsider un po’ sgangherato tra i nomi della scorsa rassegna, ha saputo alzare l’asticella rispetto al passato. Non chiediamo molto di più: solo che vengano rispettate le nostre intelligenze di pubblico, senza dover applaudire come scimmie ammaestrate chiunque solo perché oggi si fa così, e davanti al nulla ci si sente sempre più a casa e sempre meno spaesati, e disgustati, rispetto ad un tempo. E allora significa che, indubbiamente, la colpa di tutto questo è anche (e forse, soprattutto) nostra.
ROSA CHEMICAL, Made in Italy
Ma sì, va bene. Tutti a concentrarsi sulla parure, perché – ripetiamo – a Sanremo conta solo quello, sui trucchi, sulla fluidità e su questo monte di retorica, tutte cose che alla fine mettono in secondo piano la canzone e fanno comunque strappare l’applauso a Rosa. E questa la dice lunga sull’italiano medio, pronto ad applaudire il “progresso” (che aberrante parola, in nome della quale siamo disposti a regredire allo stato belluino di animali da pascolo perché il progresso è l’unico alibi che le pecore hanno per continuare ad essere tali, nei tempi della democrazia da gregge) e a vedere la rivoluzione in un paio di mani smaltate, e poi a votare Giorgia Meloni. Non è un discorso politico, è un dato di fatto. Che con la musica, a discapito di Rosa Chemical perché alla fine la canzone è anche divertente, c’entra davvero come me con il vero giornalismo musicale. “Made in Italy”: non si poteva pensare a titolo più azzeccato.
LDA, Se poi domani
A me il ragazzo piace, e alla fine anche la canzone non è affatto male. La voce c’è, la genetica non mente (nel bene e nel male), e la scrittura comunque è easy-listening sembra diventare stucchevole. Passa, non fa male e scivola via senza danni aggiuntivi.
PAOLA E CHIARA, Furore
Ne avevamo bisogno? No, assolutamente no, ma potremmo dire lo stesso per ognuna delle canzoni del Festival. Ma sul duo più iconico degli anni Novanta si può dire che la necrofilia della direzione artistica all’italiana abbia dato il suo contributo migliore: non pago di aver regalato Sanremo (sì, perché in assenza di meriti, quel palco diventa un dono gratuito) ad artisti capaci solo di smuovere share e social (fatta eccezione per qualche nome meno altisonante, e poi più interessante nei fatti), Amadeus riporta in vita dal regno delle ombre due ombre che si confermano tali, ombre appunto, e lo fa non per accanimento terapeutico ma per mero interesse di mercato, ricordando a tutti noi che al peggio davvero non c’è mai fine. Per fortuna, invece, Sanremo finisce, e i suoi fiori appassiranno fino alla primavera forzata del prossimo anno, che inevitabilmente dimostrerà ancora a tutti noi quanto ci fossimo adagiati sulla speranza che, più in basso di così, non potremo più scendere.