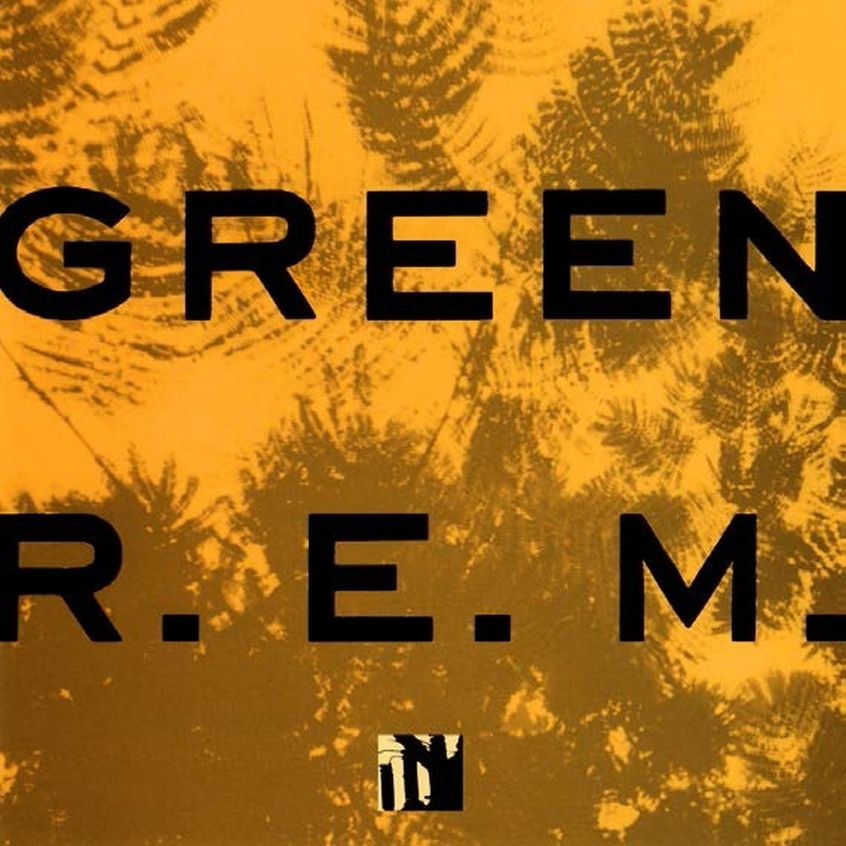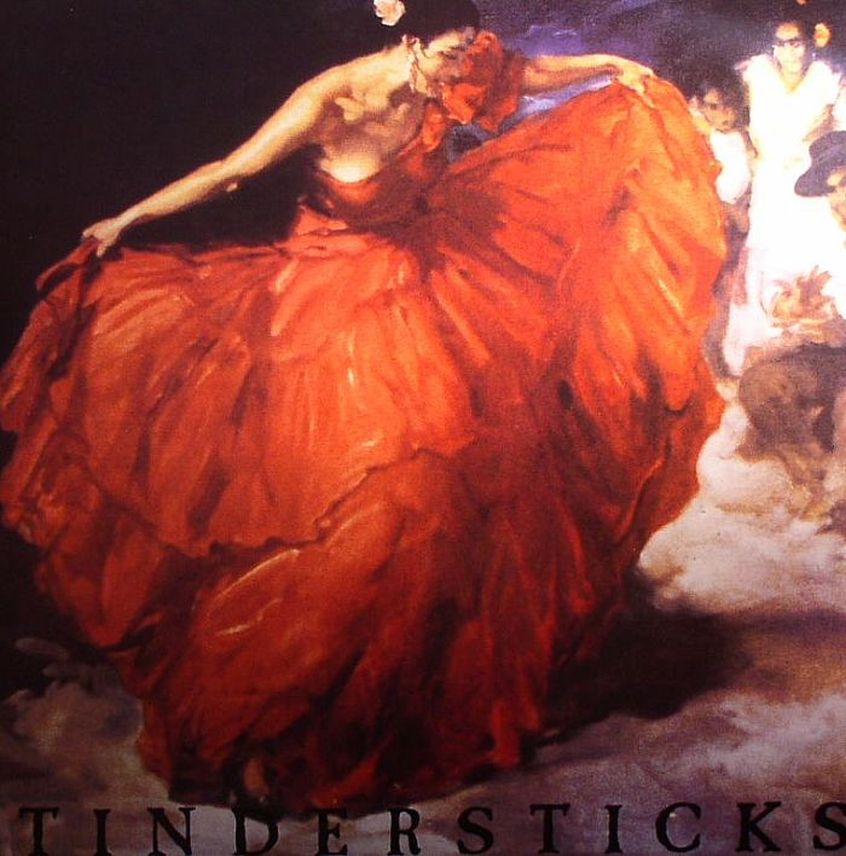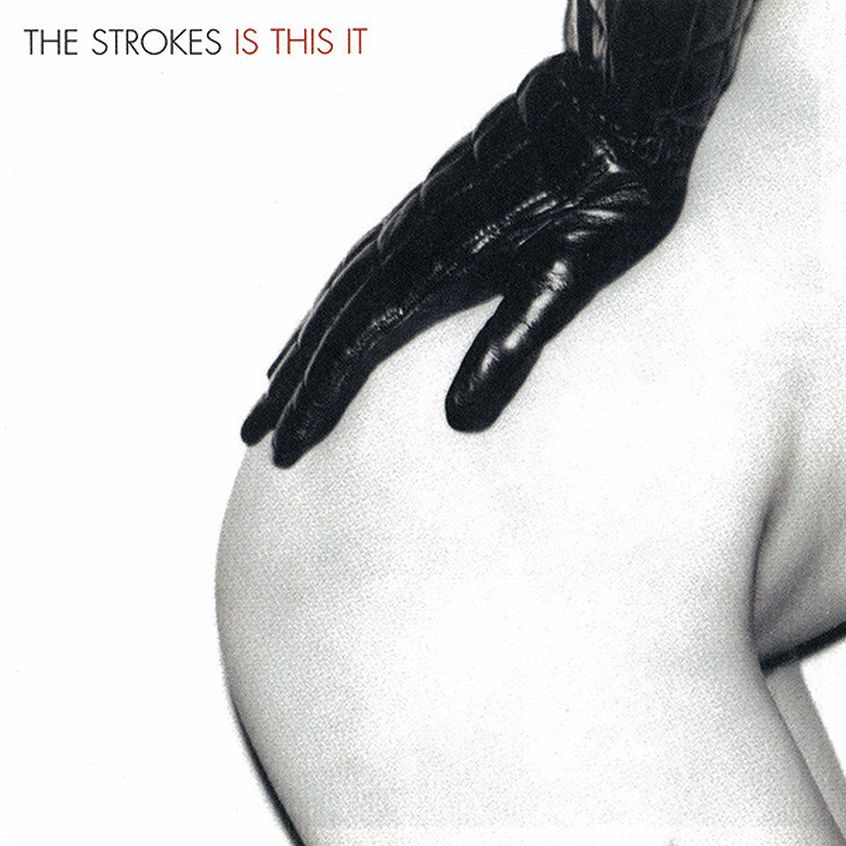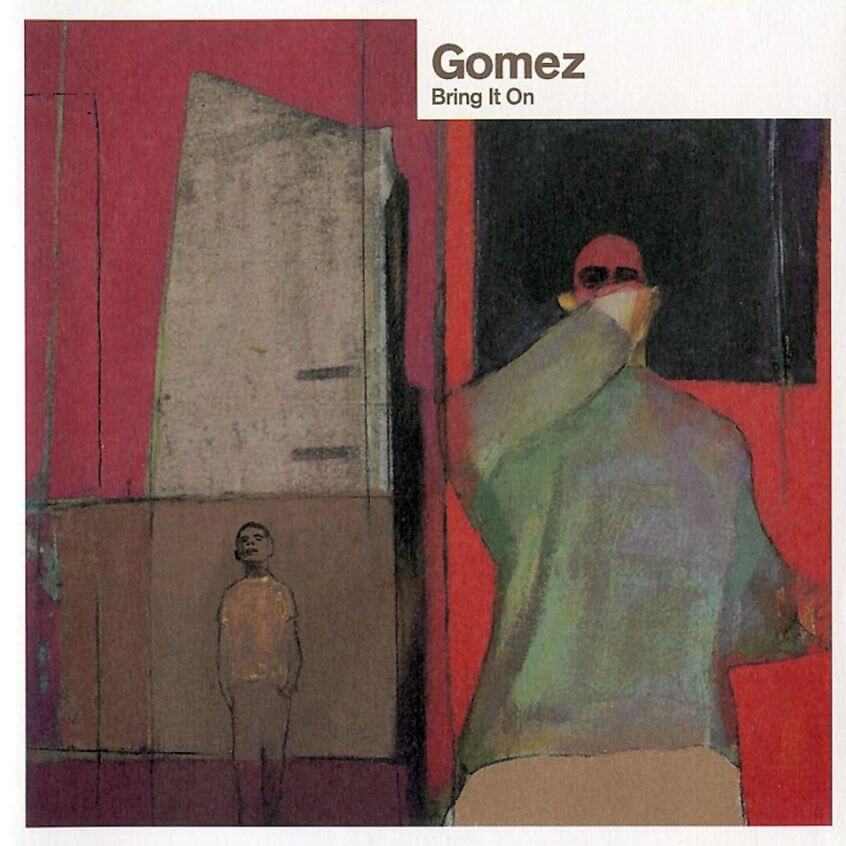
Sempre più spesso, quando ci troviamo a celebrare i compleanni dei dischi che amiamo, ci piace contestualizzarne il contenuto musicale perdendoci in spiegazioni infinite sui motivi per cui esso fosse, ad esempio, perfetto per il momento in cui è stato pubblicato e che, quindi, sia rimasto nella memoria collettiva non solo per la sua qualità, ma per come ha intercettato i gusti del pubblico dell’epoca, o per quanto è stato influente negli anni a seguire, o per altri mille motivi che, come detto, non riguardano le canzoni in sé. Ci sono alcuni casi, però, in cui le suddette canzoni rappresentavano una totale anomalia rispetto a tutto ciò che andava forte nel periodo in cui sono state pubblicate, e il motivo per cui ci troviamo ancora qui a celebrarne l’anniversario è uno solo: sono canzoni stupende e il disco in questione è semplicemente entusiasmante.
A chi mai poteva interessare, infatti, nella primavera del 1998, un lavoro discografico che aveva come ispirazione di base nientemeno che i canoni del blues? Questo discorso vale soprattutto per la Gran Bretagna, da dove i Gomez provengono, in un periodo in cui il britpop era sì in calo, ma certamente aveva ancora una certa rilevanza, e le sue alternative erano comunque costituite da suoni figli del proprio tempo o al massimo di pochi anni prima, senza che venisse ripreso alcun genere così risalente come, appunto, il quintetto di Southport ha fatto con il blues. Eppure, questo debutto ha sfiorato la Top 10 in Patria, ha poi vinto il Mercury Prize e non è mai finito nel dimenticatoio, tanto che il suo ventennale è stato celebrato con un tour che ha visto un pubblico completamente travolto da un entusiasmo incontenibile (parlo per la data di Glasgow a cui sono stato, ma penso che sia stato lo stesso per tutte le altre).
Quindi, come lo contestualizziamo un disco così? Semplice: non lo contestualizziamo. Perché è piaciuto e ancora piace così tanto? Perché è un disco fighissimo, punto e basta. Non servono elucubrazioni di sorta: i Gomez sono stati capaci di mettere insieme canzoni tanto originali quanto accattivanti, tanto raffinate tecnicamente quanto capaci di parlare alla pancia delle persone, tanto autorevoli quanto fresche e facilmente fruibili. Ho definito “base” l’ispirazione al blues perché si parte da esso, ma solo perché ai cinque serviva un modo per incanalare la propria straripante creatività, in termini sia di lavoro sul ritmo che di capacità di dare una bella rinfrescata al suono della tradizione.
“Bring It On”, quindi, mostra perfettamente, e meglio di ogni discorso teorico, che quando un disco è capace di coinvolgere e sorprendere sempre, grazie sia all’abbondanza di idee che, soprattutto, al modo in cui esse vengono messe assieme, può avere il successo che merita in barba alle mode. Mi si dirà che sono molti più numerosi gli esempi opposti, e non posso che concordare, ma ogni tanto, invece, è andata bene, quindi non tutto è perduto, nemmeno oggi.
I principali punti di forza di “Bring It On”, come accennato sopra, sono due. Il primo è il grande lavoro sul ritmo, con un campionario che va dal groove vellutato che ti entra sottopelle dell’iniziale “Get Miles”, al dinamismo sfrenato di “Whippin’ Piccadilly”, alla capacità di avvolgere in “Love Is Better Than A Warm Trombone”, a quella di dare la giusta concretezza in “Rie’s Wagon”. In generale, il ritmo viene utilizzato non come un semplice accompagnamento, ma come una parte integrante del concetto che sta dietro a ogni canzone, e ha quindi una funzione diversa quasi ogni volta. Saper usare così bene il ritmo, poi, significa anche sapere quando non usarlo, nel senso di non esagerare: ad esempio, in una canzone come “Tijuana Lady”, che è già così intensa di suo e non ha bisogno anche di una spinta ritmica, anzi, sta meglio senza; oppure in una “Make No Sound” che, per come è strutturata, ha bisogno della leggerezza che in effetti ha e che sarebbe stato un delitto non preservare.
L’altro aspetto maggiormente rimarchevole di quest’opera è il modo in cui un impianto sonoro che ha dei forti richiamo con il passato viene sempre reso vitale e intrigante e non si ha mai la sensazione di ascoltare un disco passatista, cosa che, infatti, “Bring It On” non è. Talvolta, questo risultato viene ottenuto grazie alla mescolanza con elementi elettronici che, in quel periodo, non erano certo così frequenti come lo sarebbero stati in seguito, e che per questo possono tranquillamente essere definiti come innovativi. Più spesso, però, l’impianto sonoro è costituito unicamente da elementi tradizionali, ma anche qui c’è sempre qualcosa che li fa suonare come moderni, tra l’importanza del ritmo descritta sopra, le armonie particolarmente azzeccate, l’interazione sempre diversa fra le tre voci con la scelta sempre ottimale di chi usare come solista. Mettiamoci, poi, il songwriting, aspetto fondamentale anche in un lavoro così ricco dal punto di vista sonoro come questo, ma che non avrebbe la stessa efficacia senza le sue melodie, tutte di grande spessore e dotate di una maturità che difficilmente si trova in un disco di debutto.
È davvero bello che un disco così a se stante, fuori da ogni tendenza musicale sia quando è uscito che in tutti gli anni successivi riscuota ancora l’interesse che serve perché venga degnamente ricordato. Il tour e l’edizione celebrativa li abbiamo già avuti, come detto, col ventennale, ma le nozze d’argento tra questo disco e il pubblico non possono passare inosservate. In alto i calici, dunque, per “Bring It On” e per la sua unicità.
Pubblicazione: 13 Aprile 1998
Genere: indie-rock, blues
Lunghezza: 54:06
Label: Hut
Produttore: Gomez
Tracklist:
Get Miles
Whippin’ Piccadilly
Make No Sound
78 Stone Wobble
Tijuana Lady
Here Comes the Breeze
Love Is Better Than a Warm Trombone
Get Myself Arrested
Free to Run
Bubble Gum Years
Rie’s Wagon
The Comeback