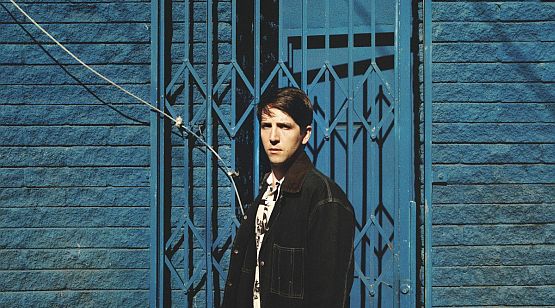Secondo album per Amber Bain in arte The Japanese House, dodici brani che confermano il talento della musicista inglese che è riuscita a mettersi in gioco, pur rimanendo fedele alle radici synth pop ed elettro pop che ne hanno segnato la fortunata carriera.

Copertina minimale ma significativa, un cerchio che si chiude, segno evidente che almeno alcuni dei dubbi che caratterizzavano vita e carattere di Amber Bain si sono trasformati in certezze. Katie Gavin dei MUNA, Chloe Kraemer nel ruolo di produttrice e ingegnere del suono, Justin Vernon (Bon Iver), Matty Healy e George Daniel dei The 1975 sono solo alcuni degli artisti presenti in questi quarantacinque minuti.
I tre singoli – “Sad to Breathe”, “Boyhood”, “Sunshine Baby”con Healy – sono la base ritmica e sonora su cui costruire un pop sfaccettato e spesso malinconico, che non lascia nulla al caso ma mantiene un filo di mistero sulla vita di Amber. Relazioni a due o multiple, che finiscono bene o male, riflessioni senza filtri su passato e presente inizialmente composte al piano e poi rielaborate con pazienza fino ad arrivare a quel suono melanconico e confidenziale che è ormai la cifra stilistica di The Japanese House.
Nascosti tra le mille pieghe, le tante svolte a sorpresa di “In The End It Always Does” ci sono forse i brani migliori, quelli più intimi. “Touching Yourself”, “Over There” e “Morning Pages” dove le voci di Bain e Gavin riescono a costruire un bel crescendo emotivo e sonoro tra gioia e tristezza in un buon esempio di sorellanza, “Baby goes again” con la chitarra acustica a dettare il ritmo, “One for sorrow, two for Joni Jones” nata come omaggio a Joni Mitchell. Sempre sincera, molto più sicura di sé, Amber Bain dimostra ancora una volta di essere un’artista completa.