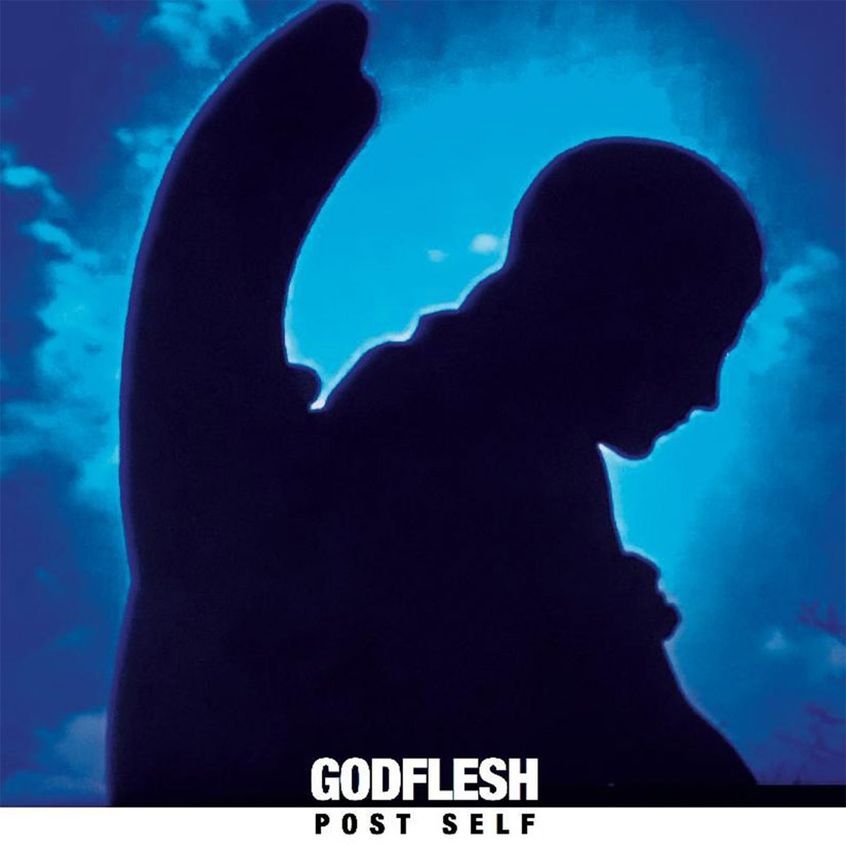Inizia con una sequenza di synth quasi carpenteriana il nuovo album degli Slowdive che tradisce questa iniziale onda di mistero con un nuovo gruppo di canzoni che invece esaltano il lato confortevole della band di Reading. Approdati in via definitiva alla loro seconda vita, con “Everything is alive” la band riprende il punto della situazione, ma non tanto rispetto al precedente omonimo, ma direi soprattutto rispetto ai primi seminali album che hanno reso Slowdive quasi un marchio dello shoegaze mondiale, con il classico movimento a tsunami del successo che anche per loro come altri dell’epoca arrivò in un successivo momento e continua ad espandersi meritatamente.

In questa perenne condizione di entusiasmo e sincera affezione che si rinnova ciclicamente da quei meravigliosi anni 90, attraverso band di diversa estrazione che hanno a turno rivitalizzato il genere, persiste da lungo tempo un motivo di orgoglio generazionale per chi all’epoca ha avuto il privilegio di captare in fieri il valore di questo suono, semplice ma ridondante, con poche trame armoniche che si ripercorrono in loop donando pienezza e densità alle canzoni, fatto di vibrazioni che si ripercorrono, un genere, di sheogaze stiamo parlando, soffuso e privo di eccessi, dove le voci quasi bisbigliano e accompagnano un flusso dolce ma vigoroso di chitarre, basso quasi new age e batteria dall’assente al marziale, che si arroga la capacità di conciliare i momenti più sinceri dell’esternazione della nostra malinconia, una sorta di necessario momento di bisogno terapeutico in cui la nostra impreparazione nell’affrontare il reale trova rimedio e conforto in questa polvere sonora che ci porta in un’onirica dimensione di lontananza, di rifugio e di fuga da un momento presente impalpabile.
Ecco, tutto questo per dire che “Everything is alive” serve ancora a questo, il punto è che lo fa dopo 30 anni circa da “Souvlaki” come se questi 30 anni non fossero passati e Halstead e la dolce Rachel Goswell portassero gli stessi maglioni felpati e jeans di seconda mano, come se bastasse o servisse proporre di nuovo la medicina a 50 enni del tempo che fu o nuovi adolescenti bisognosi: beninteso, un enorme e rispettabile proposito, come dimostra il bel video di “kisses”, in cui appunto le nuove generazioni si sfidano con le più anziane a mostrare in telecamera gli sguardi più attoniti e emotivi.
Ma le canzoni qui a parte qualche effervescenza nella già citata “kisses”, nell’iniziale “shanty” e nella roboante finale “the slab”, rispondono certamente all’idea di un’aderenza ai canoni del miglior dream pop/shoegaze, ma rimangono esili e convenzionali, le semplici trame di Halstead non sorprendono più come in passato e seppur l’impasto tra la sua voce e quella della Goswell rimane di un fascino immutato nel suo potere evocativo, il piacere iniziale dell’ascolto dell’album scema abbastanza velocemente, lasciando il posto alla sensazione di piacevoli ricordi e di compiacimento: si ha soprattutto la sensazione che sia stato confezionato a due fasi, vista l’evidente differenza qualitativa del trittico di canzoni di cui si diceva sopra ed il resto, che sa di riempitivo e dilungato.
“Everything is alive” è comunque apprezzabile al solito per l’amalgama del dettaglio produttivo, il raccordo sonoro fra gli strumenti e la classica morbidezza degli stacchi, ma è come se la band guidasse a sua insaputa col pilota automatico, narcotizzati forse dalla loro stessa dimensione di genuinità, dal piacere di ritrovarsi a condividere le stesse emozioni che li hanno resi partecipi di un successo inaspettato, ancor prima di rimanere consapevoli di saper creare canzoni dense di suggestioni per narcolettici.