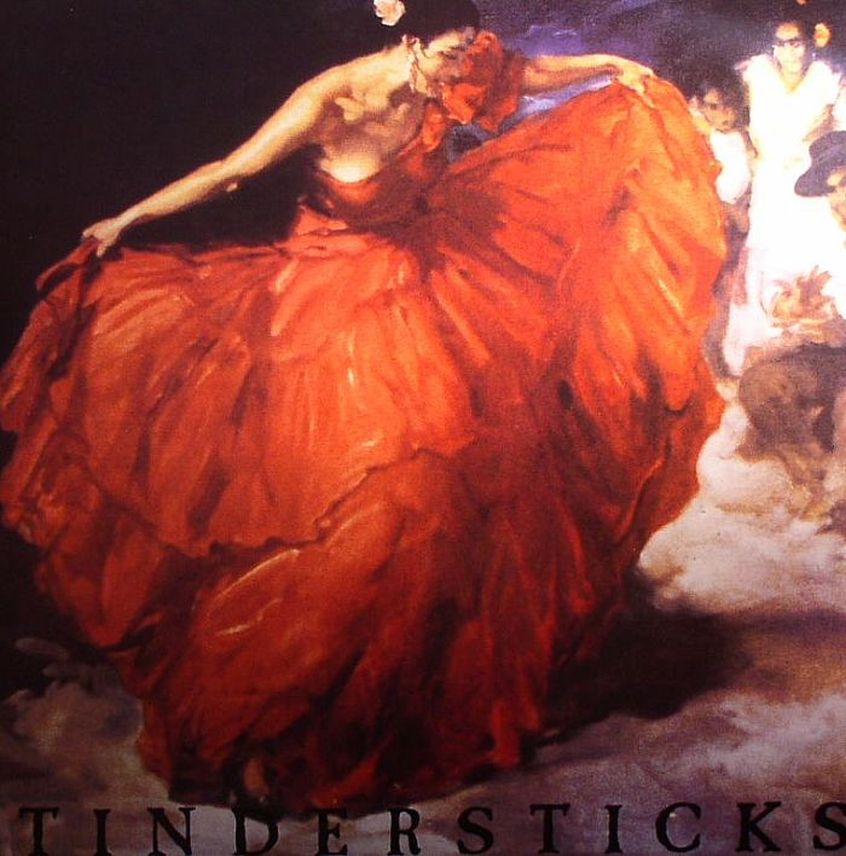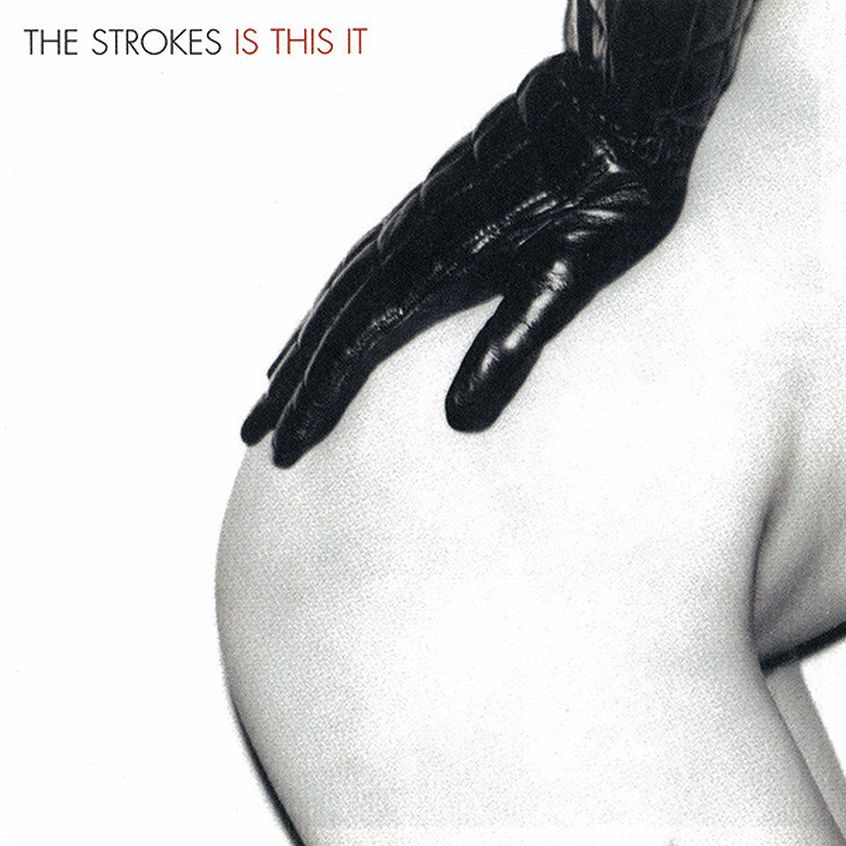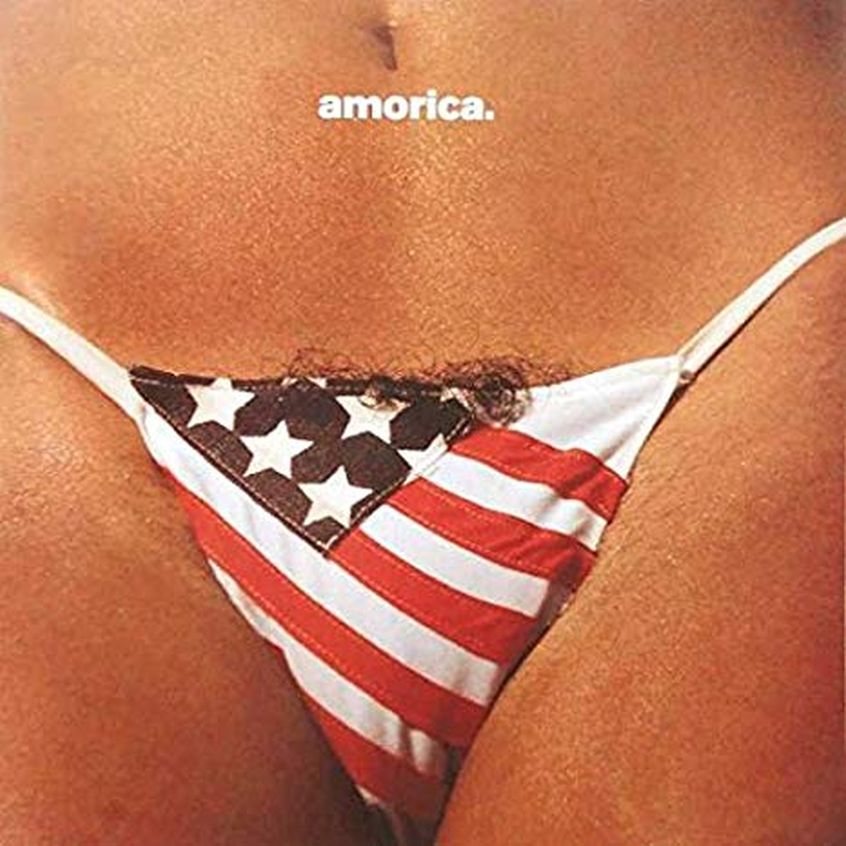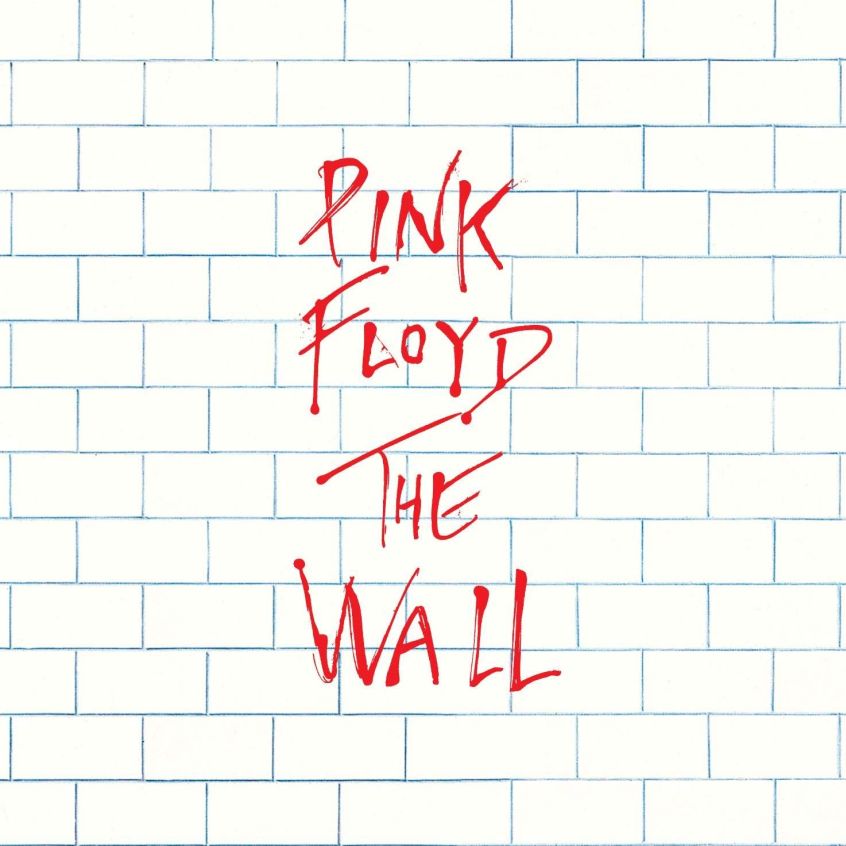“Up” dei R.E.M. compie oggi 25 anni e questo è un lasso di tempo utile e sufficiente per celebrarlo e storicizzarlo, visto che per sua natura ha rappresentato sin da subito una sorta di corpo estraneo nella copiosa discografia di Michael Stipe e compagnia.
Il perchè è anche pleonastico ricordarlo: fu il primo album senza Bill Berry, motore della band, non solo batterista ma anche polistrumentista, nonchè artefice di felici intuizioni che poi avrebbero portato a veri capolavori. Soprattutto un elemento in teoria imprescindibile, anche per il senso di comunanza che permeava la band, tutti molto legati fra loro sin dagli inizi.
In effetti fu un periodo molto controverso per i R.E.M. quello appena successivo alla dipartita del batterista, che ricordiamo ebbe gravissimi problemi di salute durante il tour di “Monster”, quando fu colpito da un aneurisma. Una volta ripresosi, registrò le sue parti per “New Adventures in Hi-Fi” ma poi prese la decisione di mollare, ormai stanco e probabilmente provato dalla vita del musicista giramondo. Fu scongiurato per pochissimo il fatto che gli stessi R.E.M. potessero di fatto sciogliersi ma a quanto pare lo stesso Bill Berry premette perchè i tre amici continuassero. La scelta fu felice, perchè la band da lì in poi visse una seconda giovinezza artistica, ma evidentemente il vuoto lasciato dietro la batteria non si poteva colmare chiamando in sostituzione dei pur bravi turnisti.
A cambiare doveva essere proprio l’attitudine, il sound, finanche il genere. E per farlo i R.E.M. fecero utilizzo di un’elettronica comunque non invasiva, ma efficace e caratterizzante in pratica tutte le 14 tracce che andarono a comporre “Up”. Non c’è più nemmeno il fidato produttore Scott Litt che aveva condiviso la scalata del gruppo da “Document”, sostituito dal poliedrico Pat Mc Carthy. Insomma, fu in tutto e per tutto un nuovo inizio.
Il risultato è quello di un disco quantomeno caotico e ondivago ma estremamente intenso, nelle liriche così come nell’interpretazione di Michael Stipe, e affascinante e misterioso nelle raffinate trame musicali. Per sopperire all’assenza di Berry, furono scelti musicisti di un certo peso (come Barrett Martin, batterista degli Screaming Trees) ma fu principalmente il giovane Joey Waronker a muoversi al suo posto, in tour ma anche in studio soprattutto col successivo “Reveal”. A livello musicale si sobbarcarono maggiori compiti il chitarrista Peter Buck, mai così eclettico con lo strumento, e impegnato anche al basso, alle percussioni e alle tastiere e Mike Mills che chiamare bassista risulta riduttivo, vista la sua capacità risapute di polistrumentista.
Il cambiamento fu drastico, quel rock urgente e ficcante che aveva tratteggiato i precedenti “Monster” e “New Adventures in Hi-Fi” era di fatto scomparso, così come non vi erano tracce delle chitarre jingle jangle che fecero la fortuna della band negli anni ’80.
In “Up” sono le tastiere, i sintetizzatori, la drum machine a farla da padrone negli arrangiamenti ma come detto si trattava di un’elettronica gentile, quasi “vintage”. A un primo ascolto l’album parve eccessivamente lento, cupo, con pochi picchi di vivacità (un brano stupendo come “Walk Unafraid” dal vivo saprà poi sprigionare una carica pazzesca ma su disco sembrava comunque un po’ zoppicante e indeciso su che direzione prendere). Tutto il disco si poggia su questo equivoco di fondo, è in effetti di transizione, ma la sua caratteristica di incompiutezza e imperfezione lo rendono ad ascoltarlo ancora oggi molto vero, emblematico del senso di smarrimento che dovevano aver provato i 3 nel reinventarsi dopo quasi 30 anni di carriera.
“Airportman” apre il disco in modo quasi sussurrato, è molto d’atmosfera, assai diverso da ogni brano che abbia mai aperto un loro lavoro in precedenza e fa da preludio a “Lotus”, che invece è uno dei pezzi più pragmatici a livello musicale. Suona minaccioso ed è accompagnato da un testo enigmatico e visionario. La successiva “Suspicion” induce alla riflessione, con i suoi ispirati versi e una musica che culla l’ascoltatore. Dovessimo scegliere una canzone per sintetizzare il disco, se la giocherebbe per esserne scelta, visto che rappresenta bene l’evoluzione stilistica del gruppo. “Hope” al contrario porta all’estremo la soluzione elettronica e il chilometrico testo di Stipe rischia di perdersi in mezzo agli effetti stralunati delle tastiere. La melodia ricalca piuttosto pedissequamente quella di “Suzanne” di Leonard Cohen, al punto che il cantautore canadese viene accreditato come autore della musica.
Si arriva così alla prima canzone assimilabile alla storia dei Nostri: la ballata pianistica “At My Most Beautiful” che però inevitabilmente risulterà molto patinata al cospetto dei capolavori del passato. “The Apologist” rimette in mostra uno Stipe declamatorio, mentre i toni mutano improvvisamente pelle sin dall’arpeggio di chitarra acustico che introduce la mesta “Sad Professor”. Molto intensa e riuscita risulta essere “You’re in the Air”, sorretta da imponenti archi e che il leader interpreta con grandissimo trasporto emotivo. La già citata “Walk Unafraid” diverrà col tempo una delle più amate e richieste nei live, grazie appunto a una qualità melodica in grado di sprigionarsi e liberarsi magnificamente in volo durante i concerti.
Seguono due tra gli episodi migliori del disco: una dolcissima “Why Not Smile”, dalla melodia cristallina con un crescendo musicale da brividi e il noto singolo “Daysleeper”, che farà egregiamente la sua parte nel lanciare in orbita l’intero lavoro. L’introduzione chitarristica di Peter Buck è di quelle da mandare a memoria, e pure il ritornello è tra i più incisivi mai realizzati dal gruppo.
La chiusura dell’album è affidata a tre brani dai toni minori, ma non per questo non meritevoli di ascolti, anzi, in “Diminished” riecheggia in sottofondo una splendida chitarra slide che conferisce toni quasi country al brano. La stessa canzone sul finale confluisce nella delicata “I’m Not Over You”, sorta di “ghost track” come si era soliti all’epoca, solo voce e chitarra acustica. La dimessa “Parakeet” si apre in un arioso ritornello ma poi si richiude in sè stessa, con le dolenti noti di organo a corredarla sul finale e a collegarla idealmente alla solenne “Falls To Climb”, una delle più toccanti e convincenti canzoni in scaletta: quando si dice “chiudere in bellezza”!
Ebbi la fortuna di vedere i R.E.M. in occasione della tappa italiana del tour mondiale successivo alla pubblicazione di “Up”, in quel di Bologna nella splendida cornice dello Stadio “Dall’Ara” l’11 luglio 1999. Fu uno spettacolo stupendo, intenso, pieno di vitalità e freschezza, lì capii ce ne fosse stato ancora bisogno, che Micheal Stipe, Peter Buck e Mike Mills avevano ancora tanto da offrire e da raccontare di sè. La loro storia sarebbe proseguita fino al 2011, ma dopo questo album sarebbero rientrati nei ranghi di una (seppur ottima) pop band. L’album che lo seguì (“Reveal”) è certamente più solare e coeso ma anche più convenzionale. Per questo “Up” a conti fatti risulterà essere l’ultimo lavoro in cui i R.E.M. vollero (e seppero) davvero mettersi in gioco. E ciò, a fronte di una carriera che ormai aveva raggiunto l’apice, non era affatto scontato.
Data di pubblicazione: 26 ottobre 1998
Registrato: tra il 1997 e il 1998. Studi di registrazione: La Casa dell’Elefante, Seattle; Toast , San Francisco; John Keane Studios, Athens; Tree Sound Studios, Atlanta.
Tracce: 14 (+ 1 Ghost Track)
Lunghezza: 64:33
Etichetta: Warner Bros.
Produttore: Pat McCarthy
Tracklist:
1. Airportman
2. Lotus
3. Suspicion
4. Hope
5. At My Most Beatiful
6. The Apologist
7. Sad Professor
8. You’re in the Air
9. Walk Unafraid
10. Why Not Smile
11. Daysleeper
12. Diminished
13. Parakeet
14. Falls to Climb