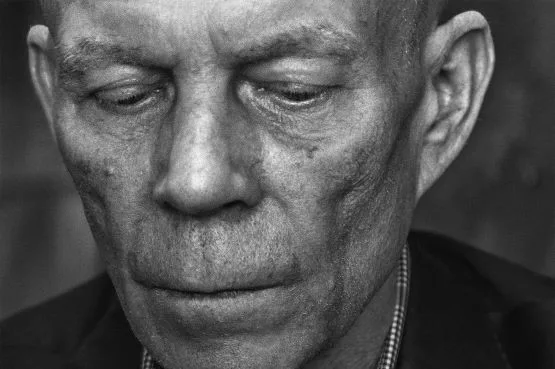Solitamente la musica elettronica, nella sua variante techno più ballabile, è considerata la musica ideale per evadere, per divertirsi, per liberarsi o per dimenticare i problemi e gli affanni quotidiani. Quando, invece, ascoltiamo Sama’ Abdulhadi, dj ed artista palestinese, i nostri pensieri vanno, ovviamente, a ciò che sta, attualmente, accadendo a Gaza, in Palestina, e a ciò che è accaduto, lo scorso Ottobre, in Israele. Sentiamo che qualcosa di odioso, di opprimente e di traumatizzante ci schiaccia e ci sovrasta, vorremmo fuggire, ma ciò ci è impossibile, perché nessun luogo ci appare sicuro, nessun futuro ci appare fiducioso, nessun passato ci appare utile ad uscire dal tunnel di errori, di ingiustizie, di torti, di soprusi, di razzismo e di morti ammazzati nel quale ci siamo inoltrati.

Sama’ Abdulhadi non appartiene assolutamente a questo sistema bicefalo di odio, ricordiamo bene che, nel 2020, lei trascorse più di sette giorni in carcere per un’esibizione in una moschea palestinese; ha, però, allo stesso tempo, sempre rivendicato il fatto di essere una donna palestinese ed araba consapevole, libera, autonoma ed estranea a quegli schemi conservatori e maschilisti che – da qualsiasi lato li si guardi, in qualsiasi contesto culturale, sociale o religioso, essi si sviluppino e si amplifichino – producono solamente dolore, sofferenza, odio, guerra, distruzione, povertà, morte.
E’ ovvio che questi 72 minuti di divagazioni elettroniche, di mix energici, di bassi profondi e penetranti, di ritmiche catartiche e palpitanti, di trame sintetiche e capaci di esaltare quello che è un linguaggio universale di tolleranza, di pace, di corpi e di menti che si armonizzano tra loro, appaiano, ai più, solamente un’utopia sonora. Non riusciamo, infatti, a sottrarci a quelle logiche che ci vogliono, per forza di cose, imporre di dover appartenere ad una parte, ad una fazione o ad una visione esclusiva ed elitaria del mondo.
In questo modo non esisterà mai alcun ponte e l’unica integrazione possibile sarà quella di questo dj-set, dei suoi brani provenienti da diversi paesi del mondo, da Oriente e da Occidente, lasciando che, alla fine, l’ultima canzone – “Laba Staifia” degli Acid Arab – ci riporti a quella che è, invece, una realtà amara ed insopportabile nella quale i ponti vengono continuamente abbattuti, così come lo sono, oggi, i palazzi e le case, le scuole e gli ospedali di Gaza, nonché le nostre stesse speranze, soprattutto quando anche la musica, quando anche una festa – come è avvenuto durante il festival Supernova, nei pressi del kibbutz di Re’im – viene trasformata in un abominevole atto terroristico, in un massacro iniquo e vergognoso che, oramai, è evidente, non fa altro che accrescere la tensione, provocare ritorsioni, dividere ed allontanare le parti, impedendo sia ai palestinesi di ottenere l’agognata indipendenza, sia agli israeliani di sentirsi al sicuro da minacce, attacchi ed attentati.
Sama’ Abdulhadi trasforma tutto ciò in ombre oscure ed inquietanti, in tamburi remoti, in battiti cardiaci che accelerano, a dismisura, ogni qual volta il terrore diventa reale, prossimo ed imminente, perché – come lei stessa ha dichiarato al Guardian – quando sei palestinese, tu sai che puoi morire in qualsiasi momento, anche in dieci minuti, ed allora non ti resta che credere ed impegnarti in ciò che fai, confidando nel fatto, come scriveva il poeta Refaat Alareer, che, una volta che sarai a morto, la tua storia possa essere narrata, possa essere un esempio positivo, possa essere un prezioso seme di speranza per il futuro, possa essere l’aquilone che fissano gli occhi liberi, gioiosi ed incontaminati di un bambino. Credere ed impegnarsi, dunque, questi dovrebbero essere i due soli pilastri su cui edificare un mondo nuovo, un mondo migliore, un mondo liberato, finalmente, da ogni forma di fanatismo.