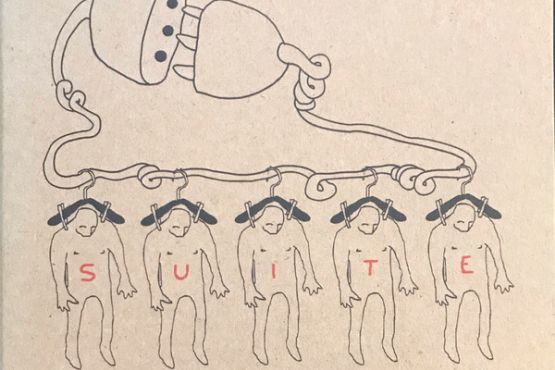Una delle rubriche su cui puntiamo molto qui su Indie For Bunnies (e che ci regala grande soddisfazione) è quella dedicata agli artisti emergenti, in cui cerchiamo di dare uno sguardo su tutto ciò che si muove dal basso per portarlo meritatamente alla luce.
Con “Brand New” si intende offrire quindi un’ampia panoramica del sottobosco indie; a volte si tratta di singoli episodi di cantanti o gruppi che magari nonostante ottime premesse poi non sanno dare seguito alle intuizioni iniziali, ma spesso e volentieri capita che alcuni nomi su cui puntiamo dimostrino col tempo di avere le carte in regole per costruirsi una bella e duratura carriera.
E’ il caso delle irlandesi Pillow Queens che noi seguiamo da sempre e per le quali era facile scommettere, considerata l’indubbia qualità della loro proposta.

Giunte da poco al terzo album, le quattro talentuose musiciste, forse incautamente inserite nel filone post-punk odierno, confermano quanto di buono avevano espresso in precedenza, andando a rimarcare con sempre più forza e convinzione alcune tematiche sulle quali non temono di esporsi.
Dalla libertà individuale alla queerness, dal dolore visto talora come tappa necessaria per rinascere e riprendere il volo all’amore che tutto accomuna (gioie ma anche grandi sofferenze), fino alla solitudine che a volte è quella che si prova nonostante una vita apparentemente perfetta e costellata di successi.
“Name Your Sorrow” prosegue con naturalezza il percorso del gruppo, imponendolo come nome pronto a prendersi davvero la scena: lo si capisce da quel senso di autorevolezza che traspare dalle dodici nuove canzoni, dall’intensità di cui sono tutte egualmente intessute, dall’apparato musicale che si è fatto più robusto, senza che per questo venga penalizzata la componente melodica.
Sin dai singoli anticipatori si poteva percepire che le Pillow Queens intendevano mettere un po’ da parte le delicatezze pop sublimi di alcuni momenti del passato per trasmetterci con più vigore e maggior consapevolezza i loro sentimenti.
Attenzione però a non farsi ingannare da un titolo così esplicito: il disco non trasmette mai infatti un senso di tristezza, né appare cupo o tedioso, perché appunto si parla di fasi della vita, di sali-scendi emotivi che ci riguardano da vicino e con i quali tutti prima o poi dobbiamo fare i conti.
L’amore è protagonista, viene declinato abbondantemente tra le pieghe del disco ma le liriche non sono certo banali o ammiccanti, così come le sonorità non virano mai nel melenso, tutt’altro.
A colpire a un primo ascolto di brani come l’opener “February 8th”, “Gone” o “Heavy Pour” sono proprio le chitarre, ora soniche, ora acide, altre volte sognanti ma pure urticanti: è questo a conti fatti un album dannatamente, indiscutibilmente, rock, che sa colpirti come un pugno sullo stomaco in vari punti della scaletta, e che allo stesso non ha disperso la sua natura fresca e cristallina.
Quest’ultima caratteristica è dettata sicuramente da un’ottima produzione (ad opera di Collin Pastore, già collaboratore delle boygenius) ma prima ancora dalla risaputa bellezza delle voci, dagli intrecci magnifici di Pamela Connolly e Sarah Corcoran.
Ma poiché di album molto suonato si tratta non posso non citare anche il grande apporto di Cathy McGuinness (alcuni suoi interventi chitarristici sono da manuale, penso in particolare al finale dell’ariosa “Friend of Mine”, al fragoroso assolo di “Blew Up the World” o al mood minaccioso da lei dettato in “One Night”) e della batterista Rachel Lyons, che le presta il fianco nella grintosa “The Bar’s Closed” (con echi di Cranberries) e offre delle dinamiche cangianti in alcuni brani-simbolo come “Suffer” o nella mid-tempo “Like a Lesson”.
Non vorrei a questo punto cedere al track-by-track, in quanto è il disco nella sua interezza a meritare, non mostrando alcun cedimento per tutta la sua durata, e allora mi fermo qui, invitandovi ad ascoltare con il giusto trasporto emotivo questo lavoro, che dall’inizio alla fine trasuda onestà, raffinatezza e grande profondità.