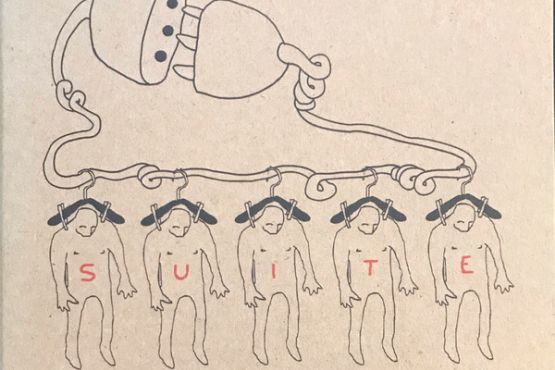Alla voce album italiani che di italiano hanno ben poco, non solo per l’utilizzo della lingua inglese ma pure per la proposta musicale, va annoverato senz’altro anche il nuovo lavoro del bresciano Andrea Van Cleef, cantautore rock in cui sembrano convivere le anime di autentici mostri sacri quali Johnny Cash e Nick Cave.
E pazienza se la cosa gli potrà sembrare ormai indigesta, perché deduco di essere soltanto l’ultimo di una discreta schiera a tirare in ballo simili paragoni, il fatto è che Van Cleef queste nobili ascendenze riesce a rispettarle e perpetuarle ottenendo comunque un linguaggio proprio assolutamente personale.

D’altronde non si sta parlando di un ragazzino ma di un signor artista che può già contare su un ricco e variegato curriculum musicale, sia in solitaria che impegnato in salienti progetti formativi (citiamo come esempio almeno gli Humulus) e che ha avuto modo di entrare in contatto facilmente con un nome del calibro di Rick Del Castillo (collaboratore di importanti colonne sonore come quella per “C’era una volta in Messico”).
Proprio nei suoi studi in Texas, e luogo più consono non poteva esserci, vista la vicinanza del Nostro col mondo western e la padronanza con cui si è nel tempo appropriato dei suoni “americani”, Andrea Van Cleef ha effettuato le prime sessions per il nuovo disco “Horse Latitudes” per completarle poi vicino a casa, a Montichiari con il sound engineer Simone Piccinelli.
Il risultato di queste registrazioni sono undici brani tutti indubbiamente meritevoli di ascolti, accreditati a Van Cleef & The Black Jack Conspiracy, a valorizzare così l’apporto dei musicisti e a connotare l’aspetto corale del lavoro.
E’ d’uopo però rimarcare quanto di Van Cleef ci sia in questo lavoro, che esula da contesti meramente ascrivibili allo stoner-rock ascoltato in passato (e pienamente nelle sue corde) per tratteggiare acquerelli musicali più variegati, dove atmosfere desertiche e toni anche soffusi si dipanano in un solco americano a più ampio raggio, memore della lezione del country.
E poi la voce, ragazzi! Qui davvero Andrea Van Cleef gioca un campionato tutto suo, dove appunto riesce ad ammaliare l’ascoltatore con la sola forza del canto, che sa farsi all’occorrenza profondo, greve, aspro ma pure dolce e introspettivo.
Potrei parlarvi dei singoli pezzi ma mi sembra quasi pleonastico, non essendoci di fatto tra questi alcuni che sovrastano gli altri per qualità e spessore; come anticipato qualche riga più su tutti mostrano una forte caratterizzazione e sono funzionali per l’ottima riuscita del progetto.
Concedetemi però di citare almeno “A Horse Named Cain”, che introduce il disco impregnandolo da subito di magnetismo solenne, dettando così il mood adeguato con il quale approcciarsi all’opera.
Altri titoli indimenticabili sono la placida “Love Is Lonely” (con Ottavia Brown), con la sua implicita aura di classicità; l’ombrosa ma tenue al tempo stesso “Come Home”; un’orecchiabile “Fire In My Bones” intrisa di reminiscenze folk grazie alla presenza massiccia del banjo e di cadenzati violini; e infine “The Real Stranger”, tra richiami ai Doors e certo fascinoso free jazz, per via del magnifico intervento di Dana Colley (ex Morphine) al sax baritono.
In conclusione, voglio tornare indietro alle parole con cui ho introdotto questo pezzo, e mi riallaccio ad esse per sostenere nuovamente che “Horse Latitudes” non sembra di certo un album “italiano”, ma potrebbe provenire da qualunque parte del mondo e risultare lo stesso bellissimo e soprattutto credibile, perché quando c’è del talento innato puoi anche permetterti di rifarti a certe esperienze dirette ma non sarà mai per scimmiottare o per crearne una copia sbiadita.
In fondo a contare e fare la differenza è sempre la personalità dell’artista, ciò che ha da trasmettere con le proprie canzoni. E Andrea Van Cleef con questo album sembra aver trovato davvero la formula giusta per esprimere al meglio sé stesso.