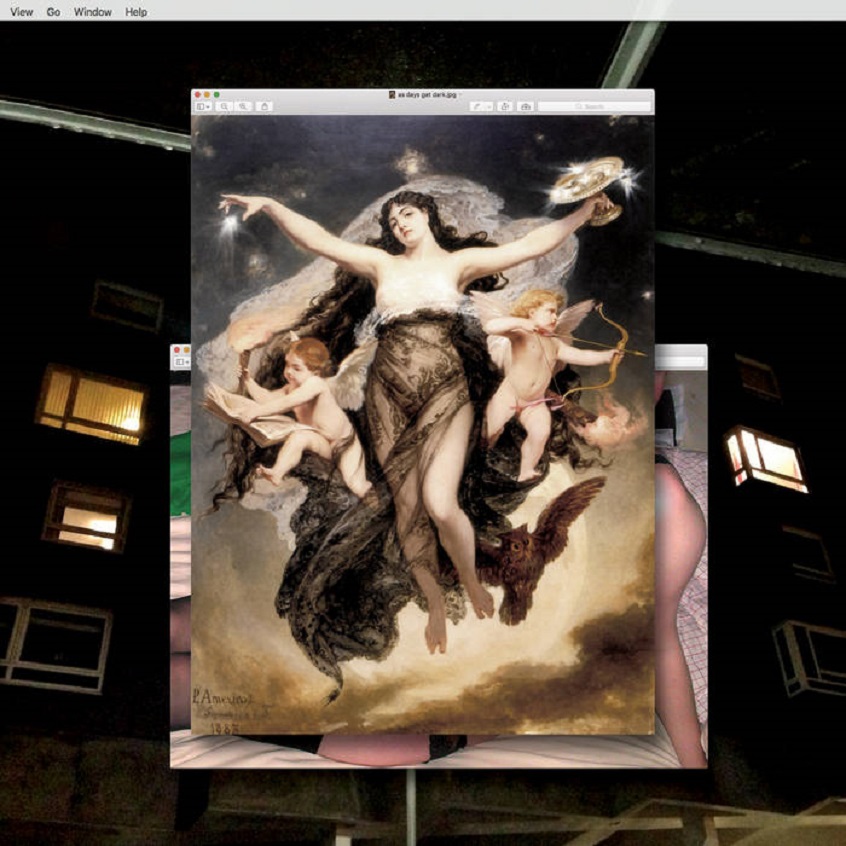Con “I’m Totally Fine with It Don’t Give a Fuck Anymore”, il duo scozzese composto da Aidan Moffat e Malcolm Middleton ci conferma che la reunion avvenuta con “As Days Get Dark” (2021) non è stata solo un’operazione estemporanea, ma a conti fatti si è rivelata come la prima tappa di quello che sembra un nuovo percorso figlio di una caparbia ambizione, oppure una resa definitiva ai propri demoni interiori, che in qualche modo dovevano riaffiorare: una strada lastricata di presagi sempre più oscuri quanto avvolta in suadenti atmosfere noir.

Il cinguettio rugginoso di un vecchio modem apre il disco come la traccia fantasmatica di un rigurgito metafisico, familiare e insieme quasi sinistro, lontano, nostalgico e dimenticato eppure in fondo agrodolce ricordo vicino, polveroso fossile artificiale sepolto nella memoria. È uno squarcio tra la vita tangibile e quella intangibile, un richiamo per chi ha conosciuto la realtà prima della liquefazione digitale ed ora galleggia tra le scure acque del mondo nuovo.
Quel tenue stridio prepara il terreno per la canzone più dura del disco: “Allatonceness” viene stracciata da un basso distorto dalle rifrazioni metalliche e schiaffeggiata dall’incedere sporco di una batteria marziale. Moffat recita con voce un po’ cavernosa un po’ ubriaca, dipingendo un mondo in cui la crudeltà della giostra digitalizzata fagocita i sussulti straniti di un’umanità lacerata.
Questa asprezza cela nel suo grembo un umore cupo che quasi vorrebbe esplodere in fragori rabbiosi, ma trova una via d’uscita e quindi di sfogo controllato attraverso ballabilissimi numeri elettropop come “Bliss”, “Hide Your Eyes”, “Strawberry Moon” e “Drag Queen”, brani quasi sensuali eppure lisi, come un rossetto sbavato su un ritratto sfiorito. Queste soluzioni musicali in fondo assai orecchiabili nascondono dimesse sfumature notturne, sempre più chiare negli intenti ascolto dopo ascolto, anelanti ad una sorta di austerità androide, che invece rivela sempre una malinconica fragilità, anche quando il mood diventa addirittura quasi maestoso (vedi la coda della conclusiva “Turn Off The Light”, con di nuovo il rumore del modem 56K a far capolino negli ultimissimi istanti).
Nel vagare ramingo tra le strade del disco si finisce comunque sempre per ritrovarsi in umidi vicoli ciechi illuminati da asfittici neon urbani, mentre il recitato confessionale e quasi soprappensiero di Moffat procede tra fumose coltri d’inquietudine moderna.
Non mancano cavalcate avvelenate dai riflessi quasi industriali (la caracollante “Sociometer Blues”) e ballate sanguinanti come “You’re Not There”, “Molehills” o “Safe & Well”, nelle quali il piano o gli scintillii chitarristici si intrecciano a pulsazioni sintetiche che nascondono il cuore spiegazzato ma sempre vivo e infuocato degli Arab Strap.