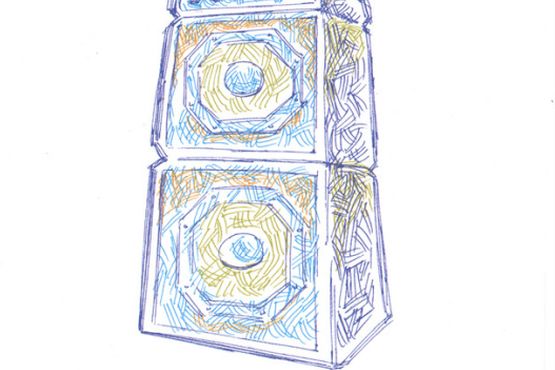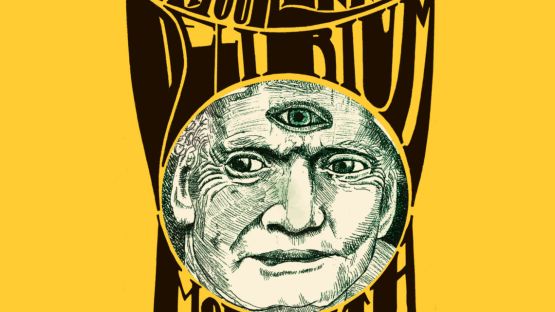Se con “Monument” le composizioni del trio avevano iniziato ad allungarsi e a farsi più pretenziose e centrate, in “Belaya Polosa” la loro creatività è ancora più fertile e ricca delle migliori idee che la band abbia partorito finora.

Il trio bielorusso con il quarto album mette in chiaro il proprio valore suonando come mai prima, rimanendo del tutto riconoscibile nonostante coordinate artistiche più mature e libere, e (spero) facendo finalmente concludere le critiche di chi ancora li tacciava di notorietà spicciola e immeritata, frutto solo dei numeri sui social (come se oggi il binomio industria musicale-TikTok fosse un fenomeno strano). Perché ‘Belaja Polosa’ non solo ci mostra come i tre non si guardino più alle spalle, forti del bagaglio anche quello di valore degli album passati e soprattutto del precedente ‘Monument’, ma alza sotto quasi ogni punto di vista l’asticella, decretando un nuovo inizio per la band, o meglio un punto di non ritorno.
Un muro insormontabile di synth, una cassa dritta che si costruisce pian piano, e infine un riff schizofrenico che ti entra subito in testa: questi sono i primi secondi di ‘Belaya Polosa’ e già vorresti andare a sentire tutto il resto del disco. “Ty Zhe Ne Znaesh Kto Ya“ è una perfetta opening track, esplosiva e ritmata ma soprattutto costruita molto bene in ogni suo dettaglio (prendete il bellissimo bridge che inizia a 3:02 e che sfocia in una risata che si riallaccia al riff), quest’ultima una caratteristica che non viene quasi mai a mancare fino alla fine dell’ascolto.
Soprattutto si nota subito l’abbandono della natura lo-fi dei lavori precedenti, ora rimpiazzata da suoni puliti e pieni, frutto della volontà di cambiare dei tre, che volano fino a Los Angeles per registrare il primo album fuori dalla Bielorussia. Il dark-synth di “Kolesom” e di “Ya Tak Ustal” è riuscito e godibilissimo, continuando la linea intrapresa dagli esordi, nata sotto il lume dei Depeche Mode e che Pavel Kozlov migliora e non di poco. E se canzoni come “III” o la conclusiva “Zimnaya” possono riportare l’ascoltare indietro di qualche anno nella discografia dei bielorussi, altre come la title-track o “Chernye Cbety“, momento in cui Roman Komogorcev vira verso nuovi pattern, sfruttano a meraviglia drum machine instancabili e chitarre che, suonando come una ventata fresca tra i blocchi di cemento di epoca sovietica che incorniciano come sempre i lavori dei Molchat Doma, giocano un ruolo non di secondo ordine.
Rimanendo con tutte le scarpe dentro gli anni ’80, il trio ruba in modo efficace anche ai The Cure questa volta meno “Pornography” e più “Disintegration”, con l’atmosfera piovosa e oscura della bellissima “Son”, in cui il cantante Egor Škutko crea immagini apocalittiche in cui non esiste futuro né passato che possa persistere: “Il cielo ci cade addosso come scintille rosse/La cupola della speranza si sciolse in quell’ora/ E’ troppo tardi per fare il segno della croce/ Non possiamo essere salvati/ Guarda le tracce che abbiamo lasciato/ Il vento le disperderà presto”. Nel loop meccanico e insistente della batteria che percorre tutto “Belaya Polosa“ c’è anche spazio per riposare, anche se poco, e qui i Molchat Doma fanno venire in mente le fughe elettro-ambient del Bowie di “Low”, momento imprescindibile per tutti quei dischi che del mondo metropolitano fatto di neon e cemento fanno la propria zona di comfort.