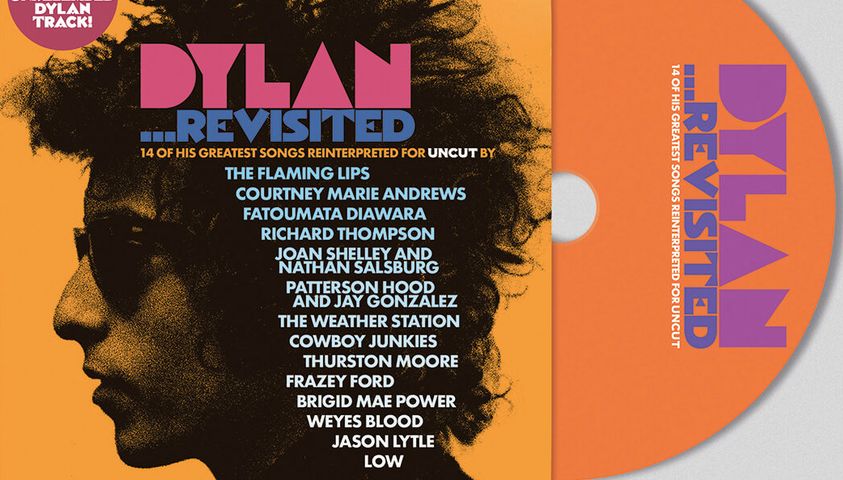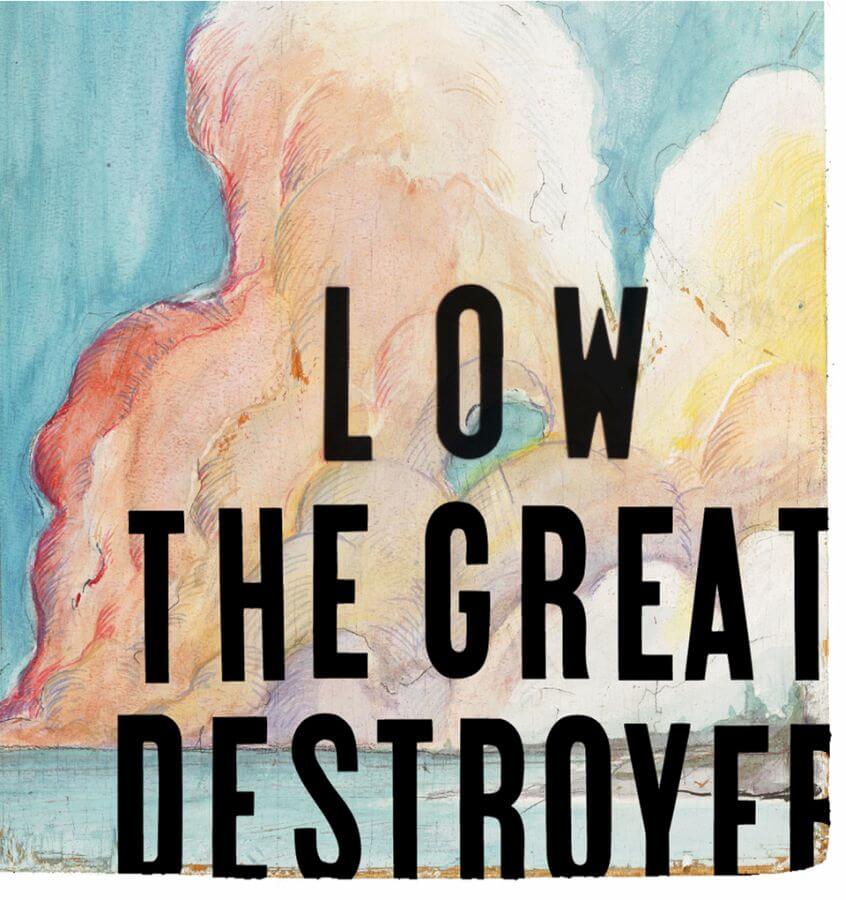“White Roses, My God” si fa strada sulle macerie di quello che è stato il meraviglioso duo dei Low, scompaginando le carte per una
virata decisa verso un territorio sonoro in parte inaspettato, dove l’elettronica minimale e l’uso dell’autotune esplorano nuove dimensioni emotive e stilistiche. A differenza del suono abrasivo e distopico di “Double Negative” o “Hey What”, questo album riduce la densità detritica della massa sonora per abbracciare un’estetica più spettrale nella sua gommosità electro, ispirata forse, in parte, all’approccio vagamente frugale di Drums & Guns, ma rendendo il paesaggio sonoro ancora più spoglio e enigmatico.

La scelta della voce iperdeformata sembra voluta proprio per allestire uno strano confessionale surrealmente alieno, evocando un senso di separazione o di frammentazione che riflette la perdita, ma anche indagando una sorta di dimensione psichica oltre il limite del tempo/spazio contingente, non verso una catarsi diretta, ma verso una purificazione obliqua e sfuggente. La formula sembra consistere in brandelli di flussi di coscienza che serpeggiano attraverso pulsazioni sinuose di drum machine quasi urban, mentre gli asettici loop di sintetizzatori sembrano voler alienare e distanziare l’autore dalla sua stessa creatura sonora.
Ma sotto questa coltre scura, anzi opaca, respirano delle canzoni, delle melodie, dei frammenti di luce – vedi pezzi come “Get Still” o “Feel Something”, il tutto sminuzzato e lanciato in un abisso siderale senza poter fare più ritorno.
La ricetta di un suono urticante e quasi svagato, assieme all’assenza delle emotive pennellate chitarristiche che ci si potrebbe
aspettare da Sparhawk, conferisce al disco un senso di vuotezza androide e strana vulnerabilità post-umana. Alcuni brani, come “I
Made This Beat,” introducono variazioni più leggere e, smorzando il tono claustrofobico del disco, possono suonare fuori contesto. Ma, nonostante l’apparente mancanza di una certa coerenza, c’è un’intenzione palese nel mantenere un equilibrio tra malinconia
cibernetica e liberazione, quasi a voler far emergere una sorta di tremebonda gioia residuale oltre il dolore, trovando nuovo terreno fertile in un divertissement che vuole nascondere (o custodire?) emozioni più umane e tangibili. Sparhawk sta quindi “giocando” con una specie di discorso meta-musicale per sperimentare nuovi allestimenti sonori oltre la dimensione dei Low, oppure questo è proprio il suo modo di portare ad una nuova trascendenza il suo io artisticale e personale?
Non sappiamo la vera intenzione che c’è dietro questo lavoro e se questa nuova direzione avrà un seguito, ma intanto ci limitiamo ad apprezzare il coraggio del nostro amatissimo Alan, all’indomani della dipartita della preziosa compagna di vita e sodale Mimi Parker, anche se questo album ci pare un’opera di passaggio più utile per lui che per noi.