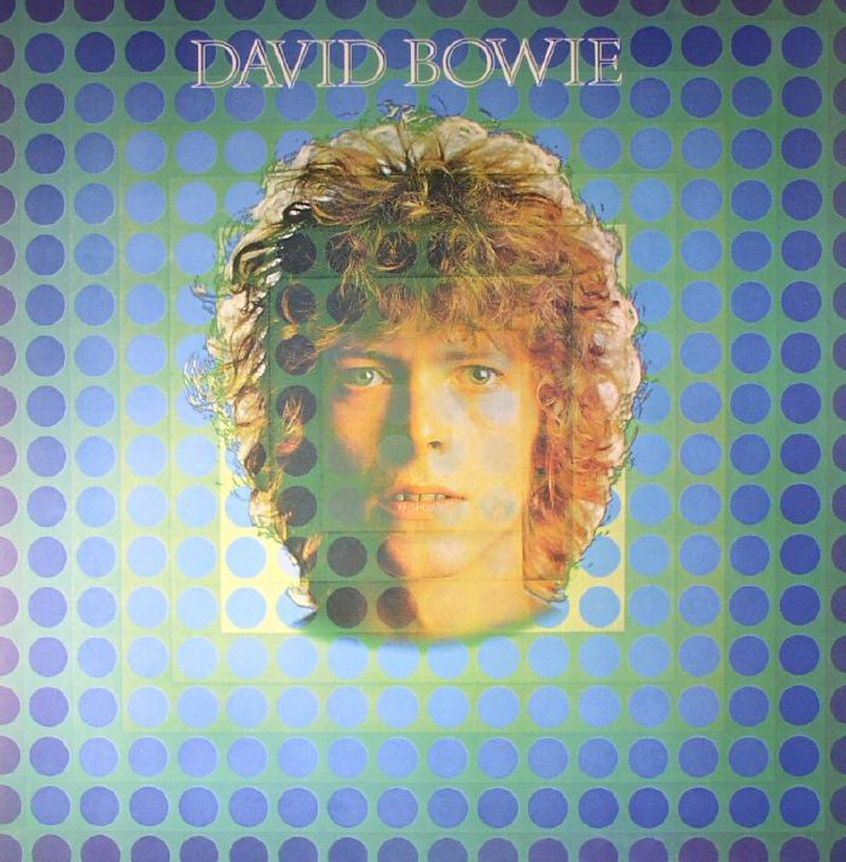Trent’anni fa veniva pubblicato “Out of Time”, l’album che rappresentò un vero spartiacque nella carriera dei R.E.M., fino a quel momento paladini della scena alternativa americana emersa negli anni ’80.
Un momento cruciale, più ancora del passaggio (all’epoca tanto discusso dai fan più intransigenti) da una indie label (seppur di spessore come la I.R.S.) alla major Warner Bros. Records, perchè fu con questo disco, trainato dalla mega hit “Losing My Religion” – insindacabilmente uno dei vertici di tutta la produzione rock anni novanta – che i quattro vecchi amici, partiti tanti anni prima dalla loro Athens nello stato della Georgia, riuscirono a conquistare il mondo, issandosi in cima alle classifiche sia in America che in Europa.
Cos’era cambiato però per arrivare a un simile exploit, fragoroso quanto meritato?
Innanzitutto occorre ricordare che quello dei R.E.M. fu un percorso di crescita graduale ma costante, come raramente se ne sono visti e come probabilmente non ne accadranno più, in quanto sin dal loro debut – album “Murmur”, datato 1983 (ma volendo ampliare il discorso, potremmo iniziare dal primo Ep “Chronic Town”, uscito dodici mesi prima) riuscirono a compiere uno step in più ad ogni nuovo lavoro, raddoppiando di volta in volta le vendite.
Molto prolifici, realizzarono un disco all’anno fino al 1988, abbattendo la barriera del milione di copie vendute (cifra notevole per essere partiti dall’underground) solo un anno prima all’altezza di “Document”, viatico per la firma con la grossa casa discografica. Qui come accennato prima, in molti fan della prima ora, ma in fondo anche parecchi critici, temevano un ammorbidimento della proposta, una svolta commerciale, ma i fatti – sintetizzati egregiamente dal disco della svolta, vale a dire “Green” – dimostrarono quanto i Nostri rimasero invece fedeli ai propri principi, puntando eccome sulla qualità della loro musica, senza snaturarsi in alcun modo.
Il pubblico alla fine rispose presente, e molti nuovi sostenitori furono raccolti; insomma, il terreno creato negli anni era divenuto assai fertile per una piena affermazione su vasta scala e un’ulteriore conferma venne dal fortunatissimo tour che fecero seguire al disco sopra citato.
Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills e Bill Berry a inizio ’90 non erano più dei ragazzini, essendo tutti trentenni o poco più, e già possedevano un bagaglio ricchissimo di esperienze artistiche e umane; consapevoli del loro status e del loro valore, erano una band coesa come mai prima d’ora, con rapporti che andavano ben oltre la sfera meramente lavorativa.
Tutti loro, quindi, erano pronti finalmente a spingersi più in là , confezionando un album che fosse specchio fedele del proprio tempo e del loro momento creativo.
Le sessions di registrazione si susseguirono in un ottimo clima, ancora con il fido produttore Scott Litt, che aveva contribuito non dico a patinarne il suono ma quantomeno a sgrezzarlo e renderlo vicino a un pop che fosse anche radiofonico.
Poi arrivò lei, ad anticipare (e scombussolare) ogni piano artistico e strategico: “Losing My Religion”, indimenticabile sin dal clamoroso videoclip – in un’epoca che appare remota, in cui Mtv aveva un ruolo sempre più preponderante nel contribuire al successo di un singolo – opera del regista indiano Tarsem Singh che riuscì a creare un connubio vincente di significati e immagini.
Le parole, evocative e taglienti, sono quelle di Stipe che interpreta il tutto con inaudita passione (e un pizzico di mestizia), dimenandosi e fissando la telecamera, lontano anni luce dall’introspezione e dal distacco mostrato nei primi anni della sua carriera di artista in prima linea.
Musicalmente ogni nota è al suo posto, col suono del mandolino di Buck a sorreggere l’architettura sonora e un ritornello che in pratica non esiste ma il tutto è funzionale al lungo cantato di Stipe. Un brano interamente acustico, per cui era difficile in principio ipotizzare un successo di tali dimensioni, che tuttavia fu presto in grado di ottenere grazie alla sua forza e bellezza intrinseca.
Detto ciò, è proprio l’intero album “Out of Time” a non tradire le attese, e nonostante col senno di poi, trent’anni esatti dopo, non si possa definire in modo univoco come la summa della loro poetica, è indubbio come sia un lavoro impreziosito da alcune delle più importanti composizioni del gruppo.
Personalmente ritengo che il lato A del disco sia il più bello della storia del rock ma rischio di diventare un ultrà e allora concedetemi almeno la genuina iperbole.
Eppure vi esorto a mettervi all’ascolto, come se fosse la prima volta, di questa indimenticabile sequenza: “Radio Song”, col suo funk rock irresistibile e gli efficaci contributi del rapper KRS-One; la già più volte citata “Losing My Religion” e a seguire la fantastica doppietta “Low”/”Near Wild Heaven”, a mostrare due facce della stessa lucente medaglia, con la prima sommessa, profonda e cupa, la seconda, di contro, solare, iper melodica e trascinante, guidata dalla voce solista di Mike Mills; chiude la facciata la semi-strumentale “Endgame”, suggestiva e ariosa.
Non che a ben vedere il resto della scaletta si discosti molto per contenuti e qualità della proposta, anche se a dire il vero la programmatica “Shiny Happy People” (anch’essa baciata da uno straordinario successo alla sua uscita come singolo) è ricordata per lo più per il bizzarro e coloratissimo video, quasi parodistico, che non per il suo valore. Di notevole impatto anche la presenza nel brano di Kate Pierson, loro famosa concittadina già con gli istrionici B-52’s.
E’ comunque questa canzone l’ultima (o forse l’unica, nel contesto) rappresentazione di good vibrations, non proprio nelle corde dei Nostri (una prima eccezione, generalizzando, era stata fatta con “Stand” nel disco precedente), giacchè da qui in avanti i toni torneranno più austeri e ben delineati su un pop che potremmo definire “d’autore”, con le sue reminiscenze folk.
Dall’urbana “Belong”, in cui si rifanno vivi i magnifici controcanti di Mills a bilanciare lo spoken di Stipe, a una “Half A World Away” che ricalca pedissequamente le atmosfere bucoliche evocate in “Green”, fino alla tirata country di “Texarkana” a ricordarci le terre assolate degli Stati del Sud, i R.E.M. mettono in scena il loro perfetto manuale della musica pop, non più indie.
Un album del genere però non può non contenere almeno un gioiello “nascosto”, una gemma destinata con il tempo ad assurgere allo status di diamante all’interno della loro produzione: in questo caso si tratta di “Country Feedback”, in cui l’urlo strozzato di Stipe, il suo accorato manifesto interiore, viene incastonato tra riverberi rock (struggente l’effetto E-bow di Buck, chitarrista sempre più eclettico e sicuro dei propri mezzi) che conferiscono solennità e drammaticità . E poi quei versi, indimenticabili: “It’s crazy what you could’ve had/I need this…”, da pelle d’oca!
Chiude il disco, dopo questa botta emozionale, “Me in Honey”, scanzonata e caratterizzata da un buon ritmo, ancora con la partecipazione della Pierson a duettare con il frontman nell’orecchiabile ritornello.
Come da loro tradizione, anche “Out of Time” doppierà nelle vendite il suo predecessore; questo però se ci si ferma ai soli Stati Uniti, perchè stavolta il successo fu appunto planetario (per la prima volta molto copioso anche nella nostra Penisola, dove stazionarono diversi mesi in top ten).
Da quel momento in poi di fatto il nome dei R.E.M. sarà destinato a rivaleggiare in termini di consensi e popolarità con band del calibro degli U2, nell’Olimpo del Rock.
Niente male per degli squattrinati studenti che all’inizio facevano leva sull’appoggio delle college radio alternative per emergere almeno al di fuori dei confini statali.
A quel punto il rischio di bruciarsi, avvicinandosi troppo al sole come dei novelli Icaro, c’era tutto ma loro reagirono all’ondata di entusiasmo e successo con un disco che poco o nulla concedeva al facile ascolto e in teoria al pubblico generalista, vale a dire “Automatic for the People”, che giungerà nei negozi appena un anno dopo, rappresentando a detta di chi vi scrive la loro opera migliore in assoluto. E anche solo immaginare di realizzare un disco di tale caratura dopo la perfezione pop di “Out of Time” non era esercizio affatto facile.
Loro ci riuscirono, semplicemente perchè erano un gruppo fuori dal comune, con ogni probabilità – se non altro per un ventennio buono – la migliore espressione artistica del panorama musicale a stelle e strisce.
Data di pubblicazione: 12 marzo 1991
Tracce: 11
Lunghezza: 44:08
Etichetta: Warner Bros.
Produttore: Scott Litt, R.E.M.
Tracklist
1. Radio Song
2. Losing My Religion
3. Low
4. Near Wild Heaven
5. Endgame
6. Shiny Happy People
7. Belong
8. Half a World Away
9. Texarkana
10. Country Feedback
11. Me in Honey