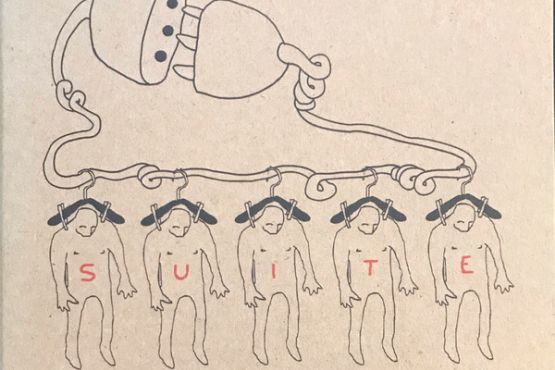Se non fossimo quelli che considerano una rara fortuna essere stati attraversati per un lungo tratto della loro vita dalla presenza dei Sonic Youth, quelli che hanno in fondo capito, tanto per essere chiari, la loro appartenenza grazie alle sonorità di questa band, parleremmo di un’ottima prova solista di un quasi settantenne, alle prese con una esigenza lirica giovanile abitata da soldati nudi alla meta, tuffatori, paure oniriche, sogni infranti e premonitori.

Invece probabilmente “Flow Critical Lucidity” è il miglior album solista di Thurston Moore, ed è tutto dire, lo si intuisce non da subito, inizia infatti con la quasi bizzarra e sviante “New in Town”, ma in seguito dalla sua inesorabile e persistente compattezza e lenta deflagrazione, in cui appunto mai come prima riesce a dare l’inevitabile continuità al sound della gioventù sonica impregnato dalla maturazione di un solista dal background inconsideratamente consistente e di una band mai così affiatata.
Non c’è una canzone fuori posto in questo album, ci sono 7 tasselli pieni, densi e complementari, frutto di un’ispirazione che viene distillata armonicamente dall’inizio alla fine, che deve gran parte delle sue derivazioni dal periodo maturo dei Sonic Youth epoca Jim O’Rourke, a echi velvettiani mai denigrati, dove la fanno da padrone i proverbiali intrecci delle chitarre, all’interno di un generale clima di pacata consapevolezza , dai ritmi tendenzialmente bassi, che si incastrano in modo magistralmente lirico con quest’ultima parte della produzione del leader.
Ci sono proprio quei momenti di magica sospensione che fanno la differenza, il finale su chitarra in fading e piano di “Hypnogram”, l’intarsio iniziale di “Sans Limites”, con il suo procedere sinuoso fino all’intro della batteria, l’intro quasi Cure di “Rewilding” con quella sottomessa forza quasi esplosiva, la spettrale “We Get High”, spettacolare nella sua lentezza doom, un sogno allucinato all’interno di un clima avvelenato da una batteria dolente e funerea, soprattutto l’emozionante finale di “The diver”, una composta ma vibrante elegia della forma espressiva migliore di Moore, che traccia questa poesia paradigmatica del tuffatore che c’è in noi, in una soffusa, ipnotica ballad al limite della perfezione nei cambi e nella coesione strumentale, con un finale da brividi assoluto, che coglie una sensazione straniante di paura imminente e il suo affievolirsi dentro il dipanarsi delle linee di chitarra, una specie di onda marina dei sentimenti, così imbarazzanti e pericolosi, che nascondono dietro il timore del loro pericolo, la pacatezza della sua risoluzione.
Ecco, un pò questo è il gioco riuscito dell’album, che ci sorprende impreparati già dal titolo, una rara lucidità nell’esposizione del flusso critico dei pensieri, dove la musica, le canzoni sono il mezzo, la freccia metaforicamente scoccata per raggiungere quell’obiettivo, che in noi rimane, semplicemente ed ogni volta, l’ascolto di qualcosa di unico ed irripetibile.