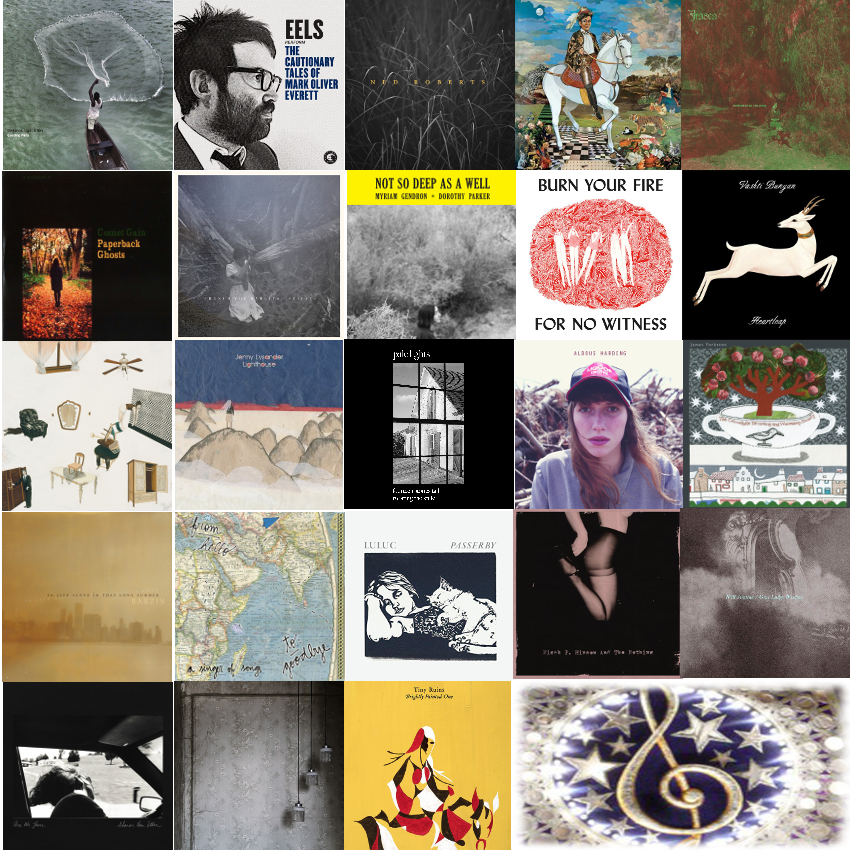Mette subito le mani avanti e dice che stasera non sta bene, indica i fazzoletti che ha vicino a sè, “perchè non si sa mai”. Ma bastano due pezzi, “Afraid of Nothing” e soprattutto la successiva “Taking Chances” per capire che non c’è nulla da temere: dietro ai capelli che le coprono gli occhi la voce di Sharon Van Etten è tagliente e straordinaria. Parte da un sussurro e subito si libera e risuona mentre lei allontana la testa all’indietro una, anche due spanne dal microfono.
è una storia poco comune la sua, per i nostri tempi: arriva al successo solo due anni fa con l’ottimo “Tramp”, a 31 anni e dopo una gavetta segnata da relazioni distruttive, depressione, demo acustici messi insieme faticosamente. Rispetto ad altre cantautrici non è difficile cogliere una consapevolezza istintiva della forza necessaria per farsi ascoltare, della differenza tra la voce che si appoggia sul proprio diaframma e di quella che può permettersi di restare indifesa e lasciarsi amplificare.
Recensendo “Are we there” su Pitchfork, Stephen Deusner scrive che le nuove canzoni hanno un “sapore live” ed è vero: ascoltate dal vivo sembra quasi di essere stati invitati alle prove in studio di quei pezzi, di sentirne una demo pressochè finita e pronta a finire su disco. Quando insieme alla band esegue invece i pezzi del precedente “Tramp”, la differenza col suono del disco è più marcata – forse “Give Out” suonerebbe così se l’avesse registrata ora, rallentata, spogliata di ogni orpello, senza più l’impronta (seppur impeccabilmente indie) di Aaron Dessner. “Serpents” mantiene l’energia delle chitarre e quei fill irresistibili di rullante ma è eseguita come un tributo a un pezzo speciale, la sua “one hit wonder” di due anni fa; But what happens when I have two? si chiede ora Sharon in “Every Time the Sun Comes Up” e prima di suonarlo ci ricorda che “tutto quello che racconto in questo pezzo è successo veramente”.
“Serpents” è già il passato per Sharon, di mezzo c’è un anno intenso in cui hanno preso forma le nuove canzoni (“l’unica cosa a cui posso paragonare questo periodo è a un parto”, ha raccontato pochi giorni fa intervistata da Lauren Laverne a Radio 6). Di certo ora che l’album è finalmente uscito e la critica (IFB compreso) ha reagito con grande entusiasmo, lei ha molto chiaro in testa quale dev’essere il suo suono: la voce prima di tutto, anzi le voci considerato l’unione costante con le armonie della fedele compagna di palco Heather Broderick. Attorno ad esse ci sono arrangiamenti abbozzati, trattenuti, pronti ad esplodere senza farlo mai, liberi soltanto di inseguire arzigogolati arpeggi di basso, riff incompleti di chitarra elettrica, crescendo di batteria che ripartono sempre da capo. La somma è qualcosa di molto simile ad una band, dove tutti sono perfettamente in sintonia col fragile, inquieto, ricchissimo mondo di Sharon Van Etten.
Forse tutta la sua inquietudine Sharon è riuscita davvero a incanarlarla nelle canzoni, perchè tra una e l’altra non mostra traccia di incertezza: quando scherza col pubblico, quando si lancia nei ringaziamenti lunghi e toccanti ai suoi compagni di band e all’ex batterista e ora nuovo manager Zeke Hutchins. Nei testi di “Are we there” ricorre più volte il desiderio di trovare se stessi. Quando sul palco spalanca la sua voce e la sua vita con il talento che ormai in molti le riconoscono, con la sicurezza umile di chi sa precisamente cosa sta facendo, sembra andarci davvero vicina.
Photo Credit: Bruce aka theholygrail, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons