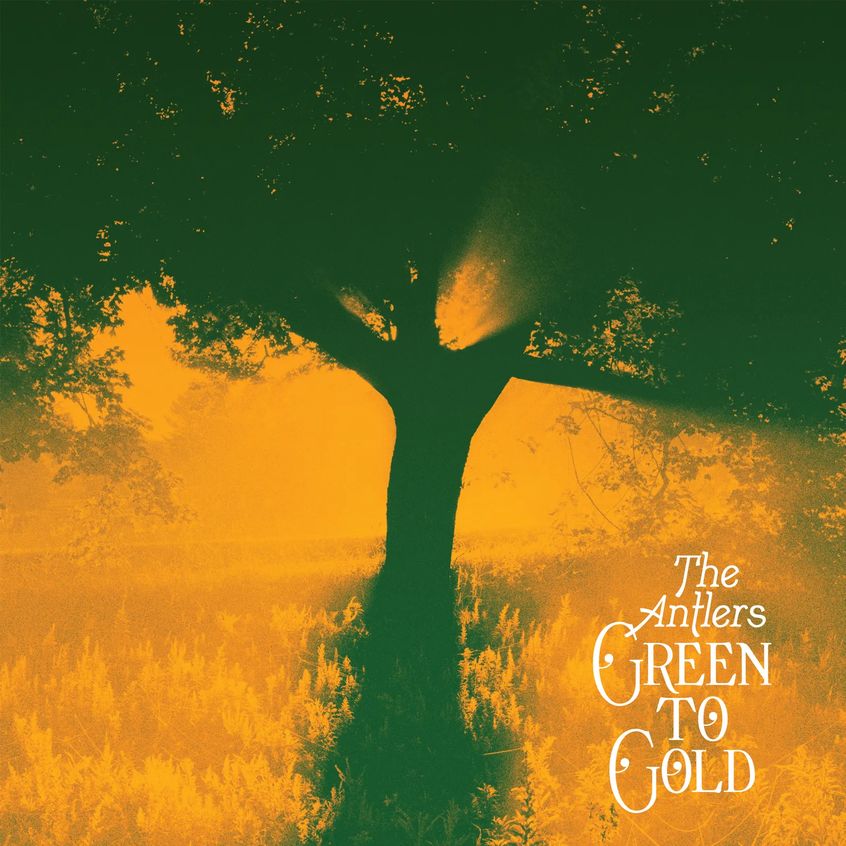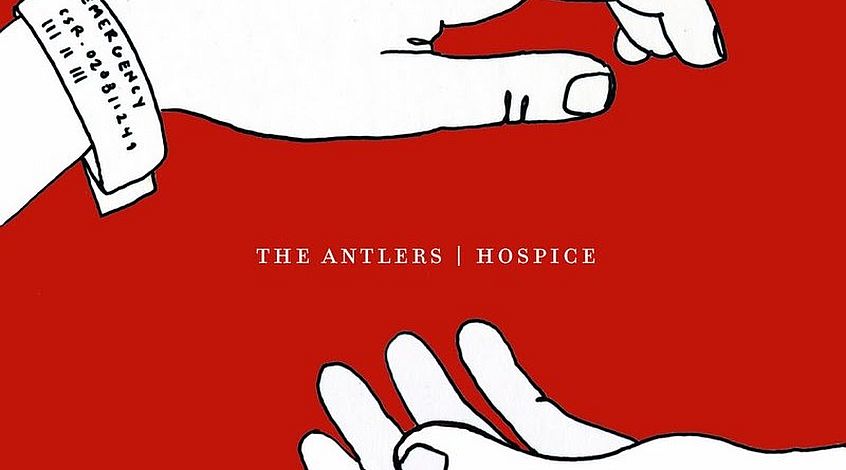Ascolto “Familiars” su un regionale Milano – Brescia. Di fianco a me c’è una ragazza cinese che ha preso alla lettera il vecchio slogan una telefonata ti allunga la vita. La sento nei brevi momenti di quiete tra un pezzo e l’altro. Scosto le cuffie e l’ascolto per alcuni minuti. Dal flusso costante del suo dialogo emerge con frequenza la parola “cognetti”, cosa che mi fa immaginare che lei possa essere una traduttrice del sempre amato Paolo Cognetti in missione per conto di una casa editrice indipendente della provincia del Sichuan.
Il treno, dicevo. E il nuovo disco degli Antlers. E una giovane donna cinese impegnata in una lunghissima telefonata con qualcuno che si trovava dall’altra parte del mondo. Ma andiamo con ordine.
La musica è una forma artistica che ha bisogno del tempo per esistere. Quando parlo di tempo, intendo un concetto molto pratico e concreto di tempo: i secondi, i minuti. Una canzone è fatta di tempo. Lo so, è una cosa semplice e, forse, ovvia, ma l’ho capita su questo treno, mentre ascolto il nuovo disco degli Antlers. Ogni canzone di “Familiars” si gonfia di tempo e si dilata: diventa chiaro fin dai sette minuti della seconda traccia, “Doppelgänger”, in cui echi e riverberi la fanno da padrone e sul finale si sente anche il fischio del vento. I risultati di questo gioco con il tempo non sono sempre soddisfacenti, spesso sfociano nella noia e nello sfinimento, creando canzoni dal tessuto sonoro slabbrato (la già citata “Doppelgänger”, “Intruders”, “Revisited”).
E la ragazza cinese che ripete “cognetti”? è grazie a lei che capisco la forza della ripetizione (una forza negativa, a volte). Ogni pezzo è costruito sulla ripetizione di moduli. Nonostante l’introduzione di variazioni, come i falsetti di Peter Silberman o la magnifica tromba di Darby Cicci, la ripetizione genera spesso l’effetto di spaesamento, come in Revisited, dove, a metà dei quasi otto minuti totali, la canzone si sfilaccia e perde la sua consistenza. Dov’è che funziona, allora, la formula cercata da Silberman in questo nuovo disco? Sicuramente in “Hotel”: si tratta del pezzo più solido, quattro minuti e quarantaquattro secondi in cui saturi di un suono caldo e avvolgente, la sezione ritmica non è soporifera come nel resto dell’album, sotto la voce di Silberman c’è un basso che vibra di vita, la tromba di Ciccy è il valore aggiunto e dialoga in modo superbo con la voce, riempie i vuoti e arriva sempre puntuale a sottolineare con vigore i momenti emozionali del pezzo. Oltre a Hotel, un giudizio positivo va speso anche per la prima traccia, Palace: è tutta un crescendo emotivo che si costruisce mattone su mattone con una lentezza che non infastidisce, aspettando che la scintilla scocchi dall’intreccio tra la voce e la chitarra di Silberman e la tromba di Ciccy. Nel resto dell’album manca totalmente la ricerca di una melodia, a favore della ripetizione e della dilatazione della forma canzone.
Gli Antlers hanno sfornato un disco fiacco e a tratti asettico, lontano dai fasti di “Hospice” (2009), disco struggente e doloroso. Escludendo “Palace” e “Hotel”, l’effetto della ripetizione non genera memoria, ma oblio.